
Feb 1, 2013 | The Blog

La Borsa a Mumbai
Stiamo attraversando a piedi la zona di Mumbai chiamata Fort e ora percorriamo la via Mumbai Samachar diretti alla stazione che un tempo si chiamava Victoria Terminus.
Questa è ora stata ribattezzata col nome dell’eroe locale Chhatrapati Shivaji, una specie di Garibaldi indiano che nella stessa città dà il nome all’aeroporto, al museo principale e alla stazione più monumentale dell’India, avendo rimpiazzato i nomi precedenti dati dagli inglesi.
Quasi di fronte all’edificio della Borsa – un tronco di cono tanto pretenzioso quanto sgraziato – c’è una banca. Entriamo per cambiare qualche Euro. Ci accolgono facce perplesse, nessuna delle quali parla inglese.
Le quarta volta che ripeto “money exchange”, qualcuno mi capisce e ci accompagna all’interno della sala, davanti alla scrivania di una tizia che non sta facendo niente. “Money exchange, please” scandisco.
La tizia mi guarda, sorride con aria imbarazzata e dice: “Sorry, we close at four thirty”.
Indico l’orologio sul muro dietro alla sua scrivania, che indica le 16:20. Lei lo guarda, poi mi ripete: “Sorry, we close at four thirty”.
Gli indiani non amano dire di no. Per cui ti dicono qualcosa di vago e tu devi leggere tra le righe.
Noi ora abbiamo capito e usciamo scuotendo la testa. E non sarà l’ultima volta, negli otto giorni d’India che ci restano.
***
Prendiamo un taxi concordando preventivamente un forfait per la mezza giornata. Prima ci facciamo portare al Sanjay Gandhi National Park, un enorme parco di 104 km quadrati all’interno della città e al cui interno si trova la zona archeologica delle Kanheri Caves, una serie di grotte che contengono colonne e statue scolpite nel basalto.
Al ritorno, chiediamo all’autista di portarci nel quartiere di Malad, al centro commerciale InOrbit, uno shopping mall di modello occidentale dove sono già stato in una precedente visita a Mumbai. L’autista rimane interdetto e dice: “Ma quello è un centro commerciale come li avete al vostro paese! Perché non andiamo al Saga? (un grande magazzino indiano dove sicuramente lui porta i clienti in cambio di una percentuale).
“No – gli ripetiamo con la cortese fermezza che abbiamo imparato in India quando la gente fa finta di non capire – vogliamo andare all’InOrbit e ci fermeremo due ore”. L’indiano non riesce a farsene una ragione e insiste: “Ma dopo andiamo al Saga, va bene?”.
“No, non abbiamo tempo. Andiamo solo all’InOrbit”. Il tono è definitivo e l’autista desiste.
Arrivati al centro commerciale, passiamo il solito controllo del metal detector e ci immergiamo in un’atmosfera che ci è familiare. Pavimenti puliti, scale mobili che funzionano, vetrine che puoi guardare senza essere travolto da uno stuolo di imbonitori, procacciatori, truffatori e straccioni. I prezzi sono esposti, i commessi gentili e con un inglese più che decente.
Come si fa a dire a un indiano – senza offenderlo gratuitamente – che vogliamo prenderci una pausa di due ore dalla sporcizia secolare, dal disordine imperante, dal traffico assurdo, dalla povertà più abbietta, dal rumore costante, dalla onnipresente puzza di urina e dalla disonestà totale di cui è intrisa la sua città?

Gen 27, 2013 | The Blog
 La sveglia suona alle 5:00 e ci scuote da un sonno profondo, aiutato anche dalla pillola di melatonina che prendiamo ogni sera da quando siamo arrivati in India cinque giorni fa. Ci muoviamo nella poco familiare stanza d’albergo come due zombie, rovistando nelle valigie ancora da disfare alla ricerca di indumenti caldi da indossare. Siamo a Nuova Delhi, dove in questi giorni si sono toccate le temperature più fredde da 40 anni.
La sveglia suona alle 5:00 e ci scuote da un sonno profondo, aiutato anche dalla pillola di melatonina che prendiamo ogni sera da quando siamo arrivati in India cinque giorni fa. Ci muoviamo nella poco familiare stanza d’albergo come due zombie, rovistando nelle valigie ancora da disfare alla ricerca di indumenti caldi da indossare. Siamo a Nuova Delhi, dove in questi giorni si sono toccate le temperature più fredde da 40 anni.
Durante la notte gela e, dall’alba fino a metà pomeriggio, il sole è nascosto da una fitta nebbia che grava sulla città. La temperatura non sale mai sopra i 6 – 7 gradi.
Alle 5:45 squilla il telefono e dalla reception ci avvisano che la nostra macchina è arrivata. Ci dovrà portare alla stazione di Hazrat NIzamuddin, nella parte sud di Delhi. Usciti dall’albergo il freddo è pungente. L’autista, un Sikh, è seduto al posto di guida della Tata Indigo avvolto in una coperta pied-de-poule che lo copre dal turbante ai fianchi.
Partiamo nell’oscurità più completa, interrotta a tratti da qualche lampione che ancora funziona e dai fuocherelli accesi sui marciapiedi da quelli che abitano in strada. Nella luce dei fari, Delhi sembra una città bombardata, con i crateri nell’asfalto e i marciapiedi divelti che la calca e il traffico delle ore di luce tendono a coprire. Ma ora, alle 6 del mattino, la combinazione di oscurità e nebbia fa apparire in modo spettrale nel fascio dei fari ogni dettaglio dello sfacelo di questa megalopoli.
La Tata si muove a velocità moderata per evitare di sfasciarsi in qualche buca e percorre il viale Sri Aurobindo in direzione nord. Poi gira a destra sulla Lodhi Road, che segna il confine meridionale della Delhi residenziale progettata da Edwin Lutyens negli anni ’20 e dove alloggiavano i funzionari del regno coloniale.
Alla fine della Lodhi Road, spunta dalla nebbia la rotonda dove sorge la Sabz Burj o Torre Verde. Nel XVI secolo, quando fu costruita, la sua cupola era rivestita di maioliche verdi. Restaurandola, la sovrintendenza ai monumenti della città ha usato maioliche blu per motivi che non ha mai spiegato a nessuno.
Ora la nostra auto si perde in un dedalo di vie buie nel quartiere di Nizamuddin. Ogni tanto, in qualche slargo, compare una chiazza di luce: sono i venditori ambulanti di vivande che illuminano i loro carretti con una fila di lampadine alimentate da un piccolo generatore a benzina. Qualche individuo avvolto in una coperta acquista qualcosa da mangiare, altri si arrampicano dove possono nell’autobus sgangherato che si è appena fermato.
Arriviamo alla stazione, che compare nella nebbia all’improvviso. In realtà, ne vediamo solo le luci di un bar a livello strada e una scalinata sudicia e ripida che porta all’interno. Tutto intorno all’ingresso e lungo le scale si accalca una folla vociante. C’è anche qualcuno dorme sul pavimento, mentre altri lo scavalcano portando fagotti e scatoloni di dimensioni improbabili. In un angolo vediamo uno degli onnipresenti metal detector di cui l’India è piena. Forse è rotto, forse i militari che lo fanno funzionare a quest’ora dormono.
Ora percorriamo una pensilina sopraelevata che permette di attraversare una dozzina circa di binari e di prendere la scalinata corrispondente al proprio treno. Ma sui cartelli luminosi, il nostro (il Taj Express delle 7:00 diretto ad Agra) non compare. Strano, sono le 6.20 e il treno si forma qui. Aspettiamo qualche minuto mentre la folla ci scorre a fianco e l’altoparlante non cessa di blaterare.
Finalmente riconosco in un annuncio un paio di parole conosciute. Ora il testo è ripetuto in inglese e non sono buone notizie. Il Taj Express ritarderà di 4 ore (così dicono ora). Il pensiero di farci almeno altre 4 ore in questo disastro di stazione è repellente. Torniamo in strada per decidere se e come arrivare ad Agra per visitare il Taj Mahal. Doveva essere un’escursione di una sola giornata ma le cose non stanno andando nel verso giusto.
I biglietti ferroviari che avevamo ottenuto con grandi sforzi (leggi qui) non servono più a niente, se non a darmi la scusa per dipingere questo squallido quadretto indiano.
Nella foto: il biglietto dell’andata con la pubblicità della “pillola del giorno dopo”.

Gen 1, 2013 | The Blog
 Chi come me credeva che il sito di Trenitalia fosse il miglior incentivo a scegliere un mezzo di trasporto diverso dal treno, si sbagliava.
Chi come me credeva che il sito di Trenitalia fosse il miglior incentivo a scegliere un mezzo di trasporto diverso dal treno, si sbagliava.
In previsione di un imminente viaggio in India, mi sono trovato a trafficare con il sito di Indian Railways (IRCTC) per prenotare e acquistare dei biglietti per una tratta interna.
Dire che il sito è “customer-unfriendly” è essere generosi. La perversa passione indiana per la burocrazia raggiunge qui livelli eccelsi, che fanno perfino impallidire la mentalità tipica da ferrovieri “product-oriented” di cui Trenitalia è intrisa.
Per motivi apparentemente legati alla lotta al terrorismo,la procedura di’acquisto online dei biglietti ferroviari indiani è particolarmente frustrante. (Nessuno però impedisce al terrorista di acquistare un biglietto brevi manu, magari regalando una manciata di rupie a un prestanome compiacente). Paradossalmente però, acquistare via Internet biglietti per i voli interni si è rivelato una passeggiata.
Il primo ostacolo per l’aspirante viaggiatore su rotaia è la registrazione come utente delle Indian Railways. Occorre dichiarare le proprie generalità e indirizzo, indicando anche il CAP e un telefono cellulare. Si riceveranno poi due password, una sul cellulare e una all’indirizzo e-mail. Peccato che siano accettati solo numeri di cellulare indiani e che il CAP previsto sia solo quello indiano e quindi a 6 cifre. A prima vista non si direbbe che ci sia un grande interesse ai viaggiatori stranieri.
Esistono però siti commerciali indiani come Cleartrip.com che ti promettono l’acquisto di biglietti “fast and easy”. Proviamoli.
Alle prime schermate si ha proprio l’impressione di essere capitati nel posto giusto. Tutto molto semplice e lineare. Ecco, già appare sullo schermo il treno desiderato con gli orari.
Ma appena si clicca sul pulsante per la verifica delle disponibilità e l’acquisto online cominciano le rogne.
Aver aperto un account su Cleartrip non bastava, ora bisogna anche aprirne uno sulle Indian Railways. Come non detto, siamo caduti dalla padella nella brace: il livello di complicazione è raddoppiato. E lo stesso vale per gli altri siti commerciali. Non c’è nessun modo di evitare la registrazione sul sito-fortezza di “Trenindia”.
Ma scopro poi un “workaround” suggerito dalle stesse ferrovie indiane per i graditi ospiti stranieri. Si può richiedere la password via mail (senza richiedere quella sul cellulare) e attendere che questa venga comunicata. Poi, forti della password mail e allegando la scansione del proprio passaporto, si può scrivere all’indirizzo dell’assistenza clienti delle ferrovie per farsi rilasciare anche la seconda password.
Voila. La complicazione è appena aumentata di un ulteriore 500%, la voglia di andare in treno è crollata ai minimi storici. Peccato, perché viaggiare in treno in India è un’esperienza da non perdere.
La soluzione che alla fine ho trovato si è rivelata forse un po’ “old economy” ma particolarmente comoda.
Ho scritto al concierge del primo albergo in cui arriveremo in India, il Sofitel di Mumbai, e gli ho esposto il problema. In qualche minuto, mi è arrivata la risposta che speravo di ricevere. “No problem, sir. We can handle that”. E’ sempre bello dialogare con degli umani. L’acquisto dei biglietti mi costerà forse 10 Euro in più ma chissà quante arrabbiature in meno.
Cento anni fa, il sahib europeo in abito coloniale e casco da esploratore avrebbe fatto la stessa cosa.

Dic 2, 2012 | The Blog
Engrish (o Chinglish) è quella forma di inglese nonsense utilizzato in Cina per rendere più trendy prodotti di largo consumo (sia nella pubblicità che nel nome stesso del prodotto), oppure quelle folli traduzioni che si trovano nei menu dei ristoranti o anche nei cartelli e negli avvisi al pubblico.
Ci sono blog e perfino libri interi dedicati all’Engrish e chi viaggi in Cina (o comunque in Estremo Oriente) per qualche giorno ne vedrà una quantità impressionante di esempi.
Ma a volte non occorre andare così lontano per vedere a quali forme di tortura è stata sottoposta la lingua di Shakespeare. In Italia, dove la conoscenza dell’inglese è ai livelli più bassi d’Europa, l’uso scellerato dell’inglese è abbastanza comune.
Traduttori improvvisati si lanciano in improbabili conversioni di testi italiani in inglese, con il risultato di creare testi difficilmente comprensibili sia agli anglofoni che agli italiani che provino a capirne il senso.
Basta leggere le istruzioni e le avvertenze nei mezzi di trasporto o cliccare sulla bandierina inglese nei siti Web per accedere alla versione “inglese” del sito. Vi troverete circondati da “falsi amici” e da costruzioni sintattiche tipicamente italiane trasportate con la forza in inglese.
L’inglese non ama la costruzione passiva, l’italiano ci sguazza. Alcuni verbi sono transitivi in inglese ma in italiano no (e viceversa), ma il traduttore non si ferma davanti a questi dettagli e ti costruisce dei capolavori che suonano male a tutti tranne che a lui/lei.
Tanta è le scelleratezza che nemmeno si pensa a far leggere la traduzione a un conoscente anglofono, just in case. Per carità, non se ne parla neppure. Chi è uscito dall’università italiana con una laurea in lingue non si abbassa a tale umiliazione. Il “pezzo di carta” sancisce l’infallibilità del portatore.
 Ma la disinvoltura con la quale si fa uso dell’inglese non si ferma qui. Giorni fa ho visto in un cantiere della futura Expo 2015 una di quelle toilette portatili che si utilizzano appunto in siti di lavoro. La marca apposta sui lati della casetta in plastica mi lasciava perplesso: Miss Cup.
Ma la disinvoltura con la quale si fa uso dell’inglese non si ferma qui. Giorni fa ho visto in un cantiere della futura Expo 2015 una di quelle toilette portatili che si utilizzano appunto in siti di lavoro. La marca apposta sui lati della casetta in plastica mi lasciava perplesso: Miss Cup.
La traduzione letterale non mi aiutava a capirne il senso e solo dopo aver pronunciato ad alta voce quello che leggevo ho capito il raffinato gioco di parole. Mis cap, ovvero Mi scappa.
Vorrei stringere la mano a chi ha avuto l’idea. Una trovata eccezionale per limitare l’interesse nel prodotto al territorio italiano. Chi potrebbe capire la battutona al di fuori della penisola? Forse i ticinesi.
L’azienda è brianzola e sul suo sito Web spiccano le foto di una serie di persone (dalla ragazza in tacchi alti all’operaio edile) che stanno per farsela addosso. Divertente, ma serve a vendere?
Se lavoro come responsabile acquisti, quali criteri mi guidano nella scelta di una toilette portatile? Il sito sbarazzino e il marchio ingleseggiante? Non credo.
La scelta del marchio sembra quasi un “inside joke” dei titolari dell’azienda. Ridono di meno i commerciali che devono presentarsi telefonicamente per prendere appuntamenti con i potenziali clienti. “Buongiorno, sono Evaristo Carugati della Miss Cup”. Che risate!
Ma c’è ancora di peggio. Anche qui non si tratta veramente di una questione linguistica. In un negozio di Belgrado che vende biancheria intima, spicca in vetrina un paio di mutandine con la scritta: Love is in the hair.
Sembra più un pun sul titolo della vecchia canzone “Love is in the air” di John Paul Young (1977) che un errore di spelling.
 Il risultato finale è comunque devastante.
Il risultato finale è comunque devastante.
Stavo percorrendo oggi la Kralija Petra (l’antica strada dedicata al Re Pietro nella città vecchia di Belgrado) e, passando davanti al negozio, la sguardo mi è caduto sulla frase.
Se la foto risulta mossa è perché ridevo troppo…

Nov 30, 2012 | The Blog

Da qualche settimana ha aperto nel centro di Belgrado un ristorante chiamato Vapiano. Si mangiano solo pizza o pasta e la formula prevede che queste si ordinino al banco e che vengano preparate davanti ai vostri occhi.
Se avete scelto una pasta (la vostra scelta interessa sia la salsa che il tipo di spaghetti, tagliatelle o penne), vi viene chiesto se ci volete aglio, peperoncino o altri ingredienti e il cuoco o la cuoca li aggiungono in una padella tipo wok cinese in cui essi vengono rapidamente cucinati. Poi arriva la pasta, che nel frattempo è stata scolata, e il tutto viene saltato in padella e servito fumante. A quel punto, lo mettete sul vassoio e andate a cercare un posto dove sedervi.
Il ristorante occupa i maestosi locali di un vecchio caffè di stile viennese che era un monumento della Belgrado di un tempo, sopravvissuto fino al 2012 e poi chiuso per fare posto a questo strano fast food all’italiana, che però italiano non è.
La catena Vapiano è tedesca e il concetto è moderatamente rivoluzionario.
Ma ci voleva un non-italiano per creare qualcosa di divertente e iconoclastico che si fondasse sul mangiare italiano! Il rapporto dell’italiota medio con i suoi feticci alimentari è dichiaratamente morboso. La pasta è la mamma, il sugo al pomodoro il papà e sappiamo che in Italia con gli affetti familiari/alimentari non si scherza. Una pasta scotta è stata la circostanza scatenante di innumerevoli divorzi, la carbonara come la faceva mamma non c’è moglie che la sappia fare, la pubblicità televisiva della pasta e dei sughi in Italia rasenta l’erotismo orale.
Nessun imprenditore italiano avrebbe potuto lanciare una catena di fast food dedicati alle icone italiche di pasta e pizza, sarebbe stato linciato in piazza, l’avrebbero condannato a livello bipartisan tutte le forze politiche, i preti e gli anarchici, Beppe Grillo e i sindacati. La gente avrebbe fatto sit-in di protesta: Aridatece la pasta de mamma nostra.
Un Paese incagliato in via permanente nella recessione e con le finestre che affacciano a picco sull’irrilevanza più completa a livello internazionale avrebbe ritrovato il suo orgoglio nel condannare e combattere coralmente l’eresia alimentare di un italico rinnegato che avesse osato profanare quel poco che c’è rimasto. Toglieteci tutto tranne la sacralità del mangiare nostrano e il latte della Lola!
E quindi l’ha fatto un imprenditore tedesco. Il ristorante è sempre pieno e frequentato da una clientela molto variegata, dagli uomini d’affari ai giovani. Ai soffitti altissimi e ai vecchi lampadari in cristallo di un tempo sono abbinati tavoli in legno massello e sgabelloni in pelle, i muri sono decorati con enormi lavagne sulle quali appaiono divertenti slogan e disegni realizzati con gessetti colorati, qua e là troneggiano delle piante di ulivo bonsai che simboleggiano il cuore della cucina mediterranea.
Nel centro di una lavagna campeggiano un ritratto a gesso di Don Vito Corleone, il celeberrimo Padrino, e la scritta PASTA NOSTRA.
Tra talebani alimentari e uomini d’onore, chi mai avrebbe osato tanto in Italia?


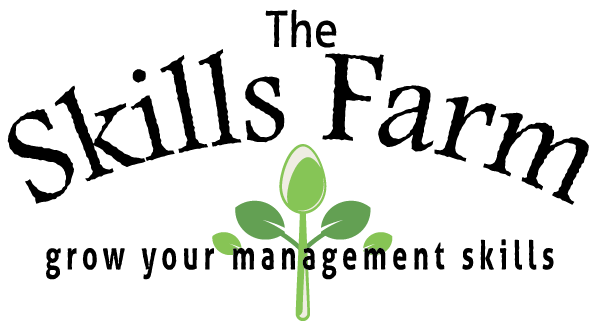






 Ma la disinvoltura con la quale si fa uso dell’inglese non si ferma qui. Giorni fa ho visto in un cantiere della futura Expo 2015 una di quelle toilette portatili che si utilizzano appunto in siti di lavoro. La marca apposta sui lati della casetta in plastica mi lasciava perplesso: Miss Cup.
Ma la disinvoltura con la quale si fa uso dell’inglese non si ferma qui. Giorni fa ho visto in un cantiere della futura Expo 2015 una di quelle toilette portatili che si utilizzano appunto in siti di lavoro. La marca apposta sui lati della casetta in plastica mi lasciava perplesso: Miss Cup. Il risultato finale è comunque devastante.
Il risultato finale è comunque devastante.
