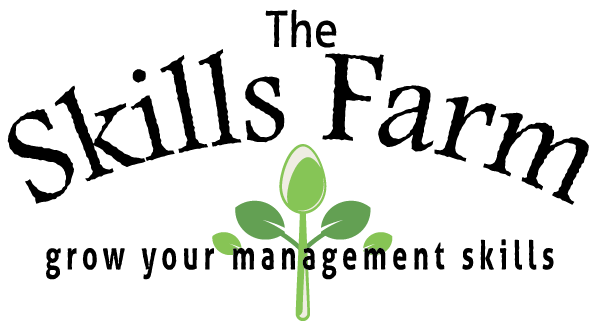Ott 7, 2012 | The Blog
Segue da “Vita di bordo”, Maggio 2012
Dopo un intervallo di qualche mese, riparte la saga della vecchia (e ora demolita) TSS Delos, ovvero come l’italiano andava in crociera 40 anni fa.

Un giorno, mentre percorriamo lo stretto canale di Corinto (solo 25 metri tra i suoi ripidi bordi) l’impianto di raffreddamento della nave pesca qualche detrito dall’acqua sporca del canale, forse l’immancabile sacchetto di plastica, che percorre le tubature fino a intasarne una. In pochi minuti salta una conduttura, non so se dal lato caldaie (cosa più probabile) o da quello delle tre vetuste turbine Rateau che spingono la Delos dal 1949, quando ancora si chiamava Azemmour e viaggiava tra la Francia e il Maghreb.
La nave, che come sempre percorre i 6 km del canale trainata da un rimorchiatore, ora entra ancora una volta nelle placide acque del Golfo Saronico, ma questa volta ferma le macchine dopo aver calato le ancore davanti al villaggio di Palaio Kalamaki. Il problema è serio e occorre far arrivare dei pezzi di ricambio da Atene. Dalla nave vediamo la statale che porta alla capitale, lontana 80 km in direzione Sud-Est, ma ci vorranno parecchie ore prima che i ricambi siano a bordo e vengano montati. Intanto le macchine devono raffreddarsi per consentire le riparazioni.
Sulla nave fa un gran caldo, visto che anche l’aria condizionata non funziona, e la gente comincia a protestare.
Teniamo un rapido consiglio di guerra nell’ufficio del Cruise Director e decidiamo di regalare ai passeggeri un’escursione a Epidauro, nel Peloponneso, che dista meno di un’ora da Palaio Kalamaki. Per radio vengono chiamati i pullman del nostro partner greco che cura le escursioni e dopo circa due ore li vediamo arrivare sul litorale. Intanto, l’unico sistema per portare a terra i passeggeri è usare le scialuppe di salvataggio.
 La gente è divertita e si gode lo spettacolo mentre l’equipaggio prova a calare le scialuppe. Molte delle gru si inceppano a causa della cattiva manutenzione, ma il pensiero che questo avrebbe potuto verificarsi in un momento di emergenza non turba l’allegria generale. Fioccano senza sosta le fotografie dei passeggeri che sorridono indossando i loro giubbotti di salvataggio e l’umore si risolleva subito.
La gente è divertita e si gode lo spettacolo mentre l’equipaggio prova a calare le scialuppe. Molte delle gru si inceppano a causa della cattiva manutenzione, ma il pensiero che questo avrebbe potuto verificarsi in un momento di emergenza non turba l’allegria generale. Fioccano senza sosta le fotografie dei passeggeri che sorridono indossando i loro giubbotti di salvataggio e l’umore si risolleva subito.
Mentre le gente si arrampica sulle rovine di Epidauro, a bordo facciamo due conti. A sera avremo perso un’intera giornata di navigazione e occorre recuperarla in qualche modo. Si propone di saltare Istanbul, il punto più lontano dell’itinerario, ma ci sarà di sicuro una rivolta a bordo. La città turca a cavallo tra Europa e Asia è il sogno di tutti e nessuno vuole rinunciarvi.
La nostra strada del ritorno prevede soste a Corfù, Brindisi, Dubrovnik e Ancona. La crociera si conclude di norma nel capoluogo marchigiano con la discesa di tutti i passeggeri: gli italiani diretti a casa e gli inglesi diretti a Rimini, dove un nuovissimo Lockheed TriStar L-1011 della Court Line li riporterà in patria.
Si decide di far finire la crociera a Dubrovnik, dirottando l’aereo inglese sulla Jugoslavia per portare lì il nuovo carico di passeggeri e riportare indietro quelli sbarcati dalla Delos. Per gli italiani (di cui molti non gradiscono l’idea di prendere un aereo per tornare a casa) si mobilitano un paio di aerei dell’Itavia, che voleranno da Ancona a Dubrovnik e viceversa.
 Gli aerei Itavia sono i turboelica Herald, molto simili al più popolare Fokker F-27, ma comunque sgraditi a gran parte dei passeggeri perché piccoli e spinti da eliche. “Ero venuto in crociera per non dover prendere l’aereo ed eccomi qua a doverlo prendere per forza” è un commento frequente che serpeggia tra gli italiani. Qualcuno deciderà poi di farsi la notte in traghetto piuttosto che assoggettarsi a un’ora di aeroplano, ma con le fobie c’è poco da fare.
Gli aerei Itavia sono i turboelica Herald, molto simili al più popolare Fokker F-27, ma comunque sgraditi a gran parte dei passeggeri perché piccoli e spinti da eliche. “Ero venuto in crociera per non dover prendere l’aereo ed eccomi qua a doverlo prendere per forza” è un commento frequente che serpeggia tra gli italiani. Qualcuno deciderà poi di farsi la notte in traghetto piuttosto che assoggettarsi a un’ora di aeroplano, ma con le fobie c’è poco da fare.
La Delos riparte a tarda sera, quando i lavori in sala macchine sono finiti. A bordo, una volta deciso il cambio di programma, sono quasi tutti soddisfatti. Gli inglesi, rientrati nella routine di bordo e già parecchio avanti nel consumo di birre, in definitiva non si accorgeranno quasi della modifica dell’itinerario, gli italiani richiederanno invece un certo lavoro di persuasione.
L’argomentazione che “un guasto può sempre succedere, l’importante è aver trovato una soluzione” non soddisfa tutti. Si fanno le 3 del mattino a discutere, ma alcuni irriducibili non cedono. Mi sfugge il tipo di soluzione ideale che cercano. Una giornata è andata perduta e non ritornerà più. La crociera successiva deve partire puntualmente, ci sono altre 400 persone che aspettano di imbarcarsi a giorni. Quali margini di manovra ci sono?
Comincio a imparare che c’è gente che anche in ferie non “stacca” mai. E’ una costante che ha puntualmente trovato conferma per i quaranta anni successivi.
Il passeggero italico, uscito dalla sua “comfort zone” (costituita dal tragitto casa-ufficio, dalla scampagnata fuori porta e dalla domenica allo stadio) diventa timido e si sente inadeguato con la sua inesistente conoscenza delle lingue e del mondo oltreconfine. Se si sposta lontano, predilige il villaggio turistico “all’italiana”, la pasta al dente e il caffè ristretto. Se tutto questo non è disponibile o succede un imprevisto, subentra in lui (o lei) la sindrome regressiva che li riporta allo stadio di bambini piagnucolosi e rigidamente ancorati alle loro abitudini.
Al primo problema logistico, il gruppo degli italiani si è trasformato in assemblea del condominio. Le frasi cominciano tutte con “io” e tradizionalmente si sovrappongono a quelle di chi sta già parlando. Il risultato è un frastuono inconcludente, che ha però l’effetto di lasciar sfogare ai vacanzieri le loro paure e frustrazioni.
Questa volta, mi arrendo prima io. Mi bevo un altro ouzo e me ne vado in branda, lasciandoli al loro mugugno. Mentre mi allontano, mi segue una minaccia “Scriveremo alla Navitur…”
E qualcuno, infatti, scriverà. Ma in quegli anni cupi per il consumatore, il massimo che ci si poteva attendere da una lettera di reclamo era una lettera di risposta piena di formule generiche e tanta aria fritta.
Mi rigiro nella mia cuccetta e, come ormai è tradizione, le vibrazioni ritmiche dell’asse dell’elica mi fanno addormentare nell’arco di un minuto o due.
Nota: le foto sono tratte da un raro filmino promozionale della Clarksons Cruises nei primi anni ’70.

Set 30, 2012 | The Blog
 Belgrado, capitale della Serbia. Città contesa tra gli Asburgo e l’impero ottomano. Rasa al suolo 44 volte mentre gli eserciti opposti si massacravano per conquistarla.
Belgrado, capitale della Serbia. Città contesa tra gli Asburgo e l’impero ottomano. Rasa al suolo 44 volte mentre gli eserciti opposti si massacravano per conquistarla.
Oggi, Belgrado (che vuol dire città bianca) è meno bianca e smagliante di una volta. A parte alcuni edifici di grande valore storico e artistico, la città predilige i toni del grigio. Il grigio dell’abbandono e dell’incuria.
Un vero peccato. In Belgrado c’è il potenziale di una città da visitare a ogni costo: un’atmosfera da Vienna e una collocazione geografica eccezionale: la confluenza del fiume Sava nel Danubio.
A Belgrado, la manutenzione degli immobili non è una priorità. L’economia è in crisi, il governo è così incapace e chiacchierato da far scuotere la testa ai governanti italiani. Che altro dire? Il risultato è che la gente ha pochi soldi in tasca e all’assemblea del condominio il problema numero uno è pagare il riscaldamento (qui il termometro d’inverno picchia sotto ai meno venti) e la manutenzione della facciata, delle scale e degli ascensori è rimandata ad anni migliori.
Morale: per trovare un ascensore che non sia guasto, vandalizzato, malmesso, sporco e osceno ci vuole una certa pazienza. Non solo, se alla fine lo trovate, domani sarà rotto (pokvaren) e lo rimarrà per giorni o mesi. E questo nel Paese che ha dato i natali a Nikola Tesla, genio dell’elettromagnetismo, nato in Serbia e naturalizzato americano nel 1891.
Ma c’è poco da rallegrarsi, almeno per noi italiani.
Nel Paese che ha dato i natali a Galileo Ferraris (che per combinazione fu un rivale di Tesla) e ad altri scienziati ed inventori nel campo elettrico, provate a trovare una macchinetta che funzioni quando volete stampigliare un biglietto ferroviario. Tre su quattro non funzionano. Alcune sono nastrate e chiaramente inattive, altre semplicemente rotte. Provate ad arrivare in stazione tre minuti prima della partenza e a cercarne una che funzioni.
Ciò nonostante, una volta in treno, si susseguono gli annunci registrati che informano i viaggiatori delle gravi sanzioni a carico di chi viaggi con un biglietto non valido.
Che cosa ci può essere di così complicato (o fragile) in uno stupido congegno elettromeccanico come una macchinetta obliteratrice di biglietti. Credo che la complessità di un cavatappi sia maggiore.
Eppure, la moria di macchinette imperversa. L’Italia high-tech, che vanta Freccerosse e treni TAV a bizzeffe, non riesce a convalidarti il biglietto prima che tu schizzi a Roma a 300 kmh.
E anche la modesta rete metropolitana ha poco da ridere. Trovate una vettura del metro milanese dove l’aria condizionata funzioni. Quelle nuove vi offrono qualche chance in più. Quelle meno nuove, nonostante i mastodontici impianti di condizionamento retrofittati (al costo di perdere cinque o sei posti passeggeri), hanno temperature tropicali.
Coraggio, malinconici ascensori serbi, non siete soli.

Ago 25, 2012 | The Blog

East Main, New Iberia
Uno dei miei autori preferiti è James Lee Burke, che ha ambientato gran parte dei suoi libri in Louisiana, nella cittadina di New Iberia, che si trova a circa due ore a Nord-Ovest di New Orleans. L’abitato di New Iberia segue il corso tortuoso del Bayou Teche, un fiume che qualche migliaio di anni fa era il ramo principale del Mississippi e che ora è un placido canale di acqua marrone-verdastra che sfocia nel Golfo del Messico a Ovest di New Orleans e dell’attuale foce del Mississippi.
I libri di Burke descrivono questa placida cittadina dalla storia tormentata di due secoli e sono popolati da personaggi altrettanto complessi e prigionieri del passato. Le vicende trattano di crimine e corruzione dei giorni nostri, ma affondano le loro radici indietro nel tempo e si ricollegano a eventi come lo schiavismo, la guerra di secessione, la segregazione razziale e, in tempi più recenti, alle infiltrazioni della criminalità organizzata.
Leggendo la prosa aulica e fortemente evocativa di Burke, sembra di respirare l’aria calda e umida di New Iberia, si intravedono le nuvole scure che si raccolgono sul vicino Golfo del Messico per scaricare fulmini e piogge torrenziali. Ovunque nelle sue pagine sembra di cogliere anche gli odori tipici di questo clima subtropicale, effluvi forti come la flora lussureggiante di questa terra e l’acqua stagnante delle paludi sanno produrre.
Dopo aver letto oltre dieci dei suoi libri ambientati a New Iberia, ho finalmente avuto occasione di visitare la cittadina. Proveniente da Houston e diretto a New Orleans, ho lasciato la Interstate 10 a Lafayette e ho preso la statale 90 verso sud. In breve entravo nella New Iberia Parish. Quella che nel resto degli USA è una contea, in Louisiana prende il nome di “parrocchia”, per via delle suddivisioni amministrative coloniali introdotte da spagnoli e francesi in tempi anteriori alla cessione della Louisiana da parte di Napoleone (1803).

Bayou Teche
Si trattò, per inciso, di uno dei più colossali affari immobiliari della storia. La Louisiana oggetto della cessione agli USA comprendeva il territorio di 15 degli attuali stati americani, per un totale di oltre due milioni di chilometri quadrati e si estendeva dal Golfo del Messico al Canada. A un costo di soli 15 milioni di dollari, gli Stati Uniti di allora raddoppiavano di fatto le loro dimensioni da un giorno all’altro.
In dollari attuali, l’enorme territorio così acquisito fu pagato poco più di $1 per ettaro.
Il centro di New Iberia è fatto di edifici storici ben tenuti che ricordano da vicino l’architettura del Quartiere Francese di New Orleans, con i loro due piani e i balconi in ferro battuto. Il sole è caldo e l’aria è umida. Siamo ai primi di Gennaio e ci sono 24 gradi.
Parcheggio l’auto sulla East Main, la via principale, scatto qualche foto e mi avvicino a piedi al Bayou Teche. A destra, verso valle, vedo il ponte mobile sul Bayou, che figura spesso nella trama dei romanzi di Burke. Sull’altra sponda del corso d’acqua corre la Front Street con le sue case immerse nel verde.
La cittadina è silenziosa, il traffico moderato e a tratti inesistente. Ne assorbo i colori e gli odori prima di rimettermi alla guida verso New Orleans. Da oggi in poi, l’ambientazione delle storie di James Lee Burke mi sarà ancora più familiare e la sua prosa, già ricca di suggestioni sensoriali, mi riporterà subito alla mente questo angolo poco noto della Louisiana che gli fornisce ispirazione e scenari da venticinque anni.

Evangeline Theater

Giu 5, 2012 | The Blog

Nike e altri giganti del suo calibro non rinunciano all’uso dell’inglese nelle loro tagline anche in mercati non anglofoni (per una serie di ottimi motivi nessuno tradurrebbe “Just do it” con “Fallo!” per il mercato italiano). Opel va addirittura oltre utilizzando il tedesco con “Wir leben Autos” pur sapendo che pochi in Italia o in altri Paesi ne capiscono il significato. Ma all’uso della lingua tedesca si associano serietà e precisione e, in ogni caso, qui c’è un’immagine già solida di suo.
La lingua locale rappresenta ormai un paletto e una limitazione all’immagine globale di certi marchi. McDonald’s si identifica dovunque con “I’m lovin’ it”, Nokia con “Connecting people”, mentre invece per anni Gillette ha tradotto il suo slogan globale “The Best a Man Can Get” (che fa anche rima con il marchio) con un banale “Il Meglio di un Uomo”, che non solo non fa rima ma anche traduce male l’originale, immagino però con la virtuosa intenzione di meglio comunicare con il consumatore italiano. (Se tuttavia un rasoio o, per estensione, la pelle liscia sono il meglio di un uomo, il problema è piuttosto serio).
Oggi è diventato pressoché obbligatorio che lo slogan sia espresso in inglese se si vuole proiettare l’immagine di una ditta di successo, anche se questa non ha progetti di internazionalizzazione o è solo la tabaccheria all’angolo.
Anche il negozio tradizionale rifà l’insegna e ci sbatte un qualche nome inglese. Perché i tempi cambiano…
Un ottico a Milano, per non cedere del tutto all’anglofilia, ha installato a tutto campo l’insegna Occhial House, uno strano ibrido e un monumento al pressappochismo nazionale. Casa dell’Occhiale, che magari era stato per due generazioni il nome originale dell’esercizio, oggi sa troppo di antico, puzza di tempi pre-Internet come la parola emporio.
Ciò nonostante, nell’Italietta che ama vedersi proiettata internazionalmente, permangono delle idiozie provinciali che evidentemente nessuno ha il coraggio di spazzare via.
Chi non ricorda i dentifrici Colgate e Close-up pronunciati all’italiana per non turbare i sonni del consumatore locale? Close-up non si trova più, ma Colgate ancora va forte, sempre pronunciato Col-ga-te. Coraggiosi pionieri sono invece stati Brooklyn, la gomma del ponte, e Whirlpool, quella degli elettrodomestici, per aver scosso il letargo italico con nomi ben più difficili da pronunciare. Ma non è successo niente, il sole ha continuato a sorgere e le vendite non sono crollate. Ciò avrebbe gettato nel panico i vertici commerciali delle aziende, spingendoli a ribattezzare i marchi Broccolino e Virpol.
(Il caso della Sega, gigante dei videogiochi che da sempre è chiamata Siga, sarà forse da esaminare a parte.)
L’altra sera, guardando la TV, mi sono sbellicato dal ridere. Sul canale Fox Crime (pronunciato all’inglese, eccetto per la “R” arrotata all’italiana) è apparsa la scritta: TOUCH (pronunciato tacc) sponsored by (sponserd bai) : CLEAR (dove invece il dittongo EA è pronunciato a bocca aperta come nel nome Lea).
La Signora Cesira, icona della massaia italica di bassa scolarità, si vanta di fare multitasking, fa shopping al factory outlet e carica la spesa nella sua “C-Crosser” alimentata a Diesel, ma evidentemente per i dirigenti marketing di Unilever Italia non è ancora pronta a sentir chiamare Cliar il suo sciampo antiforfora e per quelli della Johnson & Johnson gli assorbenti si vendono meglio se li pronunci Ca-re-fré-e.
Per un Paese in cui la percentuale degli abitanti in grado di tenere una conversazione, pur elementare, in inglese non tocca il 30% (contro il 50% della Slovenia), la strada da fare è ancora lunga e queste incrostazioni di provincialismo idiota non aiutano.

Mag 14, 2012 | The Blog
 Ho appena passato un’ora intera a scorrere quell’interminabile elenco di nomi di persone che LinkedIn mi segnala come possibili conoscenze.
Ho appena passato un’ora intera a scorrere quell’interminabile elenco di nomi di persone che LinkedIn mi segnala come possibili conoscenze.
Molti nomi sono familiari, ma a volte si tratta solo di casi di omonimia o di persone che non ho mai realmente conosciuto ma soltanto sentito nominare. Altre facce mi sono note e così anche i nomi che le accompagnano, ma confesso che devo andare a leggerne la storia per capire quando le nostre strade si siano mai incrociate.
Ad altre possibili conoscenze, invece, rinuncio a priori per colpa della foto. Sì, avete letto bene: la foto.
Ecco i criteri in base ai quali la foto costituisce per me una valida ragione per non allacciare (o riallacciare) rapporti con qualcuno.
- La foto manca. Diciamoci la verità, se sei su LinkedIn con nome e cognome e tanto di storia professionale (e magari anche gli studi che hai fatto), che senso ha non mettere la foto?
Siete troppo belli, troppo brutti, avete troppo poco tempo a disposizione? Andiamo, chi non ha almeno una sua foto digitale? Ma va bene, non abuserò del vostro tempo scrivendovi: ciao, ti ricordi di me?
- La foto ritrae di profilo una persona che guarda in aria o si studia le scarpe. Niente contatto visivo, anzi la paura di essere riconosciuti . Li ferma uno per strada: “Ma tu sei Giuseppe, il celebre serial killer! Ti ho visto su LinkedIn!” Io gente così non ne conosco, per cui passiamo pure avanti.
- La persona nella foto si tocca il mento dandosi un’aria pensierosa, riflessiva. Ti sta dicendo: io sono uno che pensa, uno che usa molto la testa. (Beato te, io invece sono un cretino con un IQ che arriva alle due cifre solo nelle giornate calde e quindi non sarò mai alla tua altezza.) Avanti un altro.
- La persona ha il viso inclinato e rivolto da un’altra parte, ma ti fissa con occhio penetrante. Ti sta dicendo: io sono un tipo magnetico e carismatico. Volgi a me gli occhi e seguimi perché sarò il tuo leader. Ecco, grazie, io però sto benissimo qui. Vai pure avanti tu a fare il pifferaio magico.
- La persona si è registrata su LinkedIn mettendo prima il cognome e poi il nome. Ora, che interesse posso avere ad allacciare rapporti con Pignattoni Gian Ercole o Linciagatti Ersilia? Chiamatemi individualista, ma io ci tengo al mio nome ed è quello con cui mi chiamano gli amici. Ecco perché lo metto sempre per primo. Il cognome è la stirpe, il nome sono io.
- La persona non si vede perché troppo lontana dall’obiettivo. Nel mio elenco di possibili contatti c’è perfino un tale in piedi in una spider americana, una Ford Mustang rossa, ma si riconosce solo il celebre cavallino sulla griglia del radiatore. Il viso del pilota è solo un punto. Ti sta dicendo: io ho guidato una Mustang. Siccome non mi pare il caso di collegarmi con lui su LinkedIn solo per dirgli “chissenefrega”, credo che ne farò a meno. Anche io ho guidato una Mustang e un giorno ho perfino incontrato il papa in fila al McDonald’s. Questo mi rende speciale?
Un momento, ecco qui una faccia conosciuta! Il nome corrisponde e la ricordo perfettamente. E’ stata una mia collega oltre dieci anni fa e non ci vediamo da altrettanti anni. Le mando subito una richiesta di contatto e mi farà piacere sentirmi raccontare come le va la vita.
Che sollievo, alla fine non è stata un’ora buttata.

 La gente è divertita e si gode lo spettacolo mentre l’equipaggio prova a calare le scialuppe. Molte delle gru si inceppano a causa della cattiva manutenzione, ma il pensiero che questo avrebbe potuto verificarsi in un momento di emergenza non turba l’allegria generale. Fioccano senza sosta le fotografie dei passeggeri che sorridono indossando i loro giubbotti di salvataggio e l’umore si risolleva subito.
La gente è divertita e si gode lo spettacolo mentre l’equipaggio prova a calare le scialuppe. Molte delle gru si inceppano a causa della cattiva manutenzione, ma il pensiero che questo avrebbe potuto verificarsi in un momento di emergenza non turba l’allegria generale. Fioccano senza sosta le fotografie dei passeggeri che sorridono indossando i loro giubbotti di salvataggio e l’umore si risolleva subito. Gli aerei Itavia sono i turboelica Herald, molto simili al più popolare Fokker F-27, ma comunque sgraditi a gran parte dei passeggeri perché piccoli e spinti da eliche. “Ero venuto in crociera per non dover prendere l’aereo ed eccomi qua a doverlo prendere per forza” è un commento frequente che serpeggia tra gli italiani. Qualcuno deciderà poi di farsi la notte in traghetto piuttosto che assoggettarsi a un’ora di aeroplano, ma con le fobie c’è poco da fare.
Gli aerei Itavia sono i turboelica Herald, molto simili al più popolare Fokker F-27, ma comunque sgraditi a gran parte dei passeggeri perché piccoli e spinti da eliche. “Ero venuto in crociera per non dover prendere l’aereo ed eccomi qua a doverlo prendere per forza” è un commento frequente che serpeggia tra gli italiani. Qualcuno deciderà poi di farsi la notte in traghetto piuttosto che assoggettarsi a un’ora di aeroplano, ma con le fobie c’è poco da fare.