
Dic 25, 2009 | The Blog
 Nonostante le sue dimensioni contenute, il Pianeta Palla esercita una strana attrazione gravitazionale nei confronti del Business English più gergale. Sicuramente lo sport è una grande fonte di analogie, con una miriade di metafore condivise e il cui significato è immediatamente chiaro all’interlocutore, dato che si tratta in maniera statisticamente preponderante di individuo maschio e frequentatore degli stadi. Sfortunatamente, quando noi abbiamo a che fare con degli Americani, le loro espressioni più colorite derivano da due sport che da noi sono poco diffusi: baseball e American football, il che ci pone in una situazione di discreto svantaggio nel cogliere al volo il significato di certe similitudini.
Nonostante le sue dimensioni contenute, il Pianeta Palla esercita una strana attrazione gravitazionale nei confronti del Business English più gergale. Sicuramente lo sport è una grande fonte di analogie, con una miriade di metafore condivise e il cui significato è immediatamente chiaro all’interlocutore, dato che si tratta in maniera statisticamente preponderante di individuo maschio e frequentatore degli stadi. Sfortunatamente, quando noi abbiamo a che fare con degli Americani, le loro espressioni più colorite derivano da due sport che da noi sono poco diffusi: baseball e American football, il che ci pone in una situazione di discreto svantaggio nel cogliere al volo il significato di certe similitudini.
Mi riferisco a frasi del tipo: “He dropped the ball”, “He picked up that ball and ran with it”, “He threw me a curve ball” o ancora più misteriosamente (data l’assenza materiale della palla) “It came out of left field”.
La diffusa espressione “playing hardball” nasce nel mondo del baseball, in contrapposizione alla variante del gioco nota come “softball” e che fa uso di una palla appena più morbida. Il suo significato è chiaramente “fare sul serio” o “giocare duro”.
Ma non basta, gli sport da rotolamento non si fermano qui. “Standing behind the 8-ball” viene infatti dal biliardo e denota una situazione di estremo svantaggio.
L’espressione tanto criptica quanto diffusa “to play ball” non è tuttavia attribuibile a qualsiasi sport basato su una palla. Essa deriva infatti dall’esortazione Play ball! che tradizionalmente segna l’avvio delle sole partite di baseball.
“Touching base”, anch’essa un’espressione mutuata dal baseball, appartiene a quelle misteriose metafore sportive in cui la palla non compare nemmeno. L’altra espressione “Three strikes, you’re out” assume oggi sfumature che trascendono il suo significato originario mutuato dal baseball: al terzo “strike”, che per semplicità chiameremo palla mancata, il battitore è fuori e viene sostituito da un altro.
La frase “alla terza che mi combini sei fuori” oggi non identifica soltanto l’individuo che, al terzo grave errore, farà bene a cercarsi un altro lavoro. A seguito di recenti leggi promulgate in più stati USA, chi si renda ripetutamente responsabile di gravi crimini (ecco spiegati i 3 strike) viene condannato d’ufficio all’ergastolo o a pene detentive molto lunghe. Per ora, tuttavia, i reati commessi dai “colletti bianchi” non rientrano nel campo di applicazione di queste leggi.
Ma torniamo alla superficie misteriosa del Pianeta Palla. Chi non si è mai grattato il capo sentendo un Americano pronunciare l’espressione: “this is a ball-park figure” o “gimme a ball-park estimate”?
Qui siamo sempre nel magico regno del baseball, che (insieme a God, Country, Mom and Apple pie) è uno dei valori fondamentali della società USA. L’espressione si può tradurre con “stima approssimata” o con l’avverbio “spannometricamente”, che appartiene al nostro striminzito patrimonio di gergo aziendale.
L’origine dell’espressione altro non è che il calcolo “a occhio” del numero di spettatori presenti in uno stadio di baseball.
Lo sparuto contingente di frasi pallocentriche di derivazione anglo-australiana è capeggiato da “it’s (just) not cricket” (che significa “non è regolare”, “è inaccettabile”), con un ovvio riferimento a quel misterioso e soporifero gioco inventato dagli Inglesi e al quale essi vengono sconfitti con disarmante regolarità dai Pakistani.
But this is a whole new ball-game…

Dic 9, 2009 | The Blog

Giornata deludente oggi a Kiev. Una raffica di incontri organizzati dall’ufficio ICE nella capitale ucraina mi lascia solo un gran mal di testa e fogli di appunti destinati al cestino.
Non vedo un mercato per i prodotti della mia ditta e in compenso ho incontrato un bel cast di faccendieri ed ex-dirigenti di aziende di stato decotte e ricomprate a quattro soldi.
Faccio due passi per il centro città scendendo dalla Shovkovychna dove si trova l’ICE e mi incammino per la Khreshchatyk a guardare la gente e le vetrine. È fine Ottobre, l’aria è frizzante e il sole splende in un cielo limpido.
Vedo parecchie belle donne dal fisico statuario ma vestite in maniera curiosa. Ne incrocio una che ha i capelli rosso fuoco, gli occhi celesti, una giacchetta di nappa carta da zucchero, la gonna in pelle di mucca Simmental bianca e marrone e gli stivali al ginocchio in pelle rossa lucida.
E come lei tante altre, paludate in maniera improbabile, ma indubbiamente belle.
Con il mio vestito scuro e il cappotto che indosso sono immediatamente riconoscibile come un “occidentale”. Mi attiro sguardi rapaci da parte di molte giovani ucraine più o meno dell’età di mia figlia.
C’è poco da montarsi la testa. La mia interprete, Elena, mi ha detto che il sogno di ogni giovane ucraina è venire a vivere nell’Europa Occidentale. Più del portafogli zeppo di Hryvnia e l’Hummer H2 con i vetri scuri (ormai ne girano tanti quante sono le Lada), la donna ucraina guarda in un uomo la possibilità di mollare tutto e andare a vivere a Milano, Parigi o Monaco.

Si è fatta ora di cena. Nel mio passeggio senza meta ho visto un ristorante che mi intriga, si chiama Pervak e sembra un posto allegro e ben frequentato. Ho voglia di riscattare l’esperienza disarmante di una cena retrò alla maniera dei ristoranti di stato (Hotel Rus, ieri sera). Bersaglio centrato, Pervak ha un’impronta mitteleuropea, è simpatico e raffinato. Potrei essere a Vienna o a Lubiana e mi trovo subito a mio agio.
Comincio a capire queste giovani ucraine: sono da poco a Kiev ma già vorrei essere altrove.

Dic 9, 2009 | The Blog
 Arrivo a KNIB (che si pronuncia Kiev), prendo un taxi per l’Hotel PYCb (che si pronuncia Rus) e già sento che avrò qualche problema. Se in Cina la battaglia è persa in partenza, in Ucraina potrei ancora farcela a leggere le insegne e i nomi delle strade. Il fatto è che sono troppo lento e i cartelli mi sfilano sotto il naso prima che abbia faticosamente finito di leggerli bisbigliando le scritte lettera per lettera. Il tassista deve avermi preso per uno squilibrato che parla da solo.
Arrivo a KNIB (che si pronuncia Kiev), prendo un taxi per l’Hotel PYCb (che si pronuncia Rus) e già sento che avrò qualche problema. Se in Cina la battaglia è persa in partenza, in Ucraina potrei ancora farcela a leggere le insegne e i nomi delle strade. Il fatto è che sono troppo lento e i cartelli mi sfilano sotto il naso prima che abbia faticosamente finito di leggerli bisbigliando le scritte lettera per lettera. Il tassista deve avermi preso per uno squilibrato che parla da solo.
Arrivo in albergo, un monolito nel centro cittadino che evoca interminabili riunioni di partito con nuvole di fumo di sigaretta e vodka come se fosse Perrier. La camera è piccola ma più che decente; l’ora tarda mi consiglia di cenare in albergo e rimandare a domani l’esplorazione della città.
Il ristorante sembra quello di un traghetto, va avanti a perdita d’occhio in un caleidoscopio di tavoli dai colori sgargianti, fiori di plastica e una moquette così rossa che ti fa male agli occhi. In Russo, bello e rosso si dicono allo stesso modo. In Ucraino evidentemente no. Gli altoparlanti della sala sparano Dancing Queen degli Abba a mio beneficio esclusivo.
Sebbene sia l’unico ospite del ristorante, lo staff sembra comunque impegnato a fare altro. Passano alcuni minuti, siamo già arrivati al brano Money, Money Money e finalmente dalle viscere di questa sala gigantesca spunta un cameriere. Ho già scelto dalla carta quello che vorrei ordinare: dopotutto siamo a Kiev, vada quindi per il celeberrimo “Chicken Kiev”.
Boris, il cameriere (il suo badge dice ?op?c e ho fatto in tempo a leggerlo), scuote la testa come si fa con un bambino che non riesce a fare 2 x 2. Mi dice in Inglese che per il Chicken Kiev c’è un’attesa di 40 minuti e mi consiglia di scegliere qualcos’altro dal menu.
Va bene, ordino uno spiedino di carne e una birra Obolon.
 La birra è sul mio tavolo dopo 5 minuti. Lo spiedino invece ci mette 40 minuti ad arrivare, che tradotto in birre fa 3 Obolon e un altro passaggio del CD degli Abba. Ho capito: ci vogliono 40 minuti per qualunque piatto, ma il Chicken Kiev questa sera non era disponibile. Boris consegna il piatto con una piroetta e si dilegua.
La birra è sul mio tavolo dopo 5 minuti. Lo spiedino invece ci mette 40 minuti ad arrivare, che tradotto in birre fa 3 Obolon e un altro passaggio del CD degli Abba. Ho capito: ci vogliono 40 minuti per qualunque piatto, ma il Chicken Kiev questa sera non era disponibile. Boris consegna il piatto con una piroetta e si dilegua.
Venti minuti dopo, in questo mare di rosso appare una cameriera in bianco e nero. Provo a ordinare un dessert. Mi dice con tono ufficiale che devo rivolgermi al mio cameriere. Già, a trovarlo…
Prima di essere anche lei fagocitata da questa sala carnivora, mi assicura che provvederà a informare Boris della mia richiesta.
Passano 15 minuti e lo vedo apparire in fondo alla sala mentre punta deciso verso di me. “Lei voleva il conto, vero?” mi dice.
Mi arrendo e gli rispondo di si. Gli Abba stanno cantando S.O.S. e anch’io sono allo stremo delle forze.
Ho deciso, domani sera esco da questa macchina del tempo bloccata al 1979 e mi trovo un ristorante contemporaneo.

Dic 5, 2009 | The Blog

Sono di nuovo al Cairo e Mohammed, il mio amico tassista, è di nuovo la mia guida.
Gli ho annunciato che domani mattina dovremo partire per Alessandria, perché ho degli incontri in zona.
Ce la farà quel rudere della sua Fiat 1100 ad andare e tornare?
Con tono solenne, Mohammed mi promette: “Dumorroh, spesial car!”
Non riesco a tirargli fuori ulteriori dettagli. Bè, mi dico, magari è un’Audi A8.
Questa sera si mangia leggero e niente uscite notturne. Domani abbiamo deciso di partire alle 6:00, ma se rientriamo abbastanza presto voglio regalarmi una cena al Sabaya, il raffinato ristorante libanese del mio albergo.
Alle 6:00 sono in strada. Manca poco all’alba ma, a giudicare dal coro dei clacson, la città è già vibrante di attività.
Mohammed mi viene incontro con una faccia da poker e mi indica la macchina che ci porterà ad Alessandria: è la solita Fiat 1100 bianca e nera.
“Spesial car not possibul” è tutto quello che ha da dire. Maalesh, pazienza, penso io. Basta che questa vecchia carretta ci riporti a casa.
Usciamo spediti dal Cairo e cominciamo a macinare chilometri sulla Desert Road alla nostra andatura di 80-90 kmh. Il sole sta sorgendo e illumina il deserto con effetti bellissimi.
I 220 km che separano Cairo da Alessandria sono costellati di basi militari dalle mura altissime, piccole comunità agricole e baracche che vendono di tutto, dalla frutta ai pneumatici. Il resto è sabbia.
Ci fermiamo per un caffè in una specie di area di servizio. Fin qui, il viaggio è stato privo di sorprese. Il primo appuntamento di oggi è a Borg El Arab City, mezz’ora prima di Alessandria. Arriviamo in anticipo, così decidiamo di fare benzina per il ritorno.
Ad Alessandria esco dal mio ultimo colloquio poco dopo le 17:00, il tempo è buono e il traffico non particolarmente intenso. Vedo la mia cena libanese diventare sempre più probabile e provo a fare una lista dei mezzeh, gli antipasti, da ordinare.
Ma ci troviamo ancora alla periferia di Alessandria e sta facendo buio quando la Fiat 1100 comincia a ondeggiare. Abbiamo forato la gomma posteriore sinistra.
Mohammed insiste per cambiare la gomma da solo, ma io sono abbastanza esperto e in due dovremmo fare prima. Mentre il traffico ci sfiora a pochi centimetri di distanza, smontiamo il vetusto pneumatico forato e montiamo quello di scorta. È liscio come una caciotta, ma è tutto quello che c’è.
Si riparte che è buio e la Desert Road si perde nell’oscurità davanti a noi. Il rumore delle gomme sull’asfalto e le vibrazioni dell’antico taxi mi fanno quasi addormentare. È stata una giornata interessante e sono soddisfatto. Un sussulto della macchina mi fa spalancare gli occhi. Il motore comincia a perdere colpi. Sembra di andare a tre cilindri, anzi ora a due. La macchina si ferma.
Con Mohammed iniziamo ad armeggiare nel motore alla luce di una torcia elettrica morente. Smontiamo le candele. Per fortuna, la Fiat 1100 ha un motore giurassico in cui tutto è in bella vista.
Le candele sembrano in ordine, le rimontiamo e la macchina riparte.
Mentre ci domandiamo quale possa essere stata la causa del problema, la Fiat riprende a camminare a strappi. Altra sosta, altro smonta e rimonta.
Abbiamo ora il sospetto di aver fatto un pieno di benzina mista ad acqua fuori Alessandria. Ma aver individuato la causa del problema non ci aiuta. Dobbiamo arrivare al Cairo e mancano ancora 110 km.
Ho perso il conto di quante volte ci siamo dovuti fermare al lato della strada. La Fiat 1100 muore definitivamente al casello di Abu Rawash, circa mezz’ora fuori città. Le ultime volte l’abbiamo fatta partire a spinta perché la batteria era ormai a terra. Addio cena libanese, maalesh. Sto diventando fatalista anche io.
È quasi mezzanotte e decidiamo di mangiare qualcosa a un fast-food dall’altra parte della strada. Il fratello di Mohammed, tassista anche lui, è in arrivo con la sua macchina (“new car” dice Mohammed. Tutto è relativo: la macchina nuova si rivela infatti un clone della Fiat Regata fatto in Turchia.) Mentre il fratello resta a guardia della 1100, Mohammed mi accompagna in albergo e poi ritorna a trafficare sulla sua Fiat. I due finiranno di lavorarci alle 4:00, dopo aver svuotato il serbatoio e smontato il carburatore.
Ma alle 8:00, Mohammed è di nuovo in attesa davanti al mio hotel. Anche la 1100 è lì, pronta a riprendere servizio e il suo motore ronza regolare come se fosse nuovo.

Qasr al Baron (il Palazzo del Barone) a Heliopolis (Cairo).

Dic 4, 2009 | The Blog

Non parlo Arabo, a parte due o tre formule di saluto, e al massimo so riconoscere in una conversazione quello che ho sentito definire “l’IBM egiziana”, cioè Insh’allah, Bokra, Maalesh. In altre parole, Se Dio vuole, Domani, Poco male. (Da non prendere letteralmente. La frase può voler dire: io non ci posso fare niente, magari si sistema da sé domani, pazienza.)
Armato di questo minuscolo bagaglio a mano linguistico e non sapendo leggere la scrittura araba, l’idea di poter girare per il Cairo e dintorni in maniera autonoma per un’intera settimana di lavoro non mi era nemmeno passata per la testa.
“Prendo il taxi” mi ero detto. E infatti, uscito dall’albergo sulle sponde del Nilo (quello che una volta era il glorioso Hotel Semìramis), mi trovo davanti una fila di taxi scassati e un gruppetto di tassisti in agguato.
Chiarite le mie intenzioni (ho sei appuntamenti nel corso della giornata), si offre volontario un certo Mohammed e mi fa strada verso la sua vettura, una Fiat 1100 degli Anni 50 tenuta insieme dalla vernice bianca e nera. Il personaggio ha circa 35 anni, due baffoni da carabiniere del secolo scorso e una faccia da simpatica canaglia. Partiamo.
Mohammed conosce sì e no cento parole di Inglese e gli indirizzi preferisce vederli scritti piuttosto che sentirli pronunciare da me. Non posso dargli torto. Ma il nostro lavoro di squadra procede perfettamente. Io scendo dal taxi per andare al mio appuntamento e Mohammed mi aspetta dormendo nell’auto parcheggiata all’ombra.
Torniamo alla base che è ormai buio. Mohammed mi dà mezz’ora per cambiarmi e poi mi porta a un ristorante-showboat che offre giri turistici lungo il Nilo con musica e spettacolo. Ho voglia di fare il turista e sono accontentato: mi ritrovo tra Inglesi che ballano con i dervisci e Giapponesi che fotografano tutto.
Due ore dopo, mentre ormai medito il suicidio, il battello accosta al suo ormeggio: nella luce dei lampioni scorgo una testa appoggiata al volante della Fiat 1100 parcheggiata a bordo strada.
Mentre mi congedo da Mohammed davanti all’albergo, lui mi chiede: “Dumorroh, visit gombany again?”
Perché no? Ormai siamo un team. Gli rispondo: “OK, Mohammed. See you tomorrow, right here, eight o’clock”, mentre indico per terra e gli mostro otto dita a titolo illustrativo.

Moschea di Al-Azhar, presso il souq di Khan el-Khalili
E così andiamo avanti per il resto del mio soggiorno al Cairo. Ci spingiamo fino a 10th of Ramadan City (un insediamento industriale a Nord-Est del Cairo sulla strada per Ismailia) e a 6th of October City, che si trova invece a Sud-Ovest della metropoli (*).
Ormai la collaborazione con Mohammed è consolidata. Lui pilota l’anziana Fiat a colpi di clacson nel traffico cittadino o lungo le statali, io siedo sul sedile posteriore e consulto le mie carte prima di ogni appuntamento.
L’ultimo giorno, Mohammed mi accompagna all’aeroporto e mi chiede se ho intenzione di ritornare in Egitto nel prossimo futuro. In effetti, ho in programma una seconda visita tra qualche settimana e glielo dico.
Mohammed si illumina; sono stato un buon cliente. “Very good, very good. See you in Cairo more later, insh’allah . You telephone me when you know day.” e mi porge un biglietto da visita.
Le mie scorribande egiziane nel taxi di Mohammed sono appena iniziate e ve le racconterò più avanti.
(*) Il significato di queste date la dice lunga: il 6 Ottobre 1973, che corrisponde al decimo giorno del Ramadan, segna l’inizio della Guerra del Kippur, con l’attacco a sorpresa della coalizione Egitto-Siria per la riconquista dei territori occupati da Israele nella Guerra dei Sei Giorni di sei anni prima. Anche se, dopo le iniziali vittorie arabe, la reazione israeliana riuscì a respingere sia i Siriani che gli Egiziani, la guerra del 1973 è considerata in Egitto una pagina gloriosa.

Dic 1, 2009 | The Blog

New Mexico, USA, fine di Maggio. Il tracciato della vecchia Route 66 attraversa un tratto desertico dalla terra rossa che segue il letto di un fiume in secca e si estende all’infinito nell’aria tremolante per il calore. Il fondo stradale è in pessime condizioni, ma è quello autentico della leggendaria strada americana: The Mother Road, da Chicago a Los Angeles in 2.400 miglia. A poca distanza, carica di traffico, corre la Interstate 40 che qui l’ha ormai soppiantata da decenni e già da quasi un’ora non ho diviso la strada con nessuno.
Alla mia destra vedo i resti di un vecchio ponte della ferrovia, molti dei piloni in legno sono crollati e quelli ancora in piedi sembrano un gruppo di ubriachi. Mi tornano alla mente mille scene di film western, con il treno a vapore che arriva sferragliando sul singolo binario mentre dai piloni del ponte penzolano le micce sfrigolanti della dinamite.
Mentre mi fermo a scattare un paio di foto, all’orizzonte appare una nuvola di polvere. In pochi minuti arriva un vecchio pick-up con due uomini a bordo. Si fermano a fianco della mia Ford noleggiata e il guidatore apre il finestrino. È un uomo sulla quarantina con un berretto da baseball e strizza gli occhi contro il sole. “Problemi alla macchina?” mi chiede.
“No – gli rispondo – sto facendo un po’ di foto.”
“Sei anche tu uno di quei matti che si fanno tutta la Old 66 fino a LA per il solo gusto di farla?”

Confesso la mia colpa e racconto loro di essere addirittura venuto apposta dall’Europa. Si guardano ridendo e scuotono la testa. “Senti, se ti va di bere qualcosa di fresco, seguici fino al ranch qui dietro la curva.”
Accetto volentieri. Sebbene sia ormai abituato all’ospitalità immediata di molti Americani, questa volta rimango stupito. L’Europeo in me si chiede anzi se sia cosa saggia seguirli “dietro la curva” carico di macchine fotografiche e dollari in contante.
Ma siamo già arrivati. Il ranch è una casetta squadrata come la disegnerebbe un bambino; a fianco sorge un capannone con un paio di trattori, niente a che vedere con i pittoreschi fienili in legno che ancora si trovano dappertutto in America. C’è un pozzo artesiano, qualche bidone di olio, due macchine parcheggiate e il resto è sabbia e collinette rocciose che si spingono fino all’orizzonte.
In questo mare di colore ocra, vedo lontano una macchia verde, come un’oasi nel deserto.
“È un vecchio pozzo che usava la US Cavalry per abbeverare i cavalli”, mi legge nel pensiero l’amico del pick-up mentre mi porge una lattina di birra imperlata di condensa. “Qui non c’è un gran che ma se ti fermi, domani possiamo fare un giro a cavallo.”
Lo ringrazio, ma spiego che devo continuare fino a Flagstaff in Arizona. “OK, come vuoi”, mi dice. Gli Americani non insistono quasi mai, visto che loro stessi raramente dicono “no grazie” solo per fare complimenti.
L’amico sparisce nel ranch e ritorna dopo un minuto con un six-pack di birre Coors Extra Gold gelate. “Mettile al fresco” mi dice. Deve aver visto il cooler di plastica che ho comprato al Wal-Mart per pochi dollari. Se attraversi l’America senza averne uno, devi essere per forza uno straniero alla sua prima visita.
“Come back anytime, y’hear?” mi salutano lui e il suo amico, mentre salgo in macchina.
Dopo pochi secondi il ranch sparisce nella nuvola di polvere che mi lascio dietro. Ora sono di nuovo sulla Route 66 con la mia Ford bianca velata di polvere rossa mentre, armato di una Reflex e 6 birre gelate, inseguo un obiettivo che si sposta con l’orizzonte. Mai come questa volta la mia destinazione è la strada stessa.

 Nonostante le sue dimensioni contenute, il Pianeta Palla esercita una strana attrazione gravitazionale nei confronti del Business English più gergale. Sicuramente lo sport è una grande fonte di analogie, con una miriade di metafore condivise e il cui significato è immediatamente chiaro all’interlocutore, dato che si tratta in maniera statisticamente preponderante di individuo maschio e frequentatore degli stadi. Sfortunatamente, quando noi abbiamo a che fare con degli Americani, le loro espressioni più colorite derivano da due sport che da noi sono poco diffusi: baseball e American football, il che ci pone in una situazione di discreto svantaggio nel cogliere al volo il significato di certe similitudini.
Nonostante le sue dimensioni contenute, il Pianeta Palla esercita una strana attrazione gravitazionale nei confronti del Business English più gergale. Sicuramente lo sport è una grande fonte di analogie, con una miriade di metafore condivise e il cui significato è immediatamente chiaro all’interlocutore, dato che si tratta in maniera statisticamente preponderante di individuo maschio e frequentatore degli stadi. Sfortunatamente, quando noi abbiamo a che fare con degli Americani, le loro espressioni più colorite derivano da due sport che da noi sono poco diffusi: baseball e American football, il che ci pone in una situazione di discreto svantaggio nel cogliere al volo il significato di certe similitudini.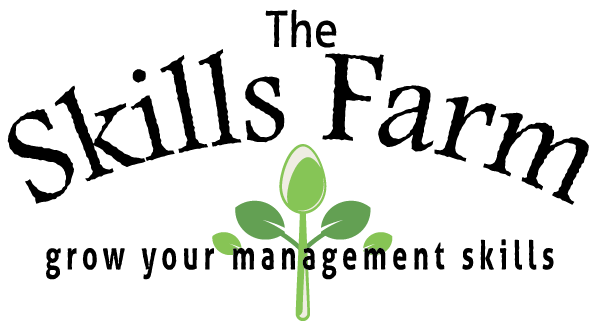

 Arrivo a KNIB (che si pronuncia Kiev), prendo un taxi per l’Hotel PYCb (che si pronuncia Rus) e già sento che avrò qualche problema. Se in Cina la battaglia è persa in partenza, in Ucraina potrei ancora farcela a leggere le insegne e i nomi delle strade. Il fatto è che sono troppo lento e i cartelli mi sfilano sotto il naso prima che abbia faticosamente finito di leggerli bisbigliando le scritte lettera per lettera. Il tassista deve avermi preso per uno squilibrato che parla da solo.
Arrivo a KNIB (che si pronuncia Kiev), prendo un taxi per l’Hotel PYCb (che si pronuncia Rus) e già sento che avrò qualche problema. Se in Cina la battaglia è persa in partenza, in Ucraina potrei ancora farcela a leggere le insegne e i nomi delle strade. Il fatto è che sono troppo lento e i cartelli mi sfilano sotto il naso prima che abbia faticosamente finito di leggerli bisbigliando le scritte lettera per lettera. Il tassista deve avermi preso per uno squilibrato che parla da solo. La birra è sul mio tavolo dopo 5 minuti. Lo spiedino invece ci mette 40 minuti ad arrivare, che tradotto in birre fa 3 Obolon e un altro passaggio del CD degli Abba. Ho capito: ci vogliono 40 minuti per qualunque piatto, ma il Chicken Kiev questa sera non era disponibile. Boris consegna il piatto con una piroetta e si dilegua.
La birra è sul mio tavolo dopo 5 minuti. Lo spiedino invece ci mette 40 minuti ad arrivare, che tradotto in birre fa 3 Obolon e un altro passaggio del CD degli Abba. Ho capito: ci vogliono 40 minuti per qualunque piatto, ma il Chicken Kiev questa sera non era disponibile. Boris consegna il piatto con una piroetta e si dilegua.







