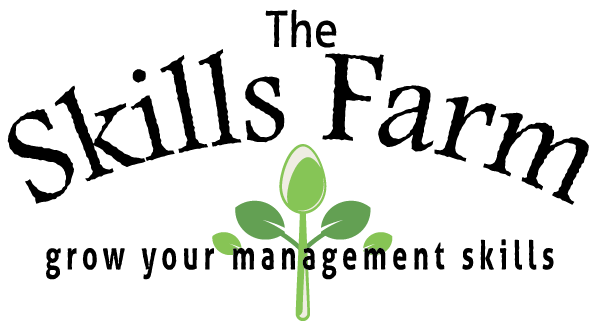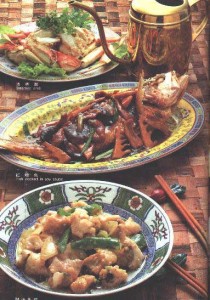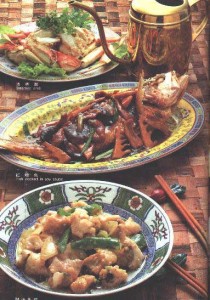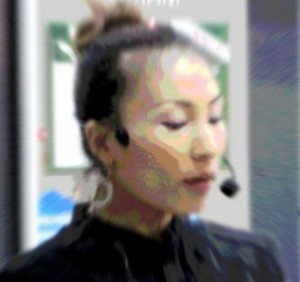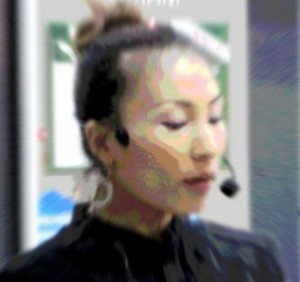Gen 22, 2011 | The Blog
 Come da copione, il dittatore tunisino esce di scena con un carico d’oro che la stampa calcola in una tonnellata e mezza, a spanne 45 milioni di euro.
Come da copione, il dittatore tunisino esce di scena con un carico d’oro che la stampa calcola in una tonnellata e mezza, a spanne 45 milioni di euro.
A suo tempo, il buon Saddam Hussein aveva accumulato una quantità d’oro non precisata e che ha dato adito negli anni alla nascita di varie leggende, speculazioni e perfino film di Hollywood. “L’oro di Saddam” è quasi diventato l’equivalente moderno del tesoro affondato con qualche antico galeone al largo del Nuovo Mondo.
Che cosa fanno intanto i tiranni rimasti? Credono anch’essi nel risparmio, nel gruzzoletto messo da parte e che un giorno servirà a integrare la pensioncina da Leader Fraterno o Padre della Patria?
Poco si sa sui piani di accumulo dell’uomo forte egiziano, Mubarak. In Egitto tutti ne parlano male, ma lo fanno bisbigliando perché i servizi segreti Mukhabarat hanno orecchie dappertutto. Il giovanotto (classe 1923) non sembra contemplare la pensione e già si sono diffuse a varie riprese voci sulla sua morte.
Se Hosni ha intenzione di andare a vivere a Dubai con un cargo pieno di oro, mummie e pezzi di piramidi farà bene a sbrigarsi.
Al confronto Gheddafi (classe 1942) è un giovane virgulto. Ha preso il potere nel 1969 e, se da una parte la sua carriera militare è finita a colonnello, si può permettere di fare lo shampoo ai generali perché lui è il Leader della Rivoluzione.
Difficile dire se il colonnello stia accumulando lingotti sotto la tenda. Di sicuro il suo gruzzolo risiede nelle banche svizzere. Sarà meno pittoresco dell’immagine dell’oro chiuso a chiave in un forziere ma probabilmente più sicuro.
Come faccio a saperlo? Anni fa lavoravo per un’azienda che aveva clienti in Libia. Questi erano una cooperativa di piccoli industriali che compravano in Italia tramite un emissario, naturalmente approvato (anzi imposto) dal regime. Il plenipotenziario arrivava da noi con valigie piene di dollari USA in contanti (per comprare i quali il colonnello concedeva un tasso di cambio agevolato) e acquistava il prodotto da spedire in Libia. Parte della sua commissione la ritirava in contanti, un’altra parte andava pagata su un conto svizzero di Mr. G, che di fatto era suo socio.
Non è impensabile che lo stesso modus operandi sia stato adottato per acquisti ufficiali di altri beni Made in Italy, dagli elicotteri alle macchine operatrici.
Anche Il Leader Fraterno, un domani che i fatti della vicina Tunisia dovessero contagiare la popolazione libica, avrebbe sicuramente abbastanza soldi da parte per vivere una vecchiaia serena.
E questo, inutile dirlo, mi conforta parecchio.

Gen 1, 2011 | The Blog

Un corso sulla comunicazione multiculturale incentrato sull’India e da poco concluso mi ha visto discutere con degli specialisti informatici italiani dei problemi legati alla collaborazione con un partner indiano in progetti di sviluppo software.
Che l’India sia un mercato dall’enorme potenziale e una grande opportunità per le imprese occidentali in cerca di partner non è una novità. Già da molti anni numerose aziende occidentali hanno iniziato a trasferire in India parte delle loro attività di “back office”; le compagnie aeree furono tra le prime a muoversi, delegando a partner o consociate indiane la contabilità dei tagliandi dei biglietti.
Da allora il settore del BPO (Business Process Outsourcing) si è sviluppato fino a diventare un’industria da ben oltre 10 miliardi di dollari USA l’anno e la sua crescita continua. Le notizie di stampa e le statistiche vanno però lette con un minimo di cautela.
Ci sono pertanto alcuni punti che vanno interpretati in maniera realistica.
- L’India ha 40 milioni di laureati, più dell’intera popolazione della Polonia.
In realtà, questo corrisponde a una percentuale del 3,3% della popolazione e non basta a soddisfare le richieste delle aziende. I neolaureati sono 3 milioni l’anno, ancora una goccia nel mare (lo 0,25% della popolazione).
- L’India ha università prestigiose e istituti tecnici di livello mondiale.
Ma la maggioranza degli studenti indiani (ci sono 250 milioni di giovani tra i 15 e i 25 anni) non ha accesso a questi istituti di altissimo livello. La sfida del governo indiano è portare un’istruzione qualificata a tutte queste giovani risorse, ma ci vorranno degli anni per vedere i primi risultati.
- Nel 2025 un lavoratore su quattro al mondo sarà indiano.
Il problema è il disallineamento tra istruzione, domanda e offerta. Il potenziale umano esiste dove mancano le scuole, i lavoratori qualificati ci sono dove mancano le industrie, le competenze della forza lavoro non corrispondono alle esigenze delle aziende locali. Tutto questo è anche legato alla carenza di infrastrutture in India e alla scarsa mobilità della forza lavoro sul territorio.
- In India 300 milioni di persone parlano inglese.
Si tratta comunque di meno di un quarto della popolazione e resta da dimostrare come e dove il livello della lingua corrisponda alle esigenze delle aziende internazionali.
Insomma, la storia di successo del BPO in India non è priva di aspetti critici e di grosse difficoltà in alcune aree. Se è vero che i settori trainanti dell’IT e della computer animation attraggono le migliori risorse, avviene anche che le restanti attività debbano accontentarsi di risorse umane dalla preparazione scolastica e professionale meno che ottimali.
Quello del BPO rimane tuttavia un movimento epocale, come le storiche migrazioni nel passato dell’India. Solo che questa volta è il lavoro a emigrare in India e non più i suoi abitanti a lasciare il Paese.
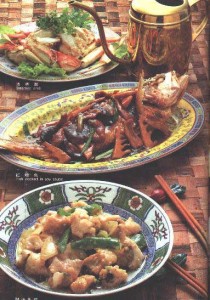
Dic 24, 2010 | The Blog
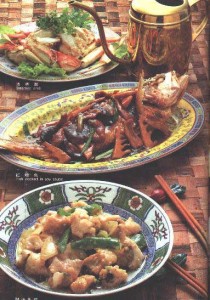 C‘è una cosa che non faccio mai quando sono in viaggio fuori dell’Italia: mangiare in un ristorante italiano.
C‘è una cosa che non faccio mai quando sono in viaggio fuori dell’Italia: mangiare in un ristorante italiano.
Viaggiare, almeno per me, è l’occasione di calarsi in una realtà e una cultura differenti. Andare a mangiare italiano è come una resa definitiva, la rinuncia a scoprire che cosa c’è di buono (o meno buono) sulla piazza locale.
Come esempio penso all’Inghilterra, invece di ricorrere alle solite immagini scontate ( e spesso infondate) connesse al cibo orientale.
L’Inghilterra è uno di quei luoghi in cui la tradizione culinaria locale, piatta e sciatta, non mi attira per niente ed è per fortuna poco rappresentata in termini di ristoranti. Avendo anche abitato in quell’isola per degli anni, gli unici ricordi di pasti memorabili sono legati a spettacolari ristoranti etnici: cinesi, tailandesi, vietnamiti e specialmente indiani, che sono a tutti gli effetti il meglio della cucina britannica e furono senza dubbio la mia salvezza. Poche le visite a ristoranti italiani e tutte al seguito di inglesi che credevano di farmi contento.
Anche in Germania, Paese che frequento da quasi 40 anni, le mie visite al ristorante italiano si contano sulle dita di una mano e sono legate alla scelta di altri. Un mio cliente tedesco in Franconia mi ha portato un paio di volte al suo ristorante preferito, un locale chiamato Bella Napoli con le tovaglie a quadretti, il fiasco di vino rosso in mezzo al tavolo e le pareti affrescate in maniera oscena con Vesuvi fumanti e barche di pescatori a riva.
I camerieri dall’aria saccente parlavano un tedesco sgangherato inframmezzato dalla parola signOre, con un’enfasi esagerata sulla O tanto per dare più colore locale all’esperienza culinaria. Il mangiare era mediocre, il conto salato e il servizio fin troppo untuoso. Mai più.
Anche dopo permanenze piuttosto lunghe in Paesi dalla cucina esotica, il pensiero di rifugiarmi in un ristorante italiano (o peggio ancora in uno dal nome italiano inventato per ragioni di marketing) non mi è mai passato per la testa.
Qualche anno fa mi sono ritrovato a trascorrere quasi un mese in Cina. Nonostante la cucina cinese sia una di quelle che preferisco, alla terza settimana cominciavo ad avere voglia di mangiare qualcosa di diverso.
Per fortuna mi trovavo a Hong Kong e una delle maggiori attrattive di quel posto straordinario è la possibilità di scegliere tra tutte le cucine del mondo, dal bistrot francese al ristorante tedesco fino a quello ucraino.
Davanti a tanta scelta, optai per un ristorante americano, il Dan Ryan Chicago Grill a Tsim Sha Tsui. L’atmosfera è quella di un locale americano degli anni 40, le bistecche arrivano in aereo dagli USA e anche le porzioni sono americane.
Potrà anche sembrare un’esperienza artificiale, come cenare al poco distante Hard Rock Café, ma dopo tre settimane di cucina cinese autentica mi era presa voglia di una bistecca come si deve e di un locale meno caotico del tipico ristorante cinese, che almeno in Cina ha spesso le dimensioni di una stazione ferroviaria.
E così, nonostante la presenza a Hong Kong di locali italiani molto quotati (e anche molto cari), l’idea di mangiare gli spaghetti allo scoglio e ascoltare le canzonette napoletane non mi passò nemmeno per la testa.
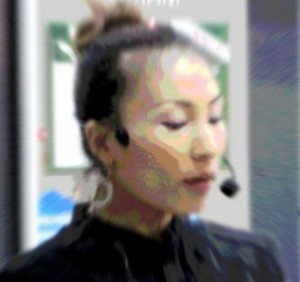
Dic 7, 2010 | The Blog
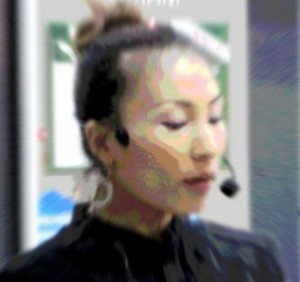 Oggi alzare il telefono e parlare con il customer service di un’azienda multinazionale o con il “room service” di un albergo può rappresentare un’esperienza illuminante, anche e specialmente per chi credeva di avere una conoscenza perfetta della lingua inglese.
Oggi alzare il telefono e parlare con il customer service di un’azienda multinazionale o con il “room service” di un albergo può rappresentare un’esperienza illuminante, anche e specialmente per chi credeva di avere una conoscenza perfetta della lingua inglese.
In questo dialogo, che mi è arrivato via Internet, dovete immaginare di essere l’ospite dell’hotel e cercare di capire che cosa dice la voce dall’altra parte del filo. Vi assicuro che, giunti alla fine della conversazione, non avrete alcun problema a decifrare la parola del titolo (Tenjooberrymuds).
Room Service : “Morrin. Roon sirbees.”
Guest : “Sorry, I thought I dialed room-service.”
Room Service: “Rye . Roon sirbees…morrin! Joowish to oddor sunteen???”
Guest: “Uh….. Yes, I’d like to order bacon and eggs..”
Room Service: “Ow July den?”
Guest: “…..What??”
Room Service: “Ow July den?!?… Pryed, boyud, poochd?”
Guest: “Oh, the eggs! How do I like them? Sorry.. Scrambled, please.”
Room Service: “Ow July dee baykem? Crease?”
Guest: “Crisp will be fine.”
Room Service: “Hokay. An Sahn toes?”
Guest: “What?”
Room Service: “An toes. July Sahn toes?”
Guest: “I… Don’t think so.”
RoomService: “No? Judo wan sahn toes???”
Guest: “I feel really bad about this, but I don’t know what ‘judo wan sahn toes’ means.”
RoomService: “Toes! Toes!…Why Joo don Juan toes? Ow bow Anglish moppin we bodder?”
Guest: “Oh, English muffin!!! I’ve got it! You were saying ‘toast’… Fine…Yes, an English muffin will be fine.”
RoomService: “We bodder?”
Guest: “No, just put the bodder on the side.”
RoomService: “Wad?!?”
Guest: “I mean butter… Just put the butter on the side.”
RoomService: “Copy?”
Guest: “Excuse me?”
RoomService: “Copy…tea..meel?”
Guest: “Yes. Coffee, please… And that’s everything.”
RoomService: “One Minnie. Scramah egg, crease baykem, Anglish moppin, we bodder on sigh and copy …. Rye ??”
Guest: “Whatever you say..”
RoomService: “Tenjooberrymuds.”
Guest: “You’re welcome”
PS: Ve l’avevo detto che alla fine avreste capito che cosa vuol dire ‘Tenjooberrymuds’ ed è così, non è vero?

Nov 29, 2010 | The Blog

Spesso mentre mia moglie ed io siamo a tavola. il nostro cane Samantha (per gli amici Sam) salta su una sedia vuota, si siede con una certa eleganza e ci guarda fissi negli occhi.
Non ho dubbi che la sua unica intenzione sia sorvegliare i piatti in tavola nella speranza di rimediare qualcosa di buono, la roba sfiziosa che mangiano gli umani, sapete, non i soliti croccantini.
Eppure ci sono delle volte che, avendola seduta di fronte a me, vedo quegli occhi senza fondo che mi fissano intensi e mi domando che cosa stia pensando.
Ma i cani pensano? E se pensano, la domanda veramente importante è a che cosa pensano?
Preoccupazioni non ne hanno e ogni giorno è un nuovo inizio: un nuovo periodo di tempo che va vissuto sulla base dell’istinto, dei ricordi accumulati e con l’aiuto di udito, odorato e vista ma che, in sostanza, è un nuovo giro di giostra scandito solo dagli appuntamenti alimentari e dai bisogni fisiologici.
Come tutti gli animali, il cane è una macchina programmata per sopravvivere. I suoi bisogni sono essenziali e non ci sono tentennamenti né incertezze. A volte però sento Sam emettere dei sospiri profondi e, nella mia fissazione di umanizzarla ad ogni costo, la immagino sconsolata, in ansia per il suo futuro.
A volte Sam sogna. All’improvviso, nel mezzo di un sonno profondo, comincia ad agitarsi, a scalciare. Poi si tranquillizza e riprende a dormire.
Che cosa sognano i cani? Voglio dire, che cosa sognano a parte delle fonti inesauribili di roba da mangiare?
Che cosa può creare loro degli incubi? Sarà il pensiero di aprire gli occhi e non trovarsi più in una casa riscaldata e piena di posti dove dormire? Il pensiero di avere all’improvviso dei padroni più severi di noi? Il ricordo di un enorme cane assassino che li ha spaventati?
Ho appena letto che le persone con quozienti intellettivi più alti sognano di più degli altri. Potrei desumerne che Sam è un cane molto intelligente (più di me di sicuro, visto che sogno veramente poco).
Oppure la cosa non vale per i cani?
Mi sembrerebbe una vigliaccata. Come la storia che noi abbiamo l’anima e loro no.
Ma ci stiamo allontanando dalla domanda di partenza: ma allora, i cani pensano?
Come fare a scoprirlo? Non so neanche se i ministri pensano (a giudicare dai fatti si direbbe in realtà che non gli riesca), figuratevi se mi riesce di dimostrare che i cani ne sono capaci.
Sarebbe un bel colpo però e credo che a Sam farebbe molto piacere essere considerata un’intellettuale.

Nov 22, 2010 | The Blog

Viaggio lampo in Germania. Alle 9.20 del mattino già tocco terra a Stoccarda dopo un rapido volo sopra le Alpi che, alla luce del sole mattutino, sembrano delle meringhe giganti.
L’aereo è un Fokker 100 della consociata di Lufthansa, un aeromobile abbastanza stagionato ma in condizioni da concorso nonostante gli almeno 15 anni.
Durante il volo getto un’occhiata al giornale. In mezzo alle non-notizie politiche italiane (il tale ammonisce, l’altro controbatte ma nel teatrino nulla cambia) compare un articolo sull’attuale situazione dei maggiori costruttori di aerei commerciali dopo un paio di clamorosi mancati incidenti dovuti a problemi tecnici.
Lo scriba non sa resistere alla tentazione di scadere nel sensazionale. L’articolo si intitola I giganti dell’aria sono deboli, o qualche altra banalità del genere, ed esordisce con il commento di un passeggero dell’ormai celebre Airbus A380 Qantas che racconta terrorizzato l’emergenza al motore di qualche giorno fa. Senza voler sminuire la gravità del fatto, basta intervistare qualunque passeggero dopo il più innocuo dei vuoti d’aria e i commenti saranno invariabilmente melodrammatici.” Ho creduto di morire”; “Mi sono detto questa volta siamo spacciati”; “Ho stretto la mano di mia figlia e ho chiuso gli occhi pregando”, “È stato un miracolo” e altre mistiche rivelazioni.
È un fatto noto che i mammiferi non sappiano volare. Quasi tutti vanno in aereo, ma dietro quella maschera di studiata indifferenza si nasconde la paura di chi non è nato con le ali eppure deve alzarsi in volo.
Il cronista di mestiere si arrampica e fa leva su questo timore innato tessendo una trama di tecnologie rischiose, di aerei esageratamente lussuosi (ma forse si confonde con le navi da crociera) e delle colpe degli avidi fabbricanti, lanciati a sua detta in un’assurda gara per il primato a tutto discapito di chi vola.
E allora, a giustificare la sua retorica complottista, eccolo collegare i puntini di un disegno che esiste solo nella sua testa. I ritardi del nuovo programma Boeing 787 Dreamliner sono messi in collegamento con un’avaria motore di un vecchio Boeing 767. Stiamo parlando di due generazioni diverse, il 787 è un aereo del futuro che deve ancora entrare in servizio. Il 767 è uscito per la prima volta dagli hangar Boeing nell’Agosto 1981. Lo so perché quel giorno indimenticabile c’ero anche io a Seattle e ne conservo un ricordo magico.
Che senso ha dipingere un quadro tanto catastrofico?
Tutti sappiamo che la paura vende più copie dei messaggi rassicuranti. La gente quindi divorerà l’articolo credendo a ogni parola. Quando si fa leva sui timori atavici l’attenzione del pubblico è massima.
L’italiano medio, confortato nella sua profonda convinzione che volare sia un enorme rischio, salirà oggi in auto e si lancerà a fare lo slalom in autostrada convinto invece della sua automobilistica immortalità.

 Come da copione, il dittatore tunisino esce di scena con un carico d’oro che la stampa calcola in una tonnellata e mezza, a spanne 45 milioni di euro.
Come da copione, il dittatore tunisino esce di scena con un carico d’oro che la stampa calcola in una tonnellata e mezza, a spanne 45 milioni di euro.