
Ott 25, 2015 | The Blog
 Ogni giorno i titoli dei giornali ci riportano le notizie di ulteriori atrocità perpetrate in nome della religione ed è ormai inevitabile associare le parole fondamentalismo o terrorismo all’aggettivo islamico.
Ogni giorno i titoli dei giornali ci riportano le notizie di ulteriori atrocità perpetrate in nome della religione ed è ormai inevitabile associare le parole fondamentalismo o terrorismo all’aggettivo islamico.
Ogni volta che, prima dell’imbarco di un volo, siamo costretti ad aprire il bagaglio a mano per farlo ispezionare, a toglierci scarpe e cinture prima di passare scalzi attraverso un metal detector, forse non ricordiamo nemmeno più che queste misure di sicurezza sono state rese necessarie in seguito agli atti terroristici commessi da attentatori islamici.
Certo, l’Islam non è l’unica religione nel cui nome sono stati perpetrati atti di violenza e intolleranza.
L’incapace che ancora risiede nella Casa Bianca ci ha ricordato nel Febbraio scorso che anche il Cristianesimo si è macchiato del sangue di innumerevoli vittime. Il suo riferimento alle Crociate esemplifica ancora una volta l’arroganza e la pericolosa incompetenza di uno dei peggiori presidenti nella storia. Il paragone tra il terrorismo e le atrocità di oggi con eventi storici che risalgono a oltre 800 anni fa è forzato e disonesto. A nessuno verrebbe in mente di incolpare i romani di oggi dello sterminio degli Etruschi avvenuto duemila anni fa.
Il mio lavoro mi ha portato per anni in nazioni caratterizzate da tensioni etniche e religiose e in paesi fortemente improntati all’islamismo. Tuttavia, solo di rado ho avuto occasione di sperimentare atteggiamenti aggressivi nei miei confronti quale europeo e quindi “infedele”. Premesso questo, resta comunque il fatto che, ogni volta che sono diretto in un paese arabo o quando il mio aereo di linea sorvola nazioni come l’Iran o l’Iraq, il pensiero va inevitabilmente alla questione sicurezza e a quella dell’intolleranza religiosa. E’ innegabile che il problema esista ed è stupido (o perfino criminale) minimizzarlo o negarlo come fanno Obama e altri come lui.
Nella terza settimana di Ottobre, ho lavorato per 4 giorni a Dubai, dove ero stato per l’ultima volta otto anni fa. Devo dire prima di tutto che l’impatto è stato incredibile: in otto anni il paese è cresciuto in maniera impressionante e mostra una vitalità straordinaria, essendo uscito dalla morsa della crisi globale ormai due anni fa ed essendosi impegnato in una serie di ulteriori, grandiosi progetti, non ultimo fra questi l’EXPO 2020.
Come in passato, anche questa volta mi ha colpito a Dubai la convivenza di più religioni, lingue e usanze in un paese dichiaratamente arabo. In questo emirato ricco di contrasti e, diciamolo pure, di sfarzo esagerato per gli standard europei, le varie convinzioni religiose sembrano coesistere intatte e con pari dignità.
A parte il caleidoscopio surreale degli shopping mall, dove la donna araba interamente velata guarda le vetrine a fianco di un’altra araba in abiti occidentali e tacchi alti, la normale e pacifica convivenza di usi e costumi è un fatto quotidiano. L’arabo che indossa la tipica kandoura immacolata non si scompone mentre al tavolo a fianco si siedono quattro americane in shorts; nel traffico intenso della Sheikh Zayed Road (v. foto), il commerciante indiano al volante di un gigantesco SUV bianco si contende pochi metri di asfalto con l’espatriato nordeuropeo al volante di una Porsche Panamera, il tutto in maniera naturale e non aggressiva.
Nei seminari di formazione che ho tenuto a Dubai, i partecipanti appartenevano ad almeno 7 diverse nazionalità e quattro religioni: cattolici, copti, induisti e musulmani. In particolare, sebbene fossero presenti due egiziani e un giordano, gli unici due islamici osservanti si sono rivelati essere indiani. All’inizio del seminario i due mi hanno chiesto se, per consentire loro di pregare all’orario prescritto, si potesse spostare di mezz’ora la pausa caffè pomeridiana.
L’abbiamo fatto senza problemi, ma mi ha colpito il modo del tutto sereno in cui la richiesta è stata fatta. Come tutti sappiamo, non sempre le esigenze degli islamici osservanti vengono presentate in maniera equilibrata (e questo in paesi in cui sono loro ad essere “ospiti”). Quando anni fa in un campo profughi siciliano è stato servito ai musulmani il mangiare durante il giorno—ed era il loro Ramadan—c’è stata una rivolta in cui hanno dato fuoco ai loro alloggi.
Qual è quindi l’esempio di Dubai?
Viene spontaneo concludere che, in presenza di un governo che garantisce la libertà religiosa e di un’economia in costante ascesa (PIL in crescita media del 5,25% dal 2012 ad oggi), l’integralismo non rientra tra le priorità dei residenti di Dubai, mentre il raggiungimento del benessere sì. Gli Emirati non sono certo un paradiso in terra, ma rappresentano tuttavia un compromesso funzionante tra un governo autocratico islamico e l’esigenza di assicurare all’oltre 80% di popolazione non locale la possibilità di vivere tranquillamente il loro stile di vita senza chiudersi in un “compound” come avviene in Arabia Saudita.

Set 2, 2015 | The Blog
Nella fase finale della sua seconda presidenza, Obama sta lavorando duro per ricavarsi una nicchia nei libri di storia.
 In questi giorni, in occasione di un viaggio in Alaska, ha ufficialmente ribattezzato Denali il Monte McKinley (la vetta più alta del continente americano). Di fatto, il nome Denali è da sempre stato utilizzato, a fianco o in sostituzione di quello ufficiale, per indicare quella splendida vetta.
In questi giorni, in occasione di un viaggio in Alaska, ha ufficialmente ribattezzato Denali il Monte McKinley (la vetta più alta del continente americano). Di fatto, il nome Denali è da sempre stato utilizzato, a fianco o in sostituzione di quello ufficiale, per indicare quella splendida vetta.
Ma il problema non è il nome. Per legge, è il Congresso degli Stati Uniti l’organo responsabile delle variazioni alla toponomastica. Il presidente si è arrogato un altro diritto che non gli compete a tutto beneficio della teatralità del gesto e in piena coerenza con il suo modus operandi autocratico e autoreferenziale.
La cosa ha fatto indignare alcuni e sorridere molti. E’ anche partita la corsa a indovinare quali nomi geografici tradizionali saranno i prossimi a cadere sotto i colpi del presidente.
Io mi permetto di suggerire di ribattezzare il Grand Canyon chiamandolo Grand Kenyan, in onore appunto del primo (e molto probabilmente ultimo) presidente americano di origini keniote. A differenza di Denali, non esiste infatti un nome indigeno cui fare riferimento (se non l’antica descrizione fatta dagli indiani Paiute: “la montagna che giace”) e quindi tanto vale assecondare la sconfinata vanità di Obama.
Sempre in occasione del viaggio in Alaska, il presidente ha annunciato che parteciperà a una puntata speciale di un reality show sui ghiacciai sotto la guida del survivalista Bear Grylls.
Anche qui i commenti negativi non sono mancati, a partire da una petizione che invitava Obama a bere la propria urina, una tecnica insegnata da Grylls. Ma senza cadere nel grottesco, molti si sono chiesti se queste “sparate” non siano dannose per l’immagine di un presidente che non è più popolare come una volta.
A mio avviso, Obama sta soffrendo un po’ sotto l’offensiva delle immagini macho che Putin ama far girare. Vladimir che cavalca a torso nudo, nuota in un lago siberiano, si immerge in un mini-batiscafo, spara a una balena da un gommone, si esibisce in mosse di judo e altre pagliacciate classiche dei dittatori di modesta statura.
Obama deve aver deciso di contrattaccare.
Negli ultimi mesi della sua presidenza credo che assisteremo ad altre gesta degne di essere tramandate, messe ormai da parte le promesse di HOPE e CHANGE che hanno per due volte portato Obama alla Casa Bianca.
Intanto il Paese non è mai stato così spaccato da tensioni razziali, diviso profondamente sull’accordo con l’Iran, confuso dalla continua immunità accordata a Hillary Clinton e spaventato per l’instabilità delle borse.
C’è da dire che anche l’arci-rivale Putin, nonostante lo stato preoccupante dell’economia russa, non ha smesso un attimo di fare l’uomo forte e di provocare l’occidente.

Ago 18, 2015 | The Blog
 Accountability è una parola inglese che si rivela spesso difficile da tradurre, visto che il primo termine italiano che viene in mente è responsabilità. Sì, ma allora come si traduce responsibility?
Accountability è una parola inglese che si rivela spesso difficile da tradurre, visto che il primo termine italiano che viene in mente è responsabilità. Sì, ma allora come si traduce responsibility?
Diciamo che, come di consueto, il contesto in cui viene usata la parola fa la differenza (e, di fatto, questo vale per tutte le parole). Estrapolata accountability dal contesto, una traduzione meno vaga di responsabile può essere: tenuto a rendere conto di.
Dove responsible sottintende spesso una responsabilità morale per qualcosa, accountable vuol dire che se ne pagheranno personalmente le conseguenze. Ci possiamo sentire responsabili di qualcosa (“se avessi risposto alla sua telefonata, non si sarebbe suicidato”) pur non essendo chiamati a renderne conto.
Un ministro dei beni culturali è accountable per il progressivo decadimento di Pompei, o almeno lo sarebbe in un’ottica aziendale. Se sei il direttore di produzione, dovrai rendere conto personalmente per una linea di produzione che si ferma per carenze di manutenzione. Quando si parla di governi e politica, però, le certezze diventano molto più sfumate.
Accountability è un concetto molto importante nei Paesi anglosassoni, il che non significa che tutti siano pronti ad accollarsela.
Guardate il caso Clinton, che occupa da mesi le prime pagine dei giornali.
Hillary Clinton è un’esperta nell’arte di viaggiare sull’orlo dell’illegalità e una bugiarda consumata, come più volte dimostrato durante i suoi 8 anni come first lady americana e in seguito come Segretario di Stato sotto Obama, un’Amministrazione che non brilla affatto per trasparenza nonostante le facili promesse elettorali.
Intrighi, prevaricazioni, corruzione, depistaggi e menzogne hanno sempre accompagnato la carriera di Hillary. C’è chi vuole che, ancora prima di fregiarsi del cognome Clinton sposando Bill nel 1975, Hillary Rodham avesse già brillato per le sue “bugie e il comportamento poco etico”.
Dal momento in cui è diventata Segretario di Stato, la Clinton ha sempre utilizzato un suo indirizzo di posta personale e non quello del Dipartimento di Stato, come richiesto dalle regole. Il suo server di posta era situato presso la sua residenza nello Stato di New York e inaccessibile a estranei.
Questo ha creato notevoli preoccupazioni per la sicurezza dell’account sia nel campo avversario che nel Dipartimento di Stato e anche nel suo partito. Inoltre, il fatto che lei abbia provveduto a cancellare dal server 30.000 mail che ha definito “private” non aiuta particolarmente a crederle, visto che sono forti i sospetti che Clinton abbia costantemente sfruttato la sua posizione di capo della diplomazia USA (e la quarta autorità dopo il presidente) per incassare cifre iperboliche in cambio di “accessibilità” da parte di interessi privati. Il libro Clinton Cash di Peter Schweizer solleva una serie di quesiti inquietanti—ma apparentemente non per i Clinton, che sostengono si tratti dei soliti attacchi di parte.
Ora che Hillary è la front runner dei democratici nelle elezioni presidenziali 2016, tutti i nodi stanno venendo al pettine e il suo server è in mano all’FBI. Non c’è alcun ragionevole dubbio sul fatto che lei sia accountable per tutto quanto sopra, ed è chiaro a tutti che i suoi tentativi di minimizzare o negare le sue responsabilità dirette (anche penali) la stanno alienando dal suo stesso partito.
Ben prima della nomination del candidato democratico, sono certo che assisteremo all’implosione della Clinton, una circostanza che è ormai inevitabile—e dovuta, aggiungo a titolo personale.
Il partito è fortemente preoccupato (anzi, per molti sarebbe già in pieno panico) per la possibilità che i misfatti della Clinton vengano rivelati e lei sia messa in stato di accusa in un momento successivo alla sua nomination.
Questo la squalificherebbe come candidata e avvantaggerebbe enormemente i repubblicani. Ecco perché nel partito democratico è partita la ricerca frenetica di altri candidati alla nomination che siano più accettabili del socialista settantaduenne Bernie Sanders, oggi l’unico a poter competere con la Clinton a livello di supporto popolare.
L’accountability è una cosa seria e la Clinton sta per scoprirlo alla tenera età di 67 anni.

Lug 6, 2015 | The Blog
In Grecia hanno vinto i NO.
Ma che cosa hanno vinto?
- I bancomat continuano a centellinare Euro e le file di correntisti non sono diventate più corte di prima. Tra qualche giorno, se non si trova rimedio, le banche avranno finito i soldi e staccheranno la spina ai bancomat.
- Varoufakis se n’è andato. Aveva annunciato le dimissioni se avessero vinto i SI, ma evidentemente non c’era più posto per lui nemmeno dopo la vittoria dei NO. Tsipras lo ha fatto saltare come un fusibile per poter riprendere il dialogo con la troika UE, FMI e BCE che Varoufakis aveva irritato dal primo giorno.
Dopotutto, prestare soldi a uno spiantato e sentirsi dare del “terrorista” quando li rivuoi indietro può essere irritante.
- Dice Tsipras che ha vinto la democrazia. Ma la democrazia è un concetto e i concetti non tremano per i risparmi che hanno messo in banca. Democrazia (la parola è greca, lo sanno tutti) vuol dire governo del popolo. Ed è il popolo, invece, che trema (e fa bene) per quella manciata di Euro che ha sul conto. E’ lo stesso popolo che, tramite i suoi rappresentanti democraticamente eletti, ha indebitato il Paese fino alla rovina e accettato il salvagente europeo 5 anni fa. Ora il popolo, che ha praticamente perso tutto, avrebbe vinto?
 I sostenitori di Syriza e tutti quelli che hanno votato NO hanno vinto una serata di canti e balli in centro ad Atene, con i tamburi, i fischietti, le trombe da stadio e le bandiere. Come in tutte le belle manifestazioni della sinistra o quando l’Olympiakos vince lo scudetto. Chi ha votato NO lontano dalla capitale avrà visto la festa dalla TV di casa o al kafeneion. Peccato. In Piazza Syntagma avrebbe avuto la fortuna di incontrare Grillo, Vendola e altri ammiratori di Tsipras in trasferta ad Atene per brillare di luce riflessa e testimoniare che anche i falliti possono divertirsi.
I sostenitori di Syriza e tutti quelli che hanno votato NO hanno vinto una serata di canti e balli in centro ad Atene, con i tamburi, i fischietti, le trombe da stadio e le bandiere. Come in tutte le belle manifestazioni della sinistra o quando l’Olympiakos vince lo scudetto. Chi ha votato NO lontano dalla capitale avrà visto la festa dalla TV di casa o al kafeneion. Peccato. In Piazza Syntagma avrebbe avuto la fortuna di incontrare Grillo, Vendola e altri ammiratori di Tsipras in trasferta ad Atene per brillare di luce riflessa e testimoniare che anche i falliti possono divertirsi.
Alla tipa che nella foto sventola con voluttà la bandiera greca darei appuntamento tra sei mesi. Ci vediamo a Plateia Syntagmatos ad Atene e ci prendiamo un caffè. Così mi dici esattamente che cosa hai vinto e che cosa ti ha portato il referendum inutile di Tsipras.
Aggiornamento dell’11/07/2015
Qualcuno mi aiuti a capire perché temo di essermi perso qualcosa.
Dopo aver “vinto” il referendum contro le misure di austerità, Tsipras ha fatto in extremis una serie di proposte all’Europa che somigliano fortemente a quel piano che aveva invitato i greci a respingere nemmeno una settimana prima. Al punto che, nel copia e incolla, qualcuno non si è accorto che comparivano ancora le date del documento precedente. Per i greci, le misure di austerità sono altrettanto se non più pesanti. E queste il parlamento le ha votate in poche ore, anche se in casa Syriza c’è un po’ di trambusto. Li capisco, anche loro hanno la sensazione di essersi persi qualcosa.
Il narcisista Varoufakis—che aveva promesso supporto totale al suo successore Tsakalotos—al momento di votare il piano in parlamento era assente. L’hanno fotografato poche ore prime mentre prendeva il traghetto per l’isola di Egina, dove ha una casa. Ubi maior…
La farsa greca fa ridere molti, ma milioni di persone nel Paese non la trovano affatto divertente. La Grecia è allo stremo e la povera gente non è mai stata così povera.
Chissà che pensano ora quelli che solo qualche giorno fa facevano i girotondi in Piazza Syntagma con le bandiere dell’OXI. Quelli che hanno vinto, per intendersi…Hanno detto di no ad un pacchetto di misure pesanti per vedersene imposto un altro più pesante (stavolta senza referendum).
 La copertina di Panorama della scorsa settimana riassume per me in una sola parola il quadro che sto osservando. Ma la vicenda non è ancora chiusa.
La copertina di Panorama della scorsa settimana riassume per me in una sola parola il quadro che sto osservando. Ma la vicenda non è ancora chiusa.
Mentre gli “amici della Grecia” (Francia, Italia, Malta, Cipro) si sono dichiarati favorevoli al terzo salvataggio di Atene, il silenzio della Germania lascia pensare al peggio. Ma sarà veramente il peggio tagliare i cavi di ormeggio della Grecia e lasciarla andare per la sua strada con Syriza al timone? Qualcuno crede alla capacità (o alle intenzioni) di Tsipras di tener fede agli impegni con una coalizione che fa acqua da tutte le parti e la sua etica da saltimbanco? In altre parole, la comprereste da Tsipras un’auto usata? O la tanto celebrata moto di Varoufakis?

Lug 2, 2015 | The Blog
 Che il partito greco Syriza fosse una manica di incapaci è un sospetto che molti hanno avuto da quando è andato al governo. Adesso, il suo massimo esponente e primo ministro greco, Alexis Tsipras, lo riconferma con i fatti. Da una parte si dichiara aperto a trattare con i creditori ma al tempo stesso invita i greci a respingere in un referendum popolare l’”estorsione” di un’Europa che chiede ad Atene ulteriori sacrifici in cambio di un nuovo salvataggio in extremis.
Che il partito greco Syriza fosse una manica di incapaci è un sospetto che molti hanno avuto da quando è andato al governo. Adesso, il suo massimo esponente e primo ministro greco, Alexis Tsipras, lo riconferma con i fatti. Da una parte si dichiara aperto a trattare con i creditori ma al tempo stesso invita i greci a respingere in un referendum popolare l’”estorsione” di un’Europa che chiede ad Atene ulteriori sacrifici in cambio di un nuovo salvataggio in extremis.
Tsipras ha esortato energicamente a votare NO per permettergli di affrontare a muso duro—perché legittimato dalla piazza—il fronte dei creditori. Il suo ministro delle finanze Varoufakis ha perfino promesso di dimettersi se vincerà il SI di coloro che sono disposti ad accettare le richieste europee. Staremo a vedere, al voto mancano solo pochi giorni.
Viene spontaneo domandarsi a che cosa serva alla Grecia un governo che passa la palla alla popolazione quando si tratta di decidere il futuro del Paese. Riusciranno i greci a ragionare serenamente su quello che conviene loro nel medio-lungo termine? O si faranno trascinare dall’euforia rivoluzionaria e dall’arroganza del team Syriza?
In Grecia, decenni di populismo e finanza allegra hanno portato la nazione sull’orlo del fallimento. Una vittoria dei NO condurrà probabilmente alla fuoriuscita di Atene dall’Euro, con conseguenze devastanti sull’economia del Paese. Sebbene pesante, l’ulteriore inasprimento del rigore fiscale richiesto dall’Europa sarebbe una soluzione meno rischiosa perché più controllabile. Se vinceranno i SI, le dimissioni di Varoufakis saranno una pura formalità, visto che l’Europa chiederà a quel punto di trattare con altri interlocutori al governo.
Nel frattempo, si sono moltiplicate nel mesi scorsi le richieste fatte alla Germania di indennizzare la Grecia per i danni di guerra subiti nel periodo 1941-1944. Si tratta, secondo una fantasiosa stima greca, di quasi 280 miliardi di Euro, mentre (guarda caso) l’aiuto finanziario esteso alla Grecia nel 2010—e che il Paese non riesce a ripagare—ammontava a 240 miliardi. In altre parole, la Grecia avrebbe un credito di 40 miliardi di Euro—cifra che, vista la recente performance di Tsipras e Varoufakis, il Paese troverebbe il modo di dilapidare in pochi mesi.
Ad Atene sostengono che richiedere i danni di guerra proprio mentre si discute il debito con l’Europa sia solo una coincidenza, affermando che quella richiesta costituisca per l’attuale governo un “dovere storico”. Un dovere che, evidentemente, la Grecia si era dimenticata di esercitare per 50 anni.
La posizione greca è stata condita con virulente campagne di stampa antitedesche, con il prevedibile ricorso alle analogie tra il cancelliere tedesco di oggi e i nazisti di ieri.
L’unico effetto sortito, però, sembra essere stato un calo dei turisti tedeschi in Grecia. In un Paese dove il contributo del turismo all’economia è dell’ordine del 17%, ci si domanda se Tsipras e compagni non abbiano esagerato con i bicchierini di ouzo.
Il vero problema dei danni di guerra subiti dalla Grecia è che la Germania ha già da decenni concordato e saldato la pendenza, pagando 115 milioni di marchi negli anni 60.
Il compenso pagato a suo tempo “non basta”, sostengono i greci, perché non avrebbe tenuto pienamente conto delle atrocità commesse dai tedeschi in Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale. Ad Atene, qualcuno ha redatto una lista dei danni subiti per mano tedesca e ci ha messo a fianco una valutazione economica.
Anche l’Italia ha saldato alla Grecia i danni di guerra causati dalla sua invasione del 1941. Nel Trattato di Parigi del 1947, la cifra fu fissata in 105 milioni di dollari di allora, più la cessione del Dodecaneso, che apparteneva all’Italia dal 1912. Ma se ad Atene il piatto piange, c’è sempre la possibilità che il governo venga a bussare anche alla porta dell’Italia per un’integrazione delle riparazioni. Dopotutto, le atrocità commesse dall’esercito italiano in Grecia sono ben documentate, anche se la nostra opinione pubblica ha sempre preferito credere alla versione di essere stati “brava gente” durante la scampagnata ellenica.
Magari in qualche ministero greco qualcuno sta già lavorando al conto da presentare a Renzi.

Giu 28, 2015 | The Blog
 Qualche giorno fa, parlando di Internet, Umberto Eco ha detto: “I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. E’ l’invasione degli imbecilli”. E ancora: “La tv aveva promosso lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Il dramma di Internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità”.
Qualche giorno fa, parlando di Internet, Umberto Eco ha detto: “I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. E’ l’invasione degli imbecilli”. E ancora: “La tv aveva promosso lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Il dramma di Internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità”.
Per rendersi conto di quanto siano vere le parole di Eco, basta andare a leggere i commenti che appaiono in rete nei siti che non vagliano i contributi degli internauti. Senza andare troppo lontano, basterà dare una rapida occhiata ai commenti dei lettori proprio in calce alle dichiarazioni di Umberto Eco sul sito dell’ANSA. E magari si potrebbe anche estendere la ricerca ai commenti che compaiono anche negli altri articoli dell’agenzia. Ne prendo uno a caso, quello dell’uomo incornato e ucciso da un toro in Spagna. Sono 120 commenti a tutt’oggi e che vi invito a leggere se troverete il coraggio.
Umberto Eco ha ragione. L’imbecille, emarginato e inascoltato appunto perché tale, trova la sua redenzione online. E alle sue esternazioni idiote rispondono altri come lui.
Chi fosse preoccupato per la sorte degli imbecilli, si rassereni: essi non sono in via di estinzione. Anzi.
Lo testimoniano sia la vacuità che il numero dei loro commenti. Alcuni si compiacciono di pubblicare e difendere ad oltranza tesi contrarie al buon senso e cercano lo scontro virtuale con i paladini dell’ovvio, questi ultimi invece cercano di far ragionare gli imbecilli—un’altra operazione priva di senso. I toni diventano accesi e le parole si fanno più pesanti, finché si finisce in rissa.
Un anno fa, sempre su questo blog, ho citato una curiosa “legge”, la Godwin’s Law.
Mike Godwin è un autore e avvocato americano che ben 25 anni fa ha coniato questa strana legge: “Al moltiplicarsi dei commenti in una discussione online, aumenta la probabilità che qualcuno cominci a fare paragoni con Hitler e i nazisti”.
E’ pressoché inevitabile che, nelle risse virtuali, venga prima o poi invocato il nome di Hitler o del suo partito a indicare l’intolleranza verso le tesi altrui.
La soluzione? Invece di pubblicare commenti di un paio di righe banali o sballati, chi ha qualche imbecillità da dire faccia uno sforzo in più: scriva un blog. Proprio come ho fatto io.

 Ogni giorno i titoli dei giornali ci riportano le notizie di ulteriori atrocità perpetrate in nome della religione ed è ormai inevitabile associare le parole fondamentalismo o terrorismo all’aggettivo islamico.
Ogni giorno i titoli dei giornali ci riportano le notizie di ulteriori atrocità perpetrate in nome della religione ed è ormai inevitabile associare le parole fondamentalismo o terrorismo all’aggettivo islamico.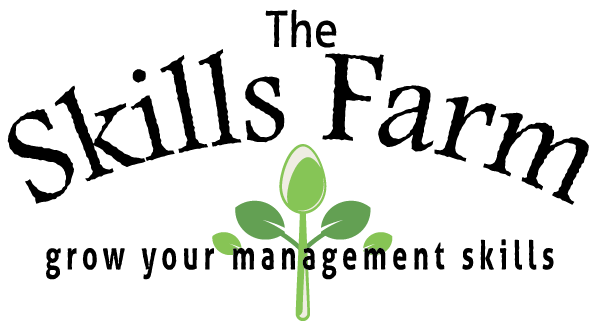





 I sostenitori di Syriza e tutti quelli che hanno votato NO hanno vinto una serata di canti e balli in centro ad Atene, con i tamburi, i fischietti, le trombe da stadio e le bandiere. Come in tutte le belle manifestazioni della sinistra o quando l’Olympiakos vince lo scudetto. Chi ha votato NO lontano dalla capitale avrà visto la festa dalla TV di casa o al kafeneion. Peccato. In Piazza Syntagma avrebbe avuto la fortuna di incontrare Grillo, Vendola e altri ammiratori di Tsipras in trasferta ad Atene per brillare di luce riflessa e testimoniare che anche i falliti possono divertirsi.
I sostenitori di Syriza e tutti quelli che hanno votato NO hanno vinto una serata di canti e balli in centro ad Atene, con i tamburi, i fischietti, le trombe da stadio e le bandiere. Come in tutte le belle manifestazioni della sinistra o quando l’Olympiakos vince lo scudetto. Chi ha votato NO lontano dalla capitale avrà visto la festa dalla TV di casa o al kafeneion. Peccato. In Piazza Syntagma avrebbe avuto la fortuna di incontrare Grillo, Vendola e altri ammiratori di Tsipras in trasferta ad Atene per brillare di luce riflessa e testimoniare che anche i falliti possono divertirsi.



