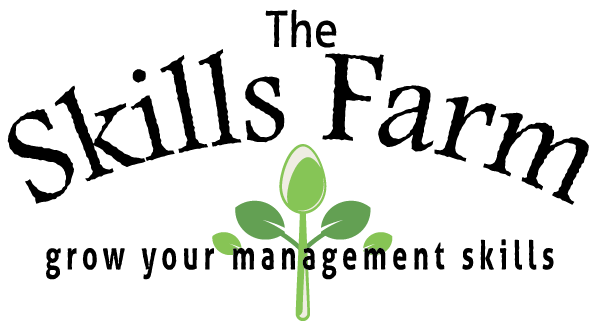Dic 4, 2009 | The Blog

Non parlo Arabo, a parte due o tre formule di saluto, e al massimo so riconoscere in una conversazione quello che ho sentito definire “l’IBM egiziana”, cioè Insh’allah, Bokra, Maalesh. In altre parole, Se Dio vuole, Domani, Poco male. (Da non prendere letteralmente. La frase può voler dire: io non ci posso fare niente, magari si sistema da sé domani, pazienza.)
Armato di questo minuscolo bagaglio a mano linguistico e non sapendo leggere la scrittura araba, l’idea di poter girare per il Cairo e dintorni in maniera autonoma per un’intera settimana di lavoro non mi era nemmeno passata per la testa.
“Prendo il taxi” mi ero detto. E infatti, uscito dall’albergo sulle sponde del Nilo (quello che una volta era il glorioso Hotel Semìramis), mi trovo davanti una fila di taxi scassati e un gruppetto di tassisti in agguato.
Chiarite le mie intenzioni (ho sei appuntamenti nel corso della giornata), si offre volontario un certo Mohammed e mi fa strada verso la sua vettura, una Fiat 1100 degli Anni 50 tenuta insieme dalla vernice bianca e nera. Il personaggio ha circa 35 anni, due baffoni da carabiniere del secolo scorso e una faccia da simpatica canaglia. Partiamo.
Mohammed conosce sì e no cento parole di Inglese e gli indirizzi preferisce vederli scritti piuttosto che sentirli pronunciare da me. Non posso dargli torto. Ma il nostro lavoro di squadra procede perfettamente. Io scendo dal taxi per andare al mio appuntamento e Mohammed mi aspetta dormendo nell’auto parcheggiata all’ombra.
Torniamo alla base che è ormai buio. Mohammed mi dà mezz’ora per cambiarmi e poi mi porta a un ristorante-showboat che offre giri turistici lungo il Nilo con musica e spettacolo. Ho voglia di fare il turista e sono accontentato: mi ritrovo tra Inglesi che ballano con i dervisci e Giapponesi che fotografano tutto.
Due ore dopo, mentre ormai medito il suicidio, il battello accosta al suo ormeggio: nella luce dei lampioni scorgo una testa appoggiata al volante della Fiat 1100 parcheggiata a bordo strada.
Mentre mi congedo da Mohammed davanti all’albergo, lui mi chiede: “Dumorroh, visit gombany again?”
Perché no? Ormai siamo un team. Gli rispondo: “OK, Mohammed. See you tomorrow, right here, eight o’clock”, mentre indico per terra e gli mostro otto dita a titolo illustrativo.

Moschea di Al-Azhar, presso il souq di Khan el-Khalili
E così andiamo avanti per il resto del mio soggiorno al Cairo. Ci spingiamo fino a 10th of Ramadan City (un insediamento industriale a Nord-Est del Cairo sulla strada per Ismailia) e a 6th of October City, che si trova invece a Sud-Ovest della metropoli (*).
Ormai la collaborazione con Mohammed è consolidata. Lui pilota l’anziana Fiat a colpi di clacson nel traffico cittadino o lungo le statali, io siedo sul sedile posteriore e consulto le mie carte prima di ogni appuntamento.
L’ultimo giorno, Mohammed mi accompagna all’aeroporto e mi chiede se ho intenzione di ritornare in Egitto nel prossimo futuro. In effetti, ho in programma una seconda visita tra qualche settimana e glielo dico.
Mohammed si illumina; sono stato un buon cliente. “Very good, very good. See you in Cairo more later, insh’allah . You telephone me when you know day.” e mi porge un biglietto da visita.
Le mie scorribande egiziane nel taxi di Mohammed sono appena iniziate e ve le racconterò più avanti.
(*) Il significato di queste date la dice lunga: il 6 Ottobre 1973, che corrisponde al decimo giorno del Ramadan, segna l’inizio della Guerra del Kippur, con l’attacco a sorpresa della coalizione Egitto-Siria per la riconquista dei territori occupati da Israele nella Guerra dei Sei Giorni di sei anni prima. Anche se, dopo le iniziali vittorie arabe, la reazione israeliana riuscì a respingere sia i Siriani che gli Egiziani, la guerra del 1973 è considerata in Egitto una pagina gloriosa.

Dic 1, 2009 | The Blog

New Mexico, USA, fine di Maggio. Il tracciato della vecchia Route 66 attraversa un tratto desertico dalla terra rossa che segue il letto di un fiume in secca e si estende all’infinito nell’aria tremolante per il calore. Il fondo stradale è in pessime condizioni, ma è quello autentico della leggendaria strada americana: The Mother Road, da Chicago a Los Angeles in 2.400 miglia. A poca distanza, carica di traffico, corre la Interstate 40 che qui l’ha ormai soppiantata da decenni e già da quasi un’ora non ho diviso la strada con nessuno.
Alla mia destra vedo i resti di un vecchio ponte della ferrovia, molti dei piloni in legno sono crollati e quelli ancora in piedi sembrano un gruppo di ubriachi. Mi tornano alla mente mille scene di film western, con il treno a vapore che arriva sferragliando sul singolo binario mentre dai piloni del ponte penzolano le micce sfrigolanti della dinamite.
Mentre mi fermo a scattare un paio di foto, all’orizzonte appare una nuvola di polvere. In pochi minuti arriva un vecchio pick-up con due uomini a bordo. Si fermano a fianco della mia Ford noleggiata e il guidatore apre il finestrino. È un uomo sulla quarantina con un berretto da baseball e strizza gli occhi contro il sole. “Problemi alla macchina?” mi chiede.
“No – gli rispondo – sto facendo un po’ di foto.”
“Sei anche tu uno di quei matti che si fanno tutta la Old 66 fino a LA per il solo gusto di farla?”

Confesso la mia colpa e racconto loro di essere addirittura venuto apposta dall’Europa. Si guardano ridendo e scuotono la testa. “Senti, se ti va di bere qualcosa di fresco, seguici fino al ranch qui dietro la curva.”
Accetto volentieri. Sebbene sia ormai abituato all’ospitalità immediata di molti Americani, questa volta rimango stupito. L’Europeo in me si chiede anzi se sia cosa saggia seguirli “dietro la curva” carico di macchine fotografiche e dollari in contante.
Ma siamo già arrivati. Il ranch è una casetta squadrata come la disegnerebbe un bambino; a fianco sorge un capannone con un paio di trattori, niente a che vedere con i pittoreschi fienili in legno che ancora si trovano dappertutto in America. C’è un pozzo artesiano, qualche bidone di olio, due macchine parcheggiate e il resto è sabbia e collinette rocciose che si spingono fino all’orizzonte.
In questo mare di colore ocra, vedo lontano una macchia verde, come un’oasi nel deserto.
“È un vecchio pozzo che usava la US Cavalry per abbeverare i cavalli”, mi legge nel pensiero l’amico del pick-up mentre mi porge una lattina di birra imperlata di condensa. “Qui non c’è un gran che ma se ti fermi, domani possiamo fare un giro a cavallo.”
Lo ringrazio, ma spiego che devo continuare fino a Flagstaff in Arizona. “OK, come vuoi”, mi dice. Gli Americani non insistono quasi mai, visto che loro stessi raramente dicono “no grazie” solo per fare complimenti.
L’amico sparisce nel ranch e ritorna dopo un minuto con un six-pack di birre Coors Extra Gold gelate. “Mettile al fresco” mi dice. Deve aver visto il cooler di plastica che ho comprato al Wal-Mart per pochi dollari. Se attraversi l’America senza averne uno, devi essere per forza uno straniero alla sua prima visita.
“Come back anytime, y’hear?” mi salutano lui e il suo amico, mentre salgo in macchina.
Dopo pochi secondi il ranch sparisce nella nuvola di polvere che mi lascio dietro. Ora sono di nuovo sulla Route 66 con la mia Ford bianca velata di polvere rossa mentre, armato di una Reflex e 6 birre gelate, inseguo un obiettivo che si sposta con l’orizzonte. Mai come questa volta la mia destinazione è la strada stessa.

Nov 29, 2009 | The Blog
Se la misura della civiltà di un paese è data dallo stato dei gabinetti pubblici e dalla segnaletica, cari amici in Italia siamo messi male.
Se avete il coraggio, entrate al WC di un aeroporto per verificarne lo stato di degrado.
Ma dove sono i gabinetti? Già, non si vede nessun cartello.
No problem, seguite la puzza. Piastrelle rotte, asse divelto, niente carta, la chiusura della porta è difettosa.
Il poverino che deve sedersi fa bene a tenere una gamba tesa a bloccare la porta altrimenti può entrare qualcuno distratto che gli si siede sopra e si libera.
Poi andate in un aeroporto del terzo mondo e trovate che i bagni sono in condizioni migliori. Viene proprio da pensare.
E la segnaletica? L’Italia deve essere il primo paese al mondo per le vendite di GPS, perché girare senza non si può. Chi segue i cartelli é perduto. Chi chiede informazioni per strada è perduto (la gente ormai sa solo dove abita, dove lavora e dov’ è quello che fa la pizza al taglio).
 Oggi mi sono avventurato in moto nel comune di Castellanza, una di quelle cittadine attorno a Milano che se le vedi dall’alto dici: ma quella è ancora Milano.
Oggi mi sono avventurato in moto nel comune di Castellanza, una di quelle cittadine attorno a Milano che se le vedi dall’alto dici: ma quella è ancora Milano.
Dalla Madunina a Castellanza non trovi nemmeno venti metri di campagna, però cambi comune almeno sei volte, anche se ti sembra di essere sempre nella stessa città. E io da mezz’ora cerco una strada e non la trovo.
Ti vedo un vigile urbano su una BMW F650, mi affianco e gli chiedo informazioni. Neanche lui sa dov’é questa strada.
Indosso il casco integrale ma lui evidentemente ha capito lo stesso che sto ridendo.
Si giustifica allora: “Sa, io sono di Olgiate Olona”, che è un’altra parte di pseudo-Milano a cento metri da Castellanza, il tutto prima di arrivare a Chiasso, dove allora finisce veramente Milano perché sei in Svizzera.
Nel frattempo, cartelli su cartelli su cartelli. I pali si piegano sotto il peso dei cartelli. “Agriturismo La Raffineria”, “Cucina Emiliana da Ahmed”, “Concessionaria Yamazuki,” “Centro Estetico Rosi Bindi”, “Centro Revisioni T.A. Rocchi”.
Poi, il miracolo! Leggo l’ennesimo cartello: “Brauerei Marocchina Alexanderplatz –200 m a sinistra” e sotto vedo scritta la via che sto cercando. Ce l’ho fatta, ma solo grazie al segnale commerciale.
Giro a sinistra, ma la targa con il nome della via naturalmente sui palazzi non c’é, o forse è coperta da altri cartelli.
In Italia la segnaletica che non manca mai è quella assurda dei nomi in dialetto. Ma chi se ne frega che gli abitanti di Buguggiate la chiamano Bügügià. E chi se ne strafrega che Rho è Comune per la Pace.
Eh sì, perché tu metti su un cartello e hai fatto la tua parte per la pace nel mondo. Comodo, no?

Nov 28, 2009 | The Blog

Manco da Hong Kong da due anni.
Dopo aver visitato questo posto incredibile almeno due volte l’anno per sei anni di fila, un’assenza come questa è pesante. Hong Kong ti provoca assuefazione e ne senti la mancanza a livello fisico.
Chi la conosce forse sa di che cosa sto parlando. A chi non c’è mai stato dico solo che non si tratta di iperbole, ma di una necessità reale.
Di Hong Kong conosco bene i migliori alberghi ma anche le anguste fabbriche “verticali” che ancora non sono state trasferite oltre il confine in Cina. Queste ultime alloggiano in fatiscenti strutture multipiano di età indecifrabile e utilizzano vecchi macchinari in ambienti malmessi e sicuramente fuori norma. Ho visto di peggio solo in India. Ma a Hong Kong non esistono locali vuoti: dovunque c’è spazio ci trovi qualcuno che lavora.
Gli alberghi, invece, ti aspettano con la promessa di pace, tranquillità e una birra gelata al termine di una giornata intensa consumata rincorrendo appuntamenti a destra e a manca a Kowloon o sull’isola di Hong Kong vera e propria, oppure nell’adiacente provincia cinese del Guangdong, le cui distanze spesso ti ingannano. Quello che sulla carta sembra un tragitto di due ore, spesso si rivela un’intera giornata di macchina.
Hong Kong, con le sue luci e l’incredibile skyline in costante mutamento, è il premio per chi rientra da una lunga giornata di lavoro. Spesso quello che ti scarica le pile è il continuo passaggio dall’opprimente caldo umido all’aria condizionata più brutale. Si arriva all’appuntamento di lavoro bagnati di sudore nei nostri vestiti occidentali inadatti a quel clima, si passa qualche minuto in sala d’attesa con il condizionatore che va a mille mentre si cerca di riprendere un aspetto presentabile.
La riunione è di solito piuttosto rapida, dopo trenta minuti si è di nuovo in strada e l’impatto del calore in agguato è solido come un muro.
Ancora cinque minuti di cammino e, in un vagone dell’impeccabile metropolitana di Hong Kong, il getto dell’aria condizionata non perdona. Poi, arrivati a Tsim Sha Tsui o a Wan Chai, dove sorgono gran parte degli alberghi più blasonati, ti resta l’ultimo tratto a piedi prima di essere ingoiato da corridoi freschi e silenziosi dove i tuoi piedi stanchi strisciano felpati verso la camera.

Una doccia e sei di nuovo in strada, questa volta vestito in maniera più pratica, alla ricerca di qualche acquisto, di uno scorcio inedito da fotografare e certamente di un ristorante dove concludere la serata. Hong Kong, con il traffico, il rumore, i violenti contrasti e i mille odori (non tutti gradevoli) non ti delude mai e ti attira implacabile come un campo gravitazionale.
E ogni tanto, a intervalli regolari come la malaria, ti prende la scimmia di ritornarci.

Nov 28, 2009 | The Blog

La brevità del volo non deve ingannare: la Libia è vicina ma è sempre Terzo Mondo.
Una volta nel terminal aeroportuale di Tripoli, l’attesa al controllo passaporti è interminabile.
Ma c’è un buon motivo: in fila si mettono solo gli sprovveduti, quelli che entrano in Libia per la prima volta.
Nella zona arrivi girano diversi faccendieri, che raccolgono i passaporti dei viaggiatori abituali affidatisi alle loro cure, ne fanno un bel mucchio e poi, passando sfacciatamente davanti alla fila, li piazzano sul banco del funzionario (che li esamina subito facendo aspettare tutti gli altri, in cambio sicuramente di un congruo corrispettivo in denaro).
Ma non vi azzardate a superare di un centimetro la riga gialla che separa il primo della fila dal banco del funzionario. Lui è inflessibile e vi riprenderà severamente, mentre un altro piccolo imprenditore locale entra nella garitta e gli consegna un’altra dozzina di passaporti VIP.
L’assurdità della situazione gli sfugge del tutto, mentre con sguardo torvo fissa il passaporto del “privatista”, che dopo due ore di attesa è finalmente arrivato alla meta.
Per la prima ora, mentre la fila sembra non muoversi di un centimetro, sul piazzale si vede ancora l’aereo che ti ha portato in Libia e più volte ti prende la voglia di tornare indietro e lasciarti alle spalle questo misto di arroganza e ignoranza che pochi altri paesi sanno esprimere in maniera così sublime come la Libia.
Poi, raccolto il bagaglio e usciti all’aperto, parte la solita ricerca della persona che porta il cartoncino con sopra il tuo nome.
Il mio contatto si chiama Ali, parla molto bene l’Italiano e sarà il mio interprete e autista in cinque giorni di ricerca di opportunità di mercato per la mia azienda.
In Libia non ci sono elenchi del telefono o pagine gialle, mentre le directory su Internet sono una totale perdita di tempo. Se vuoi sapere chi fa che cosa, devi prendere una macchina e iniziare a girare per Tripoli e Bengasi con qualcuno che conosca il paese e parli la lingua. E’ una ricerca capannone per capannone, basata sul sentito dire e su indicazioni frammentarie, una mangiata di polvere e di chilometri inutili.
Ma dopo cinque giorni, tanta strada e altrettanta frustrazione, mi rimane mezza giornata di tempo e mi regalo finalmente una visita alla zona archeologica di Leptis Magna. Ali è ben felice di portarmici: anche per lui è una reazione alla futilità degli ultimi giorni.
D’improvviso, la sporcizia, la puzza, la polvere, l’inconcludenza e la birra senza alcol spariscono per magia. L’incredibile bellezza di questa città romana affacciata sul mare mi ripaga di tutto.
Mentre l’aereo si solleva dalla pista di Tripoli, non ho rimpianti di alcun genere. Ma un giorno vorrei tornare a Leptis Magna e percorrere di nuovo le sue strade lastricate e guardare il suo mare attraverso le colonne.