
Nov 29, 2009 | The Blog
Se la misura della civiltà di un paese è data dallo stato dei gabinetti pubblici e dalla segnaletica, cari amici in Italia siamo messi male.
Se avete il coraggio, entrate al WC di un aeroporto per verificarne lo stato di degrado.
Ma dove sono i gabinetti? Già, non si vede nessun cartello.
No problem, seguite la puzza. Piastrelle rotte, asse divelto, niente carta, la chiusura della porta è difettosa.
Il poverino che deve sedersi fa bene a tenere una gamba tesa a bloccare la porta altrimenti può entrare qualcuno distratto che gli si siede sopra e si libera.
Poi andate in un aeroporto del terzo mondo e trovate che i bagni sono in condizioni migliori. Viene proprio da pensare.
E la segnaletica? L’Italia deve essere il primo paese al mondo per le vendite di GPS, perché girare senza non si può. Chi segue i cartelli é perduto. Chi chiede informazioni per strada è perduto (la gente ormai sa solo dove abita, dove lavora e dov’ è quello che fa la pizza al taglio).
 Oggi mi sono avventurato in moto nel comune di Castellanza, una di quelle cittadine attorno a Milano che se le vedi dall’alto dici: ma quella è ancora Milano.
Oggi mi sono avventurato in moto nel comune di Castellanza, una di quelle cittadine attorno a Milano che se le vedi dall’alto dici: ma quella è ancora Milano.
Dalla Madunina a Castellanza non trovi nemmeno venti metri di campagna, però cambi comune almeno sei volte, anche se ti sembra di essere sempre nella stessa città. E io da mezz’ora cerco una strada e non la trovo.
Ti vedo un vigile urbano su una BMW F650, mi affianco e gli chiedo informazioni. Neanche lui sa dov’é questa strada.
Indosso il casco integrale ma lui evidentemente ha capito lo stesso che sto ridendo.
Si giustifica allora: “Sa, io sono di Olgiate Olona”, che è un’altra parte di pseudo-Milano a cento metri da Castellanza, il tutto prima di arrivare a Chiasso, dove allora finisce veramente Milano perché sei in Svizzera.
Nel frattempo, cartelli su cartelli su cartelli. I pali si piegano sotto il peso dei cartelli. “Agriturismo La Raffineria”, “Cucina Emiliana da Ahmed”, “Concessionaria Yamazuki,” “Centro Estetico Rosi Bindi”, “Centro Revisioni T.A. Rocchi”.
Poi, il miracolo! Leggo l’ennesimo cartello: “Brauerei Marocchina Alexanderplatz –200 m a sinistra” e sotto vedo scritta la via che sto cercando. Ce l’ho fatta, ma solo grazie al segnale commerciale.
Giro a sinistra, ma la targa con il nome della via naturalmente sui palazzi non c’é, o forse è coperta da altri cartelli.
In Italia la segnaletica che non manca mai è quella assurda dei nomi in dialetto. Ma chi se ne frega che gli abitanti di Buguggiate la chiamano Bügügià. E chi se ne strafrega che Rho è Comune per la Pace.
Eh sì, perché tu metti su un cartello e hai fatto la tua parte per la pace nel mondo. Comodo, no?

Nov 28, 2009 | The Blog

Manco da Hong Kong da due anni.
Dopo aver visitato questo posto incredibile almeno due volte l’anno per sei anni di fila, un’assenza come questa è pesante. Hong Kong ti provoca assuefazione e ne senti la mancanza a livello fisico.
Chi la conosce forse sa di che cosa sto parlando. A chi non c’è mai stato dico solo che non si tratta di iperbole, ma di una necessità reale.
Di Hong Kong conosco bene i migliori alberghi ma anche le anguste fabbriche “verticali” che ancora non sono state trasferite oltre il confine in Cina. Queste ultime alloggiano in fatiscenti strutture multipiano di età indecifrabile e utilizzano vecchi macchinari in ambienti malmessi e sicuramente fuori norma. Ho visto di peggio solo in India. Ma a Hong Kong non esistono locali vuoti: dovunque c’è spazio ci trovi qualcuno che lavora.
Gli alberghi, invece, ti aspettano con la promessa di pace, tranquillità e una birra gelata al termine di una giornata intensa consumata rincorrendo appuntamenti a destra e a manca a Kowloon o sull’isola di Hong Kong vera e propria, oppure nell’adiacente provincia cinese del Guangdong, le cui distanze spesso ti ingannano. Quello che sulla carta sembra un tragitto di due ore, spesso si rivela un’intera giornata di macchina.
Hong Kong, con le sue luci e l’incredibile skyline in costante mutamento, è il premio per chi rientra da una lunga giornata di lavoro. Spesso quello che ti scarica le pile è il continuo passaggio dall’opprimente caldo umido all’aria condizionata più brutale. Si arriva all’appuntamento di lavoro bagnati di sudore nei nostri vestiti occidentali inadatti a quel clima, si passa qualche minuto in sala d’attesa con il condizionatore che va a mille mentre si cerca di riprendere un aspetto presentabile.
La riunione è di solito piuttosto rapida, dopo trenta minuti si è di nuovo in strada e l’impatto del calore in agguato è solido come un muro.
Ancora cinque minuti di cammino e, in un vagone dell’impeccabile metropolitana di Hong Kong, il getto dell’aria condizionata non perdona. Poi, arrivati a Tsim Sha Tsui o a Wan Chai, dove sorgono gran parte degli alberghi più blasonati, ti resta l’ultimo tratto a piedi prima di essere ingoiato da corridoi freschi e silenziosi dove i tuoi piedi stanchi strisciano felpati verso la camera.

Una doccia e sei di nuovo in strada, questa volta vestito in maniera più pratica, alla ricerca di qualche acquisto, di uno scorcio inedito da fotografare e certamente di un ristorante dove concludere la serata. Hong Kong, con il traffico, il rumore, i violenti contrasti e i mille odori (non tutti gradevoli) non ti delude mai e ti attira implacabile come un campo gravitazionale.
E ogni tanto, a intervalli regolari come la malaria, ti prende la scimmia di ritornarci.

Nov 28, 2009 | The Blog

La brevità del volo non deve ingannare: la Libia è vicina ma è sempre Terzo Mondo.
Una volta nel terminal aeroportuale di Tripoli, l’attesa al controllo passaporti è interminabile.
Ma c’è un buon motivo: in fila si mettono solo gli sprovveduti, quelli che entrano in Libia per la prima volta.
Nella zona arrivi girano diversi faccendieri, che raccolgono i passaporti dei viaggiatori abituali affidatisi alle loro cure, ne fanno un bel mucchio e poi, passando sfacciatamente davanti alla fila, li piazzano sul banco del funzionario (che li esamina subito facendo aspettare tutti gli altri, in cambio sicuramente di un congruo corrispettivo in denaro).
Ma non vi azzardate a superare di un centimetro la riga gialla che separa il primo della fila dal banco del funzionario. Lui è inflessibile e vi riprenderà severamente, mentre un altro piccolo imprenditore locale entra nella garitta e gli consegna un’altra dozzina di passaporti VIP.
L’assurdità della situazione gli sfugge del tutto, mentre con sguardo torvo fissa il passaporto del “privatista”, che dopo due ore di attesa è finalmente arrivato alla meta.
Per la prima ora, mentre la fila sembra non muoversi di un centimetro, sul piazzale si vede ancora l’aereo che ti ha portato in Libia e più volte ti prende la voglia di tornare indietro e lasciarti alle spalle questo misto di arroganza e ignoranza che pochi altri paesi sanno esprimere in maniera così sublime come la Libia.
Poi, raccolto il bagaglio e usciti all’aperto, parte la solita ricerca della persona che porta il cartoncino con sopra il tuo nome.
Il mio contatto si chiama Ali, parla molto bene l’Italiano e sarà il mio interprete e autista in cinque giorni di ricerca di opportunità di mercato per la mia azienda.
In Libia non ci sono elenchi del telefono o pagine gialle, mentre le directory su Internet sono una totale perdita di tempo. Se vuoi sapere chi fa che cosa, devi prendere una macchina e iniziare a girare per Tripoli e Bengasi con qualcuno che conosca il paese e parli la lingua. E’ una ricerca capannone per capannone, basata sul sentito dire e su indicazioni frammentarie, una mangiata di polvere e di chilometri inutili.
Ma dopo cinque giorni, tanta strada e altrettanta frustrazione, mi rimane mezza giornata di tempo e mi regalo finalmente una visita alla zona archeologica di Leptis Magna. Ali è ben felice di portarmici: anche per lui è una reazione alla futilità degli ultimi giorni.
D’improvviso, la sporcizia, la puzza, la polvere, l’inconcludenza e la birra senza alcol spariscono per magia. L’incredibile bellezza di questa città romana affacciata sul mare mi ripaga di tutto.
Mentre l’aereo si solleva dalla pista di Tripoli, non ho rimpianti di alcun genere. Ma un giorno vorrei tornare a Leptis Magna e percorrere di nuovo le sue strade lastricate e guardare il suo mare attraverso le colonne.

Ott 28, 2009 | The Blog

Abu ‘abd-Allah Muhammad XII, ultimo sultano di Granada, fu costretto ad abbandonare la città nel Gennaio 1492 dopo che i Reali di Castiglia l’avevano cinta d’assedio da mesi. Cadeva così l’ultimo bastione islamico in Spagna. La Reconquista della Penisola Iberica si concludeva dopo ben 700 anni.
Mentre con la sua corte si allontanava dalla città diretto alla costa, il trentenne Muhammad si sarebbe voltato per l’ultima volta a guardare le mura dell’Alhambra, sulle quali già sventolavano le bandiere dei Reali di Spagna.
La leggenda dice che egli abbia pianto per aver perduto “il più bell’oggetto del mondo”, cioè la sua medina, quella splendida cittadella in pietra rossa che dominava Granada.
Secondo la stessa leggenda, sua madre, sicuramente un bel sergente maggiore, lo avrebbe schernito: “piangi come una donna quello che non sei stato capace di difendere come uomo”.
La località in cui tutto ciò sarebbe avvenuto oltre 500 anni fa si chiama ancora Suspiro del Moro ed è un valico a quota 860 m posto lungo quei 70 km di strada che separano la città di Granada dal mare.
Il bello è che tutto questo l’ho solo scoperto dopo essermi goduto in moto quella strada stupenda, stretta e tortuosa che dalla città andalusa si snoda fino al mare, offrendo panorami spettacolari quelle rare volte che si riesce ad alzare l’occhio dall’asfalto.
Il nome del passo mi aveva incuriosito e una rapida ricerca in Internet ha soddisfatto la mia voglia di sapere.
Che siate o meno appassionati di storia, se capitate da quelle parti non mancate di percorrere la A4050 tra Almuñécar (sulla costa) e Granada.
Se appunto fate la strada a salire, arrivati al Puerto del Suspiro del Moro saprete di essere quasi arrivati a Granada. Dalla strada ormai l’Alhambra non si vede più, ma se andate all’ultimo piano dell’Hotel Ibis e non c’è di mezzo un Media World o un McDonald’s, forse riuscirete ancora a scorgere un angolo di quelle torri rosse come le vide il Sultano in lacrime.

Ott 18, 2009 | The Blog
 Aeroporto di Karachi. Sto partendo per Lahore, capitale del Punjab e seconda città del Pakistan con 7 milioni di abitanti. Fatto il check-in del bagaglio mi resta solo una valigetta 24-ore ma l’inserviente dedicato alla Business Class della Pakistan International insiste per togliermela di mano e accompagnarmi alla saletta dove attenderò l’imbarco del volo. Nel resto del mondo ci sono i cartelli con scritto “Lounge” e basta seguirli per lasciarsi alle spalle il viavai e il frastuono degli aeroporti. Qui a Karachi, invece, un signore dall’aria solenne e dai baffoni che ricordano un sergente maggiore del Raj britannico vuole a tutti i costi farmi da scorta.
Aeroporto di Karachi. Sto partendo per Lahore, capitale del Punjab e seconda città del Pakistan con 7 milioni di abitanti. Fatto il check-in del bagaglio mi resta solo una valigetta 24-ore ma l’inserviente dedicato alla Business Class della Pakistan International insiste per togliermela di mano e accompagnarmi alla saletta dove attenderò l’imbarco del volo. Nel resto del mondo ci sono i cartelli con scritto “Lounge” e basta seguirli per lasciarsi alle spalle il viavai e il frastuono degli aeroporti. Qui a Karachi, invece, un signore dall’aria solenne e dai baffoni che ricordano un sergente maggiore del Raj britannico vuole a tutti i costi farmi da scorta.

Il Forte di Lahore
Arrivo all’aeroporto Allama Iqbal di Lahore e ad accogliermi all’esterno ci sono un gradevole caldo secco e una piccola jeep Suzuki Santana con un mitragliatore montato sul tetto. Lahore è una città di frontiera e ha una storia abbastanza turbolenta. Ma ormai le armi automatiche sono in bella mostra in tutti gli aeroporti del mondo e nessuno ci fa più caso.
L’indomani si parte in auto per Sargodha lungo l’autostrada che va a Islamabad. L’ultima ora del viaggio la passiamo su una stradina stretta che attraversa campagne e piccoli villaggi. Il giovanotto al volante la percorre al doppio della velocità che terrei su una strada del genere. Vecchie corriere, biciclette, carretti, animali, adulti e bambini attraversano la striscia di asfalto davanti a noi.  Un paio di volte l’autista è costretto a buttarsi fuori strada per evitare qualche ostacolo, ma il piede sul gas rimane pigiato.
Un paio di volte l’autista è costretto a buttarsi fuori strada per evitare qualche ostacolo, ma il piede sul gas rimane pigiato.
Mi domando se esista una causa degna per morire a Sargodha, Pakistan. Concludo che la mia missione di affari non giustifica un sacrificio umano, di sicuro non il mio.
Entriamo in città e mi sembra di entrare nel caos coreografato del set di un film. Sargodha ha una doppia vocazione. E’ un importante centro agricolo ma ospita anche numerose piccole aziende manifatturiere. In realtà, la maggior parte dei miei clienti in Pakistan è concentrata qui.
Le strade sono asfaltate ma coperte di di terra, il traffico è fatto di motorette scoppiettanti, biciclette e furgoncini che si litigano la carreggiata con i pedoni. C’è perfino una strada intera dedicata al commercio di biciclette e relativi accessori.

Downtown Sargodha, Punjab
Nella piccola fabbrica di interruttori di un cliente, le presse (rigorosamente manuali) per i componenti in plastica sono al piano rialzato. Al piano terra è legata una capretta e, al suo fianco, ci sono dei bambini seduti per terra che assemblano dei pezzi contenuti in vassoi di vimini. L’aria è densa di odori di frutta marcia, polvere e mosche. E anche la capretta ci mette del suo.
Improvvisamente, la saletta fresca e tranquilla della Pakistan Airlines mi sembra lontana mille anni. Vorrei essere lì, con una birra gelata in mano e vorrei togliermi dalla testa l’immagine di quei bambini silenziosi che lavorano assorti a montare i loro interruttori elettrici.


Ott 10, 2009 | The Blog

Il sarto personale del Colonnello Muammar al-Qadafi, Leader Fraterno e Guida della Rivoluzione libica, ha un diavolo per capello mentre solleva il lembo della tenda ed esce all’aperto.
Oggi tira un vento freddo che viene da Nord, ma almeno non c’è sabbia nell’aria, solo una luce accecante.
Amir il sarto si avvia verso la sua Toyota Corolla malandata (che senso ha in Libia far riparare le ammaccature?) e carica nel portabagagli gli abiti che ha fatto provare al colonnello.
“Mi sono ridotto proprio male – dice fra i denti – ero un vero sarto e facevo abiti che la Tripoli bene si litigava. Mio padre, che mi ha insegnato il mestiere, aveva aperto una sartoria vicino a quella che oggi è la Piazza Verde e faceva abiti per tutti i gerarchi italiani.”
“Chi mi invidia per la mia frequentazione del Leader non sa che adesso mi tocca cucirgli delle porcherie come questa”, dice mentre piega una strana uniforme a metà tra Hermann Goering e il domatore del Circo Orfei. “O questa…”, una tonaca viola cangiante da predicatore nero in Alabama. Amir sbatte il cofano e un lembo del cellofan protettivo rimane fuori, come una bandierina.
Le buste di plastica sono la vera bandiera della Libia e le vedi sventolare a brandelli impigliate nei fili spinati per centinaia di chilometri lungo la litoranea che porta a Bengasi. Ma Amir non ha tempo per riflettere sullo stato delle strade libiche. Entro domani, insh’allah, deve finire le ultime variazioni per questi due costumi da pagliaccio.
Oggi ci ha messo tre ore per farli provare al Leader, con lui che ciondola di qua e di là puzzando di whisky e quelle zoccole delle sue Amazzoni che frugano nella borsa del sarto. Gli hanno perfino sequestrato le forbici. “Ma dico io, le forbici! – si lamenta Amir mentre il traffico di Tripoli lo ingoia – adesso mi metto ad ammazzare il Leader con un paio di forbici…”
“Due ore circondato da quelle capre esaltate prima di riavere l’uso della mia borsa. Addestrate in Serbia! Gli avessero almeno insegnato a lavarsi le ascelle, c’era da svenire.”
La Toyota svicola nel traffico caotico di utilitarie e furgoncini diretta al quartiere di Gargaresh dove Amir ha il suo atelier, ma il povero sarto non ha finito di lamentarsi.
“E adesso Lui mi chiede di fargli anche una bandana entro domattina. Una bandana! Ma quando mai si è visto un capo di stato con in testa la bandana?”

 Oggi mi sono avventurato in moto nel comune di Castellanza, una di quelle cittadine attorno a Milano che se le vedi dall’alto dici: ma quella è ancora Milano.
Oggi mi sono avventurato in moto nel comune di Castellanza, una di quelle cittadine attorno a Milano che se le vedi dall’alto dici: ma quella è ancora Milano.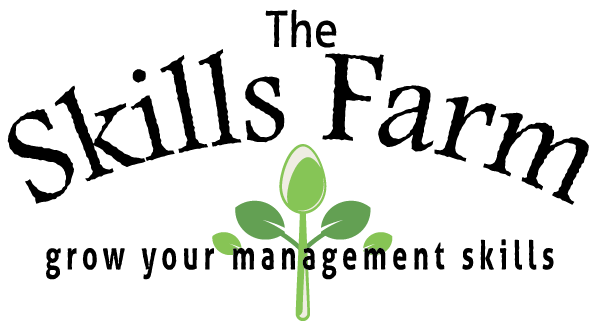






 Aeroporto di Karachi. Sto partendo per Lahore, capitale del Punjab e seconda città del Pakistan con 7 milioni di abitanti. Fatto il check-in del bagaglio mi resta solo una valigetta 24-ore ma l’inserviente dedicato alla Business Class della Pakistan International insiste per togliermela di mano e accompagnarmi alla saletta dove attenderò l’imbarco del volo. Nel resto del mondo ci sono i cartelli con scritto “Lounge” e basta seguirli per lasciarsi alle spalle il viavai e il frastuono degli aeroporti. Qui a Karachi, invece, un signore dall’aria solenne e dai baffoni che ricordano un sergente maggiore del Raj britannico vuole a tutti i costi farmi da scorta.
Aeroporto di Karachi. Sto partendo per Lahore, capitale del Punjab e seconda città del Pakistan con 7 milioni di abitanti. Fatto il check-in del bagaglio mi resta solo una valigetta 24-ore ma l’inserviente dedicato alla Business Class della Pakistan International insiste per togliermela di mano e accompagnarmi alla saletta dove attenderò l’imbarco del volo. Nel resto del mondo ci sono i cartelli con scritto “Lounge” e basta seguirli per lasciarsi alle spalle il viavai e il frastuono degli aeroporti. Qui a Karachi, invece, un signore dall’aria solenne e dai baffoni che ricordano un sergente maggiore del Raj britannico vuole a tutti i costi farmi da scorta.
 Un paio di volte l’autista è costretto a buttarsi fuori strada per evitare qualche ostacolo, ma il piede sul gas rimane pigiato.
Un paio di volte l’autista è costretto a buttarsi fuori strada per evitare qualche ostacolo, ma il piede sul gas rimane pigiato.


