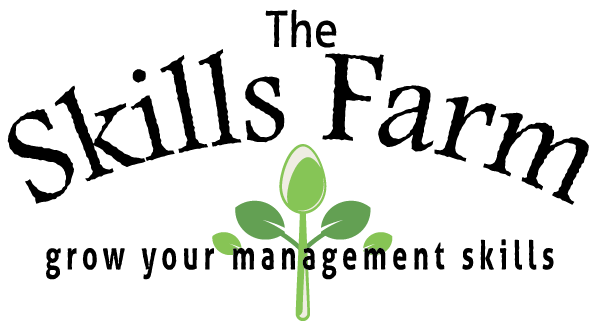Pare che il celeberrimo cocktail Martini non contenesse all’origine l’omonimo vermouth italiano. Si dice anche che il nome derivi dalla cittadina di Martinez in California dove il drink sarebbe nato nel 1862 e non si riferisca quindi alla Martini & Rossi di Torino (azienda che da 20 anni appartiene comunque al gruppo Bacardi).
Come può essere che il celebre Martini non abbia radici italiche? Indignazione degli Italebani integralisti che vedono nel Bel Paese l’unica origine possibile per alimentari e bevande di qualità (dal prosciutto al vino rosso) e vogliono tutto Chilometro Zero. Poi finiscono per bere il Latte della Lola che chissà da dove diavolo viene…
Ma torniamo al Martini. Nella sua formulazione originale, il Martini era molto diverso dall’attuale. C’era del vermouth dolce ed era in quantità doppia rispetto al gin, c’era del Maraschino e perfino un tocco di amaro. Sembra che il primo entusiasta di questo cocktail fosse un minatore arrivato in California con la Corsa all’Oro del 1849 e deciso a celebrare la sua fortuna in un bar di Martinez.
Nel sito Web della città si legge anche come la paternità del cocktail sia stata rivendicata dalla vicina San Francisco e sancita da una sentenza legale, prontamente rovesciata dal tribunale di Martinez, naturalmente.
Con il proibizionismo il Martini subì una metamorfosi importante. Se produrre whisky illegale, il cosiddetto “moonshine”, non era un’operazione alla portata di tutti, chiunque avesse avuto una vasca da bagno poteva invece fare il gin in casa. Con l’aggiunta di un po’ di vermouth e di un’oliva, anche il gin fai-da-te diventava potabile e questo rilanciò una versione più semplice del drink californiano.
Altra particolarità del Martini è la qualifica di “dry”. Meno vermouth si aggiunge (la ricetta indicherebbe circa un rapporto di 1:5 con il gin) e più il drink è dry. Alla temperatura glaciale che gli si conviene, un Martini molto dry è una spada che entra nello stomaco e scende veloce a tagliarti le gambe. Una divertente citazione legata al Martini dice: “Un Martini è sufficiente, due sono troppi e tre non sono abbastanza” (James Thurber).
Ernest Hemingway, probabilmente l’unico scrittore americano decorato dall’Italia con una medaglia d’argento al valor militare, non disdegnava il Martini, di cui anzi prediligeva la sua personale versione extra-dry detta “Montgomery”, in cui il rapporto tra vermouth e gin era di 1:15. Il nome veniva dal rapporto di forze che il Maresciallo Montgomery desiderava avere prima di attaccare le truppe tedesche nella Seconda Guerra Mondiale. (Per gli appassionati di cose militari, già da oltre 2000 anni lo stratega cinese Sun Tzu raccomandava invece un rapporto di forze di 5:1 per attaccare battaglia, un approccio più realistico e meno cautelativo).
Winston Churchill, grande statista e altrettanto grande alcolizzato, aveva una sua ricetta extra-dry particolare. Complice la guerra e la conseguente carenza di vermouth francese, gli bastava versare il gin sui cubetti di ghiaccio e sollevare il bicchiere in direzione della douce France.
Un mio amico americano sosteneva invece che per fare un buon Martini sia solo necessario avere una bottiglia di vermouth in qualche parte della casa e non serva nemmeno aprirla. Per gli americani questo è un Martini “bone dry”, che più secco non si può.
Una breve menzione in questo post dedicato al Martini la merita anche James Bond, che lo preferiva “shakerato e non mescolato”. In realtà quello dell’agente 007 era un “Vodka Martini”, la cui ricetta originale dettata dallo scrittore Ian Fleming era tre parti di gin, una di vodka e mezza di Kina Lillet, un aperitivo francese prodotto da una piccola casa vinicola vicino a Bordeaux.
Dal 1986 però il Kina Lillet è fuori produzione. Si può ripiegare sul normale Lillet o usare del Martini Extra Dry con una scorza di limone.
I puristi potranno storcere il naso denunciando le abissali differenze tra i due aperitivi, ma in realtà già al secondo Martini ghiacciato sarete piacevolmente pervasi da una sensazione di grande serenità.