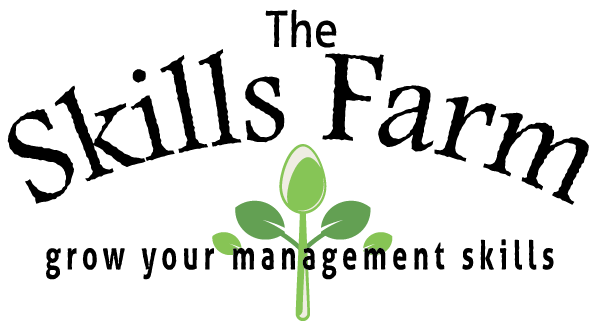Il mio volo per Karachi arriva alle 5:00 del mattino. L’umidità invade l’aeroplano appena si apre il portellone: è un’aria opprimente, calda e fetida—e manca ancora più di un’ora all’alba.
Dopo ore a rigirarmi in un sedile d’aereo, entro barcollando nel terminal, dove già regna una confusione indescrivibile.
Vedo un groviglio di gente febbrilmente indaffarata ad aprire pacchi e valigie davanti ai doganieri, vedo gli sguardi avviliti di chi dovrà pagare delle somme ingenti per aver fatto spese al di là dell’Oceano Indiano, negli Emirati, dove migliaia di Pakistani lavorano in condizioni di quasi schiavitù e portano con sé detersivi, frullatori, radio e giocattoli a ogni ritorno a casa.
Benedico l’idea di aver raccolto tutti i miei effetti personali in una borsa portabiti e in una valigetta tipo pilotina. Ora non devo correre ai nastri del bagaglio in mezzo a quell’orda accaldata e aspettare un’altra ora in questo bagno di folla e di rumore. Tutto quello che voglio ora è una doccia e un cambio di abiti.
Con la mia faccia occidentale e il bagaglio minimalista che porto, passo inosservato sotto il naso dei doganieri arcigni ed esco nella zona arrivi. Mi aspetta un muro vociante di mille persone che agitano biglietti con nomi scritti sopra, mi offrono un taxi, cambio valuta o un semplice “can I help you, sir?”
L’ho già detto, ora voglio solo una doccia e, se mi riesce, chiudere gli occhi per un’ora.
In questo groviglio di umanità, riesco a intravedere il mio rappresentante in Pakistan, si chiama Akhber, è alto e magro, dal naso aquilino e l’età indefinita. “Welcome to Pakistan, my friend”, intona con la cadenza cantilenante del Subcontinente Indiano.
Saliamo in macchina, un calesse di fabbricazione giapponese che ha visto tanto sole e sale e un tempo aveva perfino un colore. L’auto fa lo slalom tra le buche e i ciclisti e si immette in un viale immenso dove un fiume di veicoli scorre verso la città in nuvole di fumo, mentre un sole anemico si annuncia dietro la foschia e lo smog come un pallido uovo al tegame.
Akhber è andato in pensione dall’aviazione militare, dove era un ufficiale superiore, ma entrare in casa sua mi stringe ogni volta il cuore. Lo spazio ridotto e lo squallore mi mettono una tristezza infinita, o forse sono solo stanco.

“La nostra riunione è anticipata alle 8:00, mi dice Akhber, ma abbiamo tempo per un caffè”. (Addio doccia). Mentre rovista nella cucina alla ricerca del barattolo di Nescafè, estraggo dal mio bagaglio una bottiglia di whisky etichetta nera, quello che piace a lui e che in un paese islamico come il Pakistan si trova con difficoltà. L’ho contrabbandato con successo anche questa volta; in dogana sarebbero stati guai se mi avessero scoperto: la bottiglia ora farebbe la sua degna figura in casa di qualche doganiere.
“Akhber, questa è per te” gli dico e vedo un sorriso riempire di mille grinze la sua faccia lunga e ossuta, come le crepe in una vetrata centrata da un sasso.