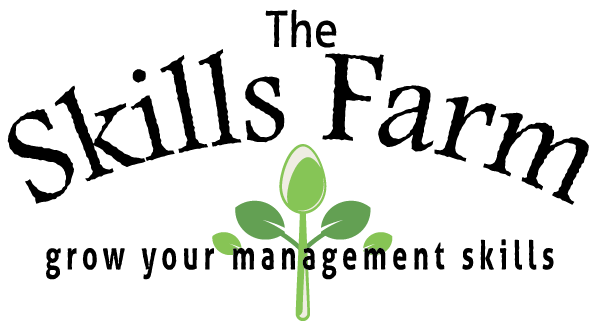Ancora storie di customer service nel Bel Paese, dove le aziende si vantano dell’attenzione riservata al cliente, ma lo fanno solo nella pubblicità. L’esperienza del cliente, la tanto sbandierata customer experience, si rivela spesso tutt’altra cosa.
Scena I
Call center di una carta di credito legata al programma frequent flyer di una grande compagnia aerea e gestita da uno dei principali gruppi bancari italiani.
(Ci si aspetterebbe un servizio da business class, ma non è affatto così.)
Chiamo il numero a pagamento per un problema legato alla carta. Mi risponde con tono immediatamente scostante una voce maschile dall’accento siciliano (l’azienda ha diversi call center, quello di Palermo conta 120 addetti).
Gli segnalo un problema con la carta e la prima risposta è: “Cognome e nome?”, con l’identica intonazione di “Patente e libretto” pronunciata da un vigile urbano. Per l’accento e per il tono sembra quasi una scenetta comica di uno spettacolo televisivo, ma chiaramente non lo è.
Ricordo all’addetto che il cliente può esprimere un giudizio sulla qualità del servizio a fine telefonata e che il suo servizio, nella fattispecie, si sta rivelando scadente. Non è questo il tono con cui ci si rivolge a un cliente. L’addetto mi risponde alzando la voce: “E come le devo rispondere? Io qui sto lavorando.”
Eccolo, il Grande Alibi.
Il lavoro è sofferenza e sei autorizzato a farlo male e senza il minimo attaccamento perché non ti piace. (Poi, comportandoti così, finisce che un giorno lo perdi e allora ti vai a incatenare da qualche parte rivendicando il tuo diritto al lavoro. Che però vivi sempre come sofferenza e perderai di nuovo se non cambi atteggiamento).
Intanto, il cliente che paga per il tuo servizio deve sopportare il tuo approccio adolescenziale alla creazione di valore.
La banca, da parte sua, dichiara sul sito Web di aver “organizzato l’attività di ascolto degli stakeholder realizzando circa 8.000 interviste finalizzate a identificare i fattori che più incidono sulla reputazione”. Spero tanto di essere uno dei fortunati ad essere intervistati.
Scena II
Periferia di Milano. Grande magazzino dell’elettronica di consumo, primo brand italiano del settore, controllato dall’inglese Dixons.
Arrivo alla cassa dopo aver attraversato l’intero magazzino trasportando uno scatolone molto voluminoso (95x50x22), sebbene non pesante. Qui non esistono i carrelli.
L’addetta alla cassa passa il lettore sul codice a barre e scuote la testa. L’apparecchio non riesce a rilevare il prezzo.
“Le dispiace riportarlo indietro ai colleghi del reparto per fargli stampare una nuova etichetta?”—mi chiede indicando lo scatolone.
Le rispondo “Sta scherzando? Perché invece non chiama uno degli addetti e lo fa venire qui?”
L’incaricata si adombra e risponde stizzita: “Stanno lavorando a servire dei clienti”. (Ancora una volta, ecco affacciarsi il Grande Alibi).
“Scusi, ma non sono un cliente anche io? Per quale motivo devo essere io a rifare due volte il percorso per un vostro errore? Non sono certo stato io ad applicare alla scatola un codice a barre sbagliato.”
Lei è visibilmente contrariata (questi clienti diventano sempre più insolenti) ma chiama al telefono uno dei suoi colleghi che, in capo a cinque minuti, risolve il problema e mi consente di mettermi in strada.
Conclusione scontata:
L’attaccamento al cliente non manca mai di comparire nella missione aziendale delle imprese, ma resta spesso lettera morta per l’incapacità (o l’impotenza) del management aziendale di trasmettere questo valore ai propri collaboratori. Politiche sindacali scellerate, supervisori impreparati e il falso senso di entitlement dei loro collaboratori concorrono a creare un atteggiamento negativo da parte degli addetti al servizio clienti. Sto lavorando non può essere una scusante se stai lavorando male.