
Set 26, 2009 | The Blog, The Blog

Il mio volo per Karachi arriva alle 5:00 del mattino. L’umidità invade l’aeroplano appena si apre il portellone: è un’aria opprimente, calda e fetida—e manca ancora più di un’ora all’alba.
Dopo ore a rigirarmi in un sedile d’aereo, entro barcollando nel terminal, dove già regna una confusione indescrivibile.
Vedo un groviglio di gente febbrilmente indaffarata ad aprire pacchi e valigie davanti ai doganieri, vedo gli sguardi avviliti di chi dovrà pagare delle somme ingenti per aver fatto spese al di là dell’Oceano Indiano, negli Emirati, dove migliaia di Pakistani lavorano in condizioni di quasi schiavitù e portano con sé detersivi, frullatori, radio e giocattoli a ogni ritorno a casa.
Benedico l’idea di aver raccolto tutti i miei effetti personali in una borsa portabiti e in una valigetta tipo pilotina. Ora non devo correre ai nastri del bagaglio in mezzo a quell’orda accaldata e aspettare un’altra ora in questo bagno di folla e di rumore. Tutto quello che voglio ora è una doccia e un cambio di abiti.
Con la mia faccia occidentale e il bagaglio minimalista che porto, passo inosservato sotto il naso dei doganieri arcigni ed esco nella zona arrivi. Mi aspetta un muro vociante di mille persone che agitano biglietti con nomi scritti sopra, mi offrono un taxi, cambio valuta o un semplice “can I help you, sir?”
L’ho già detto, ora voglio solo una doccia e, se mi riesce, chiudere gli occhi per un’ora.
In questo groviglio di umanità, riesco a intravedere il mio rappresentante in Pakistan, si chiama Akhber, è alto e magro, dal naso aquilino e l’età indefinita. “Welcome to Pakistan, my friend”, intona con la cadenza cantilenante del Subcontinente Indiano.
Saliamo in macchina, un calesse di fabbricazione giapponese che ha visto tanto sole e sale e un tempo aveva perfino un colore. L’auto fa lo slalom tra le buche e i ciclisti e si immette in un viale immenso dove un fiume di veicoli scorre verso la città in nuvole di fumo, mentre un sole anemico si annuncia dietro la foschia e lo smog come un pallido uovo al tegame.
Akhber è andato in pensione dall’aviazione militare, dove era un ufficiale superiore, ma entrare in casa sua mi stringe ogni volta il cuore. Lo spazio ridotto e lo squallore mi mettono una tristezza infinita, o forse sono solo stanco.

“La nostra riunione è anticipata alle 8:00, mi dice Akhber, ma abbiamo tempo per un caffè”. (Addio doccia). Mentre rovista nella cucina alla ricerca del barattolo di Nescafè, estraggo dal mio bagaglio una bottiglia di whisky etichetta nera, quello che piace a lui e che in un paese islamico come il Pakistan si trova con difficoltà. L’ho contrabbandato con successo anche questa volta; in dogana sarebbero stati guai se mi avessero scoperto: la bottiglia ora farebbe la sua degna figura in casa di qualche doganiere.
“Akhber, questa è per te” gli dico e vedo un sorriso riempire di mille grinze la sua faccia lunga e ossuta, come le crepe in una vetrata centrata da un sasso.

Ago 9, 2009 | The Blog

Grazie alla rotta polare, il volo speciale della World Airways riesce a fare Monaco-Anchorage senza scali. Anche se l’aereo è un gigantesco 747, in turistica il viaggio è scomodo ed eterno; arriviamo malconci e sbandati per la differenza di fusi orari.
Giusto il tempo di noleggiare un’auto in aeroporto e cercare un motel per buttarsi sul letto a pelle di leone sperando di dormire.
Giusto il tempo per rendersi anche conto che in Alaska i prezzi di tutto sono più cari che nei Lower 48, come vengono chiamati il resto degli Stati Uniti continentali.
In Alaska si respira ancora aria di frontiera, quello spirito pionieristico che spinge l’uomo a insediarsi in luoghi dal clima ostile. Curiosamente, l’Alaska conserva ancora nella composizione della sua popolazione un retaggio dei tempi eroici: ci sono più uomini che donne e questo distacco è il più alto degli USA. La seguono in classifica stati poco urbanizzati come Nevada, Colorado, Wyoming, Utah, Idaho e, a sorpresa, Hawaii.

Palmer, Alaska, sulla Highway 1
La gente è cordiale ma sbrigativa. Non si tratta della fretta e della proverbiale ruvidità degli abitanti della Grande Mela e anche la cordialità è diversa, per esempio, dalle maniere impeccabili e un poco retrò del Sud degli Stati Uniti.
Gli abitanti dell’Alaska sono uniti dalla solidarietà innata di chi vive in un ambiente duro e poco accogliente. Quanto all’uso del tempo, finché fa bello, meglio utilizzarlo al massimo e senza sprechi.
Siamo in Agosto e la stagione turistica volge al termine. La Golden Rule di chi visita l’Alaska è prepararsi a trovare il tempo più freddo di una stagione rispetto a quanto indichi il calendario (primavera o autunno se si va in estate, inverno se si va in primavera o in autunno).
 Ieri il Monte McKinley era coperto dalle nuvole. Con i suoi 6.194 metri la “Grande Montagna” (o Denali nella lingua dei nativi) ha un suo microclima e a volte la sua cima resta nascosta per giorni.
Ieri il Monte McKinley era coperto dalle nuvole. Con i suoi 6.194 metri la “Grande Montagna” (o Denali nella lingua dei nativi) ha un suo microclima e a volte la sua cima resta nascosta per giorni.
Oggi però c’è una giornata splendida e la montagna si vede chiaramente, stagliata contro il blu del cielo.
Arriviamo a Talkeetna, un villaggio di 500 anime al confine meridionale del Denali National Park da cui partono tutte le spedizioni per il McKinley. All’aeroporto ci dirigiamo verso l’hangar di Hudson Air Service, una ditta familiare di lavoro aereo che organizza voli turistici e di supporto ai campi base degli alpinisti.
 Il volo durerà un’ora e ci porterà intorno alla montagna e attraverso la Great Gorge del Ghiacciaio Ruth. Non potremo sorvolare la cima, perché il piccolo monomotore Cessna non è pressurizzato, ma il giro ci farà ammirare la bellezza di questo monte e dell’immenso parco naturale che lo circonda.
Il volo durerà un’ora e ci porterà intorno alla montagna e attraverso la Great Gorge del Ghiacciaio Ruth. Non potremo sorvolare la cima, perché il piccolo monomotore Cessna non è pressurizzato, ma il giro ci farà ammirare la bellezza di questo monte e dell’immenso parco naturale che lo circonda.
Scendiamo dall’aereo galvanizzati dall’incontro ravvicinato con questo colosso silenzioso. Ma la splendida giornata di sole non deve ingannare, Denali è una montagna che ha le sue regole e chi non le rispetta muore. Gli abitanti dell’Alaska lo sanno e hanno un rapporto sano con il territorio aspro che li ospita e con il tempo spesso inclemente.
 Il nostro pilota, un tizio che atterra sui ghiacciai ma non se la tira per niente, ci saluta. Avete indovinato: cordiale ma sbrigativo.
Il nostro pilota, un tizio che atterra sui ghiacciai ma non se la tira per niente, ci saluta. Avete indovinato: cordiale ma sbrigativo.

Ago 8, 2009 | The Blog

Nazanin è una giovane iraniana sui 30 anni con la sua piccola ditta di import-export a Teheran. La incontro al mio arrivo all’aeroporto mentre mi aspetta all’esterno; ha mandato a prendermi un uomo di mezza età che ho seguito fuori del terminal. Forse è suo padre.
Sono già passate le 2:00 del mattino e l’aria è tiepida. Le luci al sodio del piazzale tingono di giallo i volti della gente ma, a causa dell’hijab che Nazanin porta in capo, le vedo a malapena il viso.
Mi saluta in ottimo inglese e mi dà il benvenuto a Teheran. Mentre saliamo in macchina, proseguono i convenevoli sul mio volo e sui nostri incontri di domani, mentre l’uomo che l’accompagna guida in silenzio. Scendo al mio albergo, che si chiama Simorgh e si trova sulla Valiasr non lontano dalla Vanaq Square, e mi butto sul letto sperando di dormire almeno cinque ore prima della giornata intensa che mi attende domani.
L’alba annuncia una giornata di sole a Teheran. Mentre rimbalziamo da un incontro di lavoro all’altro, Nazanin mi racconta di sé. Alla luce del giorno è una bella ragazza vivace dai grandi occhi castani. I capelli, neri e lunghi, li vedrò soltanto entrando nel suo ufficio a metà giornata, quando finalmente si potrà togliere l’hijab.
Sposata e già divorziata, lei costituisce un caso raro in Iran, dato che è stata proprio lei a chiedere il divorzio. Si diverte molto a fare questo lavoro, ama la musica e ha la passione dell’astronomia.
Girando per Teheran, la sua piccola Toyota è un barattolo a galla in un torrente: il traffico è caotico e rumoroso e tutti vanno troppo forte. Fermi a un semaforo, ci rendiamo conto di aver sbagliato strada. Nazanin vuole chiedere indicazioni al guidatore della macchina a fianco, ma prima di tirare giù il vetro si aggiusta il foulard in testa e spinge dentro due ciocche di capelli che ne fuoriuscivano e mi dice: “Meglio non dare alla gente un pretesto per trattarmi male. Già il fatto che guido io la macchina mentre ho un uomo al fianco…” e non finisce la frase, ma il significato è già chiaro.
Dopo un altro giro interminabile, mentre da cartelloni giganti il presidente Ahmadinejad e l’Ayatollah Khamenei (il vero potere in Iran) ci guardano benevoli, arriviamo finalmente a destinazione.
Dopo l’ultimo appuntamento, ci troviamo nella zona di Sa’dabad, dove sorge l’ex-palazzo dello Scià ora trasformato in museo. Facciamo due passi a piedi per visitare un piccolo bazaar alla ricerca di qualche oggetto interessante. Mentre ci accingiamo ad entrare, escono correndo due ragazze dall’aria terrorizzata. Apprendiamo poi che proprio ieri, in questo stesso bazaar, una donna che non indossava sopra i jeans uno spolverino abbastanza lungo è stata randellata dalla polizia e portata via di forza.
Pochi minuti dopo, incontriamo la ronda. Sono tre trogloditi in uniforme verde che portano alla cintura dei manganelli dall’aria vissuta. I guardiani della rivoluzione scrutano con attenzione Nazanin che mi cammina a fianco ma non dicono nulla. Tutto in ordine, evidentemente.
Mi viene in mente quella che doveva essere Berlino negli anni 30. Città moderna e sofisticata, con ristoranti, caffè e locali. La gente esce la sera, va a sentire la musica, si diverte. Una grande metropoli da vivere, l’importante è non essere ebreo.
A Teheran, invece, l’importante è non essere donna.

Lug 31, 2009 | The Blog

Teheran è come un enorme bidone di yoghurt rovesciato sulle pendici dell’Alborz e che scorre fino alla pianura. Tra i suoi quartieri nord e quelli meridionali c’è una differenza di altitudine di 600 metri e perfino di diversi gradi di temperatura.
La città conta oltre 13 milioni di abitanti, ha un traffico infernale e, pur non essendo propriamente brutta, non è neanche un posto che ti rimane nel cuore a al quale vuoi a tutti i costi tornare.
Se conosci qualcuno il discorso cambia, la gente è aperta e cordiale e ama raccontarti del suo paese.
L’ospitalità iraniana è palpabile. In una riunione, l’ospite è al centro delle attenzioni e non manca mai un piatto ricolmo di frutta e un piattino con forchetta e coltello davanti a lui . Si parla di affari, si discute di prezzi, ma la discussione viene regolarmente interrotta dall’invito a servirsi, a mangiare un po’ di quella frutta bellissima.
E piano piano ti lasci convincere. Nel giro di qualche minuto ti ritrovi a discutere animatamente mentre mangi albicocche o apri quei favolosi pistacchi che sono una delle ricchezze del paese.
E dire che l’arrivo a Teheran prometteva male. Alle 2 del mattino e dopo una spettacolare veduta dall’alto dell’immensa metropoli luccicante, il jet della Lufthansa atterra all’aeroporto di Mehrabad (*).
Il terminal è semideserto e disordinato, l’impressione iniziale è di un bazar che stia per chiudere.
Tra le poche anime che lo occupano, c’è il solito viavai di pupazzi in uniformi militari o paramilitari pieni di sé che sembrano in agitazione, anche se chiaramente non sta succedendo proprio niente.
Non ho ancora il visto di ingresso ma una lettera d’invito. Il visto, mi hanno detto, mi verrà dato in aeroporto. Non ne sono del tutto convinto e già mi vedo salutare l’alba in una sala d’attesa dai vetri sporchi e che puzza di tappeti umidi e fumo di sigarette.
Ma non è così. Sono la seconda persona che dovrà ritirare il suo visto e l’operazione dura pochi minuti. Ormai i passeggeri del mio volo sono già transitati tutti e mi ritrovo a percorrere da solo il salone degli arrivi diretto al controllo passaporti. Mi sembra che le mie scarpe facciano un gran rumore sul pavimento di marmo, ma è solo il silenzio spettrale che è calato sul terminal.
Un giovane addetto all’immigrazione mi guarda con espressione cordiale mentre arrivo allo sportello, controlla rapidamente passaporto e visto, poi alza gli occhi e sorride a trentadue denti dicendo: “Welcome to Iran!”.
Mi aspettavo lo sguardo inquisitorio dei guardiani della rivoluzione o l’atteggiamento scostante di un perfetto ignorante in uniforme e invece, nel cuore della tiepida notte iraniana, in un aeroporto dove le ultime luci si stanno spegnendo, il primo Iraniano che incontro mi accoglie con simpatia.
(*) Qualche mese dopo, a fine 2007, quasi tutti i voli delle compagnie straniere sono stati trasferiti al nuovo Imam Khomeini Airport costruito a 30 km dalla città.

Lug 30, 2009 | The Blog

Sono stato un paio di giorni in Germania per motivi di lavoro e ho “scoperto” la valle del fiume Rems (o Remstal).
Si trova a NE di Stoccarda ed è una zona ad alta densità industriale, ma a differenza della Ruhr, il vecchio cuore siderurgico tedesco (che è molto più a Nord, tra Düsseldorf e Dortmund), il paesaggio qui è splendido e fatto di un alternarsi di valli e verdi colline.

- Sua altezza la Brezel
In questa zona del Baden-Württemberg sorgono molte fabbriche rinomate, specialmente nel settore della meccanica di precisione. La storica Mauser, che dalla metà dell’800 produce le celebri armi da fuoco, oggi ha anche una consociata nel settore delle macchine a controllo numerico.
Molte cittadine mostrano ancora tracce di archeologia industriale, come le vecchie ciminiere in mattoni rossi. A Schorndorf (paese natale di Gottlieb Daimler, pioniere dell’automobile) ce ne sono un paio perfettamente conservate. Una è proprio quella della birreria Kesselhaus , che è nata nel 2001 nei locali di una vecchia fabbrica di caldaie (Kessel) e ha un suo impianto da dieci ettolitri che produce splendide birre.
Ma per potermi bere in santa pace 3 Weissbier non pastorizzate ho dovuto guadagnarmele. Ho passato due giornate in una fabbrica per approfondire le mie conoscenze nel settore delle macchine utensili, dalla fase di progettazione CAD ai collaudi pre-consegna. I ritmi in Germania sono lenti e misurati, l’atmosfera familiare e rilassata.
Alle 09:00 già si fa la prima pausa. Frau Pfeiffer del commerciale e l’Ing. Mören dell’Uffico Tecnico prendono posto a un tavolino e si fanno una partita a Skat, un classico gioco di carte tedesco. Nel reparto montaggio, si scartano delle Brezel fresche fresche di forno e si beve aranciata (niente birra sul posto di lavoro).
Gran parte dei dipendenti sono qui da anni e conoscono bene il loro mestiere. Non ci sono giovani rampanti e l’età media è sui 40. Capelli grigi, panze da birra e pelate luccicanti ti fanno sentire a casa. Qui si lavora per consegnare le macchine in tempo, ma nel frattempo si scherza e si ride.
Una macchina che verrà prelevata domani è stata montata con delle tolleranze fuori norma e va sistemata. Ci vorranno delle ore, ma nessuno si agita e va nel panico. Il tecnico mi guarda, fa l’occhietto e mormora senza muovere la sigaretta che ha in bocca: “Grosse Probleme, grosse Probleme!” Intanto arriva un tizio dall’ufficio tecnico con una stampata del computer: è un particolare della macchina sul quale si può agire per rimettere tutto posto.
Si smonta, si fresa, si misura, si rimonta.
Magari oggi non si riesce a staccare alle 16:00, ma quando domani arriva il camion per prelevarla, la macchina sarà in perfetta regola.
Riparto per l’Italia con una mezza dozzina di Brezel nel bagaglio e la convinzione che i Cinesi non ce la faranno a uccidere l’Europa delle piccole e medie imprese.
E poi che cavolo ne sanno i Cinesi di come si fanno le Brezel?

Giu 5, 2009 | The Blog
 Che strana sensazione arrivare alla frontiera tra Italia e Slovenia e non doversi fermare.
Che strana sensazione arrivare alla frontiera tra Italia e Slovenia e non doversi fermare.
Gorizia e Nova Gorica sono quasi diventate due quartieri della stessa città.
Anche il passaggio tra Slovenia e Croazia, sebbene sia soggetto come sempre a controllo doganale, non incute particolare timore e si rivela un’operazione piuttosto rapida e rilassata.
Le cose si complicano lasciando la Croazia diretti in Serbia. Si percepisce quasi un aumento del livello di tensione. La Serbia dopotutto non ha una fama brillante, ma a onor del vero, dopo pochi minuti di controlli (che comprendono anche il libretto di circolazione della moto), le porte di questa nazione si spalancano e gli incontri con le uniformi di Belgrado non riprendono che all’uscita dal paese.
Una burocrazia perversa fatta di chiavi USB contenenti i dati del mezzo (e che il pilota deve mostrare a una serie misteriosa di diversi sportelli senza nome) accompagnano l’ingresso in Bulgaria. A parte questo, nessuna complicazione. La decantata “vignetta” per utilizzare le autostrade bulgare non appare in vendita da nessuna parte, noi non la andiamo a cercare e nessuno ce la chiede. Amen.
Da Bulgaria a Turchia si valica una linea immaginaria che é la frontiera tra cultura occidentale e cultura islamica. Non era così 30 anni fa, ma la Turchia oggi si sta polarizzando e i sostenitori di un suo ingresso nella CE farebbero bene a togliersi i paraocchi dell’idealista e a guardare bene questo improbabile candidato.

Il passaggio alla frontiera è macchinoso, il processo inefficiente e poco cordiale. Niente fotografie, anche se l’enorme moschea che appare dopo la barriera dei caselli dei doganieri fa gola al fotografo in cerca di simbolismi. Facce accigliate, nessun messaggio di benvenuto. Altoparlanti lontani proiettano distorto il canto registrato del muezzin. Piano piano, la fila di auto e moto transita davanti allo sportello. Il doganiere turco si prende molto sul serio e adotta la faccia standard dell’ignorante: ostile per non sbagliare.
Niente però supera la tensione palpabile del passaggio da Turchia in Grecia. La frontiera sul fiume Evros sembra una cittadella, i militari si muovono in assetto da guerra e si dice che la terra di nessuno fra i due paesi sia ancora minata. Terminato l’ennesimo esame del libretto di circolazione, il turco fa cenno di passare. Dall’altra parte del ponte, il doganiere greco chiede in Italiano: “niente da dichiarare?” Alla risposta negativa, saluta sorridendo e augura buon viaggio. Il cerchio si chiude, si ritorna nell’Europa senza frontiere.
A molti Italiani, i Greci amano dire: “una faccia, una razza” alludendo a origini etniche comuni.
Sarà poi vero? Non lo so, ma non c’è dubbio che la sensazione è quella.



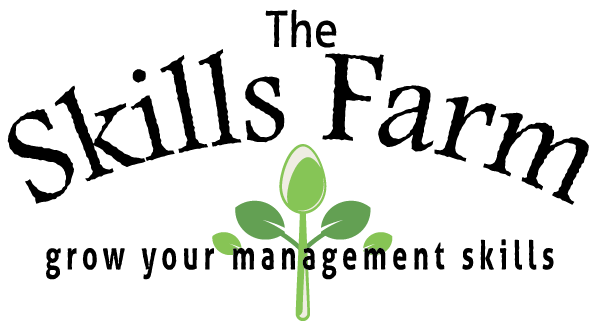



 Ieri il Monte McKinley era coperto dalle nuvole. Con i suoi 6.194 metri la “Grande Montagna” (o Denali nella lingua dei nativi) ha un suo microclima e a volte la sua cima resta nascosta per giorni.
Ieri il Monte McKinley era coperto dalle nuvole. Con i suoi 6.194 metri la “Grande Montagna” (o Denali nella lingua dei nativi) ha un suo microclima e a volte la sua cima resta nascosta per giorni. Il volo durerà un’ora e ci porterà intorno alla montagna e attraverso la Great Gorge del Ghiacciaio Ruth. Non potremo sorvolare la cima, perché il piccolo monomotore Cessna non è pressurizzato, ma il giro ci farà ammirare la bellezza di questo monte e dell’immenso parco naturale che lo circonda.
Il volo durerà un’ora e ci porterà intorno alla montagna e attraverso la Great Gorge del Ghiacciaio Ruth. Non potremo sorvolare la cima, perché il piccolo monomotore Cessna non è pressurizzato, ma il giro ci farà ammirare la bellezza di questo monte e dell’immenso parco naturale che lo circonda. Il nostro pilota, un tizio che atterra sui ghiacciai ma non se la tira per niente, ci saluta. Avete indovinato: cordiale ma sbrigativo.
Il nostro pilota, un tizio che atterra sui ghiacciai ma non se la tira per niente, ci saluta. Avete indovinato: cordiale ma sbrigativo.






