
Mar 3, 2010 | The Blog
 In un post precedente abbiamo già fatto la conoscenza di Akhber, che rappresentava la mia ditta a Karachi. Sappiamo quindi che il brav’uomo era stato ufficiale superiore dell’aviazione pakistana. Come tale, Akhber aveva speso parecchio tempo in America per fare addestramento su jet di fabbricazione USA. Lì aveva anche conosciuto Helen, che aveva in seguito sposato e portato in Pakistan.
In un post precedente abbiamo già fatto la conoscenza di Akhber, che rappresentava la mia ditta a Karachi. Sappiamo quindi che il brav’uomo era stato ufficiale superiore dell’aviazione pakistana. Come tale, Akhber aveva speso parecchio tempo in America per fare addestramento su jet di fabbricazione USA. Lì aveva anche conosciuto Helen, che aveva in seguito sposato e portato in Pakistan.
Un giorno, mentre dall’Italia preparavo la mia prossima missione a Karachi, decisi di avvertire Akhber del mio orario di arrivo. Ma al telefono mi rispose Helen, che con l’irriducibile twang del suo accento americano mi informò che il marito era momentaneamente fuori casa. “Visto però che ti ho al telefono – aggiunse dopo i soliti convenevoli – vorrei chiederti di portare con te quel buon salame di manzo che fate in Italia”.
“Beef salami? There’s no such thing!” le dissi. Ma Helen insisteva e alla fine capii il messaggio. Akhber era rientrato e Helen non voleva fargli capire che mi stava chiedendo di portarle un normalissimo insaccato di carne di maiale.
Fu con una certa trepidazione che nascosi nel mio bagaglio il salame “di manzo” e la solita bottiglia di Johnnie Walker Black per Akhber. Una cosa è contrabbandare alcolici in Pakistan, ma portare anche carne di maiale significa di sicuro andare in cerca di guai.
Per fortuna riuscii a portare a destinazione il prezioso carico senza inconvenienti doganali.
Dato che era un venerdì e gli uffici erano chiusi, Akhber mi invitò al Karachi Golf Club a giocare con lui. Ai tempi il campo da golf era una distesa desertica e i “green” erano chiamati “chocolates” perché realizzati mescolando sabbia e gasolio. (*)
Il mio ricordo di questa giornata è legato in parte al profondo imbarazzo che i continui ringraziamenti di Akhber mi provocarono (“Thank you ever so much, my friend. That beef salami is delicious!”) ma anche alla mia misera figura come golfista. Niente di strano, non avevo mai giocato a golf in vita mia (e da allora non ci ho più provato) e sotto quel sole torrido avrei preferito trovarmi al Club Ufficiali della Pakistan Air Force a bere tè freddo all’ombra di qualche albero centenario.
Sono passati diversi anni e non ho mai saputo se il buon Akhber avesse finalmente scoperto che il salame che gli portavo non era di manzo. La mia coscienza è comunque a posto. Se l’amico poteva ignorare i dettami della sua religione e bere whisky, poteva anche mangiare il salame.
(*) A metà degli anni ’90, il campo del Karachi Golf Club è stato trasformato in una distesa verde ricolma di piante e cespugli e i “chocolates” sono ormai un ricordo del passato, che però molti old-timer rimpiangono.

Feb 6, 2010 | The Blog
La Dottoressa R.Z. dell’assessorato al Turismo della Regione Sicilia si aggiusta sui fianchi la giacchetta D&G che indossa sopra un paio di pantaloni di nappa color prugna. Ai piedi ha un paio di scarpe da basket che dalla forma sembrerebbero delle Converse ma sono tutte ricoperte di strass luccicanti. Il completo deve averle azzerato un paio di stipendi in zona Via Ruggero Settimo a Palermo. E’ una donna sulla quarantina dal colorito mediterraneo ma dai capelli biondissimi che l’origine normanna senza l’aiuto del perossido di idrogeno non è in grado di regalare.
Siamo a Bruxelles, alla Fiera del Turismo BTF, dove la Regione Sicilia ha un grosso stand e sta per dare il via ad una conferenza stampa sul turismo nell’isola nell’anno che viene. In una fiera dove metà dei delegati vestono in grigio e l’altra metà indossa coloratissimi sari, parei e sarong, la Dottoressa è un pugno nell’occhio ma non lo sa.
Ci troviamo al centro della città, in una saletta del Jolly Hotel, scelto appositamente per l’ambiente e la cucina italiani. Alla presentazione seguirà infatti una cena tipica rallegrata da una selezione di vini siciliani. E questo spiega anche la presenza del sottoscritto con un gruppetto di colleghi del Bel Paese residenti all’estero.
Al tavolo dei relatori siedono anche due signori di mezza età con l’ abito grigio sopra il golfino senza maniche (a Bruxelles d’inverno fa un bel freddo umido che senti nelle ossa) che bisbigliano fra loro guardando fisso avanti, come al funerale di un lontano parente. Il loro ruolo non è chiaro, né verrà spiegato. Sono probabilmente due vecchi centurioni, uomini di fiducia inviati dall’Assessore a spalleggiare la Dottoressa in questa difficile missione.
Ma eccola che esordisce: “Signore e signori, è un piacere per me trovarmi qui nella splendida città di Brùcsel”.
La strana pronuncia crea un rantolo nella sala: vuole per caso essere un compromesso tra Bruxelles, come la chiamano i Valloni, e Brussel, come invece preferiscono dire i Fiamminghi? Meglio non indagare.
Ma il problema principale è che la Dottoressa sta parlando Italiano a un pubblico al 90% belga. A parte me e un paio di colleghi italiani a fondo sala, il resto della platea è rappresentato da giornalisti e operatori del settore locali.
“Excusez- moi, Madame” interrompe un signore in seconda fila. “Pouvez-vous parler français ou anglais?”.
La Dottoressa si stringe nelle spalle perché non ha capito la domanda. Una sua risposta a questo punto appare perfino superflua. Le due cariatidi in grigio scuotono la testa e bisbigliano tra loro: “Sti minchia di Belgi non parlano nemmeno l’Italiano..”
Si offre volontario un valente giornalista belga che inizia una generosa quanto stentata traduzione simultanea.
Nessuno di noi Italiani si è fatto avanti. Sono solo rogne. Se la Regione non ha pensato alla necessità di un interprete, non conti su di noi contribuenti per tirarla d’impiccio.
Entra trafelata e impellicciatissima la moglie dell’Ambasciatore d’Italia in Belgio. Si siede in prima fila e, mentre la conferenza stampa agonizza e poi muore di morte naturale, inizia una conversazione a due con la Dottoressa ignorando il resto della sala. La promozione dell’offerta turistica della Sicilia si è compiuta.
 Con gli amici italiani ci alziamo e usciamo. In attesa del Regaleali o del Colomba Platino che serviranno a tavola, ci facciamo subito una birra Duvel al bar dell’albergo per annaffiare il nostro profondo imbarazzo.
Con gli amici italiani ci alziamo e usciamo. In attesa del Regaleali o del Colomba Platino che serviranno a tavola, ci facciamo subito una birra Duvel al bar dell’albergo per annaffiare il nostro profondo imbarazzo.
A poche centinaia di metri da noi, il Manneken Pis, curioso simbolo di Bruxelles, prosegue la sua secolare opera di irrigazione. Il paragone con la Regione Sicilia, che invece lo fa con i soldi, mi intristisce profondamente ma non mi sorprende.

Feb 6, 2010 | The Blog
In vena di reminiscenze, ho cercato di ricordare la mia prima traduzione dall’Inglese. Sono certo di esserci andato vicino, ma la certezza non l’avrò mai: credo sia stato attorno al 1965 e si trattava delle parole di una canzone, il tema conduttore del film High Noon (Mezzogiorno di fuoco). Avevo suonato il disco mille volte, portando indietro la puntina all’infinito per riascoltare dei passaggi incomprensibili. Finalmente avevo scritto tutto su un foglio, ma ancora mi sfuggiva il significato di qualche cosa.
Il mio professore di Inglese, tale M.V., uomo del Tavoliere e già stanco del suo mestiere a poco più di trent’anni, guardò il foglietto e disse: “Uagliò…” restituendomelo. Che doccia fredda! Un professore di Inglese che non sapeva l’Inglese. Fu solo il primo.

Dissolvenza cinematografica. Ci ritroviamo nel 1972. Sto traducendo notizie stampa da una newsletter americana del settore trasporti e aviazione civile. In ufficio ho una Olivetti M40 vecchia di 30 anni che fa un baccano da mitragliatrice e nella foga ogni tanto infilo un dito fra due tasti. Questo lavoro mi piace: dalle notizie telegrafiche del notiziario, che è stampato su carta celeste e arriva per posta, devo tirare fuori qualche articoletto di interesse per gli operatori italiani nel settore viaggi e turismo.
Cinque anni dopo, l’Ambasciata del Sud Africa a Roma mi assume come “Journalist/Translator” e devo mettermi la cravatta per andare a lavorare in quell’ambiente ovattato e senza stress che mi attende. Qui farò la conoscenza dell’Inglese parlato dai Sudafricani e delle sue strane vocali.
È il 1981, sono alla Boeing di Seattle con due commissioni parlamentari italiane (Camera e Senato) che si sono regalate questa scampagnata come “missione conoscitiva” sulle collaborazioni internazionali dell’industria aerospaziale italiana. I due funzionari delle commissioni si sono portati le rispettive compagne a spese del contribuente per fare da “interpreti” ai deputati e senatori, ma in realtà le tipe ne sanno veramente poco nonostante le arie che si danno.
Io lavoro per una società che fabbrica aeroplani e la politica non mi interessa. Il mio lavoro (coordinare il viaggio e il ricevimento in Boeing) è praticamente finito. Me ne sto comodamente seduto nell’auditorium della Boeing ad aspettare il discorso di benvenuto del CEO. Le due interpreti lo attendono sul palco in preda al nervosismo. Eccolo che arriva: vestito blu scuro, camicia bianca e cravatta bordeaux a tinta unita.
Non ha con sé nessun foglietto, parlerà a braccio.
“Good evening, ladies and gentlemen…” e si lancia in una frase introduttiva che elogia il ruolo dell’industria aerospaziale italiana come partner della Boeing. Poi si ferma e guarda le due donne, che dovrebbero ora tradurre. Le due però sono bianche come un lenzuolo, non hanno capito niente di questo esordio e il loro silenzio è agghiacciante. Qualche senatore comincia a bisbigliare “Ma che cosa sta succedendo?”. I due funzionari cercano di sparire nelle loro poltroncine come due gnomi da giardino. Il CEO della Boeing è perplesso e si starà chiedendo: “What the hell is going on here?”
Il mio capo mi guarda terrorizzato. “Fai qualcosa” mi dice con voce strozzata. E fu così che, invitate le signore a scendere dal palco, ho iniziato a tradurre il discorso del CEO e la successiva sessione di domande e risposte. Mi dicono che siamo stati lì oltre un’ora ma il tempo per me è volato via.
Alla cena di gala sono stato poi avvicinato da un dirigente dell’Alitalia che era tra il pubblico, il quale mi ha chiesto di incontrarci a fine viaggio perché voleva offrirmi un lavoro nella Direzione Relazioni Esterne.
Non l’avessi mai fatto…

Gen 22, 2010 | The Blog
Nel manifesto di propaganda Ben Ali sorride, mentre al suo fianco scintilla il suo nuovo terminal aeroportuale, costruito a Enfidha, 100 km a sud di Tunisi, tra Hammamet e Sousse.
Ma c’è poco da sorridere: 5700 ettari di superficie, 400 milioni di Euro per la Fase 1 del progetto, una torre di controllo alta 85 metri, una pista Est-Ovest di 3300 metri e nessuno che ci vuole andare.
Dopotutto, l’aeroporto Tunisi-Cartagine ha ancora capacità residua, e così pure l’aeroporto H. Bourguiba di Monastir. Si è trattato di grande lungimiranza nella pianificazione delle infrastrutture?

C’è chi dice che, pur di potersi dedicare un aeroporto (lo scalo si chiama infatti Zine El Abidine Ben Ali Airport), il presidente tunisino l’avrebbe perfino costruito in mezzo al Sahara. Altri, ancora meno generosi, parlano di una gigantesca speculazione immobiliare che ha visto migliaia di ettari di terreno moltiplicarsi di valore.
A chi appartenevano i terreni quando è stato deciso (sicuramente con voto plebiscitario, come è tradizione in questo paese) di farvi sorgere l’aeroporto?
Lo scalo, inaugurato nell’Ottobre 2009, si presentava pienamente operativo a Gennaio 2010, con tanto di svincolo autostradale sulla A1. La torre di controllo splendeva al sole e si vedevano chiaramente i boarding bridge delle porte di imbarco. Si notava però anche la totale mancanza di aeroplani.
Presumibilmente, l’aeroporto ha già una serie di servizi funzionanti e la società turca TAV (che l’ha costruito e ne ha la gestione per 40 anni) sta già pagando i suoi dipendenti per passare la giornata guardando il nulla circostante dalle grandi e luminose vetrate.
Se il viaggiatore d’affari diretto a Tunisi privilegerà certamente i voli diretti al vecchio Tunis Carthage (8 km dalla città), i voli turistici per Hammamet possono fare scalo indifferentemente a Enfidha o all’aeroporto della capitale, visto che sono praticamente equidistanti dalla nota cittadina turistica. Diversa la situazione per il comprensorio di Sousse-Monastir. L’attuale aeroporto è a pochi minuti dai grandi alberghi, Enfidha dista invece un’ora di pullman. Serviva uno scalo di queste dimensioni per il solo turismo di Hammamet?
Certamente esistevano in Tunisia progetti più urgenti in cui investire 400 milioni di Euro.

Ma il settantaduenne Ben Ali, che ha abolito la presidenza a vita dopo il suo colpo di stato del 1987 ma è al suo quinto mandato successivo, rassicura tutti con il suo sorriso aerografato.

Gen 2, 2010 | The Blog
Per Britalian intendo quella versione della lingua inglese utilizzata con disinvoltura dagli Italiani che non sanno l’Inglese.
Per capirsi, il Britalian è parente stretto dell’Itañol (che a sua volta è la versione della lingua spagnola utilizzata dagli Italiani che non sanno lo Spagnolo) e del Franglais, che i Britannici parlano in Francia e si meravigliano di non essere capiti.
Sorge spontanea la domanda: “Ma se non sanno l’Inglese (o lo Spagnolo), perché non lo imparano prima di usarlo?”
Giusta osservazione. Un Tedesco, per esempio, farebbe proprio così. Mentre un Francese si rifiuterebbe per principio di imparare (e di utilizzare) qualunque altra lingua se non la langue française, point.
L’Italiano invece è più disinvolto e geneticamente privo di ogni senso di autocritica. Diversamente non si spiegherebbero insegne commerciali del tipo Occhial House (che esiste sul serio a Milano) o peggio ancora Dogcooker, una ditta brianzola di accessori per animali domestici che da anni continua a evocare in me immagini raccapriccianti di pentoloni fumanti pieni di amici dell’uomo.
Quando stai per investire diverse migliaia di Euro in un’insegna luminosa, che cosa ti costa informarti presso qualcuno che l’Inglese lo sa veramente e chiedere se per caso non stessi scrivendo una castroneria?
O magari (la butto lì) spendere 100 Euro per farti consigliare da un traduttore professionista. Ma la “voglia di multinazionale” ha contagiato molti bottegai italici, ormai convinti di essersi dati un tono di global player. Perché sbattersi per realizzare un logo in Inglese autentico quando in pochi minuti ne inventi uno che sembra inglese. E qui un’analogia con i Rolex cinesi non sarebbe del tutto peregrina.
Nel Britalian rientra anche quell’impiego sbrigativo dell’Inglese fatto nelle aziende e che abbrevia pragmaticamente titoli ritenuti troppo lunghi e ridondanti. L’Account Manager diventa così l’Account (“ieri ho parlato con l’Account della XYZ Advertising”), il Sales Representative si ritrova chiamato Sales (“oggi vedo il Sales della GlobalAir”). L’elenco è pressoché infinito ma in compenso assolutamente democratico, visto che abbraccia dal Regional (Vice President) con una RAL di oltre €200.000 all’Administrative (Assistant), che si porta a casa un decimo di quella cifra.
Sempre Britalian è lo spostamento sistematico degli accenti di alcune parole inglesi, che spesso genera ulteriori sfaceli nella pronuncia delle stesse. Mostri come Purchàsing, Rèport, Manàgement, Sùspense, Éxpress, Vintàge sono i crimini più frequenti. Chi provasse a enunciare queste parole piazzando l’accento al posto giusto e magari abbozzando anche una pronuncia decente, si vedrebbe subito apostrofato con: “Aò, ma che me fai er fanatico?”
Il senso di orgoglio e di proprietà di questa bizzarra lingua (“dite quello che vi pare, io l’Inglese lo parlo così”) è un fatto singolare che trova solo riscontro nelle lingue creole e nel Pidgin English, dove però questi fenomeni linguistici hanno una loro dignità etnica e storica.
 Il Britalian era un tempo anche noto come Inglese maccheronico. L’espressione è però caduta in disuso in quanto ritenuta politicamente scorretta.
Il Britalian era un tempo anche noto come Inglese maccheronico. L’espressione è però caduta in disuso in quanto ritenuta politicamente scorretta.
Essa sembrava subdolamente sottintendere una padronanza meno che ottimale della lingua inglese e pertanto (Dio ce ne scampi) la necessità di studiarla con maggiore impegno. Tutto ciò è chiaramente inaccettabile nel Bel Paese che ha dato i natali a geni come Leonardo Da Vinci e Leonardo Pieraccioni e che produce il Parmigiano Reggiano che il mondo intero ci invidia.
Un giorno, entrando in un grande albergo di Milano ho sentito un connazionale che dalla Reception telefonava a un ospite straniero in camera: “Elloo, ai emme ueiting et de céntralin”. Non ho però colto il resto della conversazione, perché sono entrato nell’àscensor.

Gen 1, 2010 | The Blog
 “Un Drake a Bankitalia”, titola il Sole-24 Ore il 31 Dicembre 2009, riferendosi esplicitamente a Mario Draghi.
“Un Drake a Bankitalia”, titola il Sole-24 Ore il 31 Dicembre 2009, riferendosi esplicitamente a Mario Draghi.
Quello che è meno chiaro è l’uso della parola “drake”, che in Inglese è il maschio della papera.
A meno che l’articolista non si riferisse a Sir Francis Drake, l’avventuriero e pirata al soldo della corona inglese.
Ma allora diventa meno chiara l’allusione al banchiere ed economista italiano. Banchiere e pirata? Ma quando mai si è vista una cosa del genere?
Stesso dubbio sorge rispolverando il soprannome dato a Enzo Ferrari, “il drake”. Come nasce il nickname?
Un anonimo Internauta propone questa spiegazione:
deriva da Drake un importante corsaro inglese che si era distinto x la sua forza e determinazione nel combattere durante le battaglie e quindi Enzo Ferrari era chiamato così, “drago” è la traduzione della parola.
Peccato che, come abbiamo visto, non sia vero. Drago in Inglese è “dragon”.
Alla voce Sir Francis Drake, Wikipedia.it ci confonde ulteriormente:
Drake si guadagnò il soprannome di El Draque (“Il dragone”), che è la diretta traduzione del suo cognome.
Non proprio: Dragone in Spagnolo si dice Dragòn. Andiamo a vedere Wikipedia in Inglese:
(…) a hero to the English but a pirate to the Spaniards to whom he was known as El Draque, ‘Draque’ being the Spanish pronunciation of ‘Drake’.
Aha! Ora cominciamo a vederci più chiaro. Draque è come lo pronunciavano gli Spagnoli e non la traduzione (gli Italiani l’avrebbero pronunciato Drache). Ma l’enciclopedia virtuale prosegue: “His name in Latin was Franciscus Draco (‘Francis the Dragon’)”.
Il pasticcio sarà forse colpa della trascrizione latina del nome originale, sorte toccata anche ad altri nomi celebri nel corso dei secoli (vedi Renatus Cartesius alias René Descartes)?
Resta sempre la possibilità che il soprannome Drake volesse fare allusione al celebre mago Mandrake dei fumetti, che da noi ovviamente si pronuncia Mandràche.
Due persone su tre sono fermamente convinte che Mandrake in Inglese voglia dire “uomo drago” (riecco l’equivoco drago = drake). In realtà, Mandrake è solo una pianta medicinale, la Mandragora officinarum, pertanto sprovvista di ali e di fiato fiammeggiante.
A complicare le cose ci si mette perfino lo scomparso Enzo Biagi nella sua biografia di Enzo Ferrari:
“Lo hanno definito anche ‘stregone,’ o ‘Drake’, con chiara allusione al leggendario corsaro”.
Insomma, per il giornalista, Enzo Ferrari poteva essere il mago Mandrake o il pirata Sir Francis Drake. Esclusa quindi ogni parentela con i draghi o (questo ci conforta non poco) con il maschio della papera.
Tirando le somme: drake e drago sono dei cosiddetti “falsi amici”, li accomuna solo la trascrizione di Drake in Latino, lingua che allora era ancora in uso nei documenti ufficiali. Un buon dizionario riporterà anche un uso arcaico e obsoleto di “drake” nel senso di “drago”, derivato dal termine “draca” dell’Old English, che a sua volta l’aveva attinto dal Latino.
Dubito però che il redattore del Sole-24 Ore o la tifoseria del cavallino di Maranello si siano rifatti al termine arcaico. E’ molto più probabile che si tratti dell’ennesimo vocabolo di quella pseudolingua nota come Britalian che ogni tanto affiora.

 In un post precedente abbiamo già fatto la conoscenza di Akhber, che rappresentava la mia ditta a Karachi. Sappiamo quindi che il brav’uomo era stato ufficiale superiore dell’aviazione pakistana. Come tale, Akhber aveva speso parecchio tempo in America per fare addestramento su jet di fabbricazione USA. Lì aveva anche conosciuto Helen, che aveva in seguito sposato e portato in Pakistan.
In un post precedente abbiamo già fatto la conoscenza di Akhber, che rappresentava la mia ditta a Karachi. Sappiamo quindi che il brav’uomo era stato ufficiale superiore dell’aviazione pakistana. Come tale, Akhber aveva speso parecchio tempo in America per fare addestramento su jet di fabbricazione USA. Lì aveva anche conosciuto Helen, che aveva in seguito sposato e portato in Pakistan.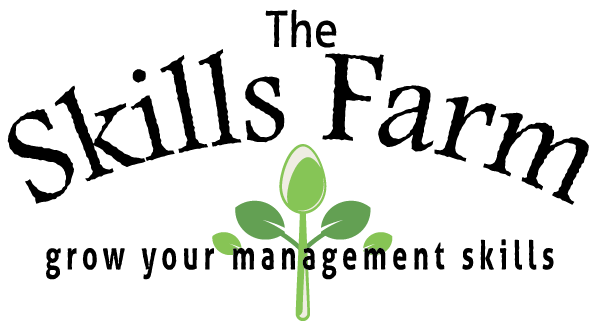

 Con gli amici italiani ci alziamo e usciamo. In attesa del Regaleali o del Colomba Platino che serviranno a tavola, ci facciamo subito una birra Duvel al bar dell’albergo per annaffiare il nostro profondo imbarazzo.
Con gli amici italiani ci alziamo e usciamo. In attesa del Regaleali o del Colomba Platino che serviranno a tavola, ci facciamo subito una birra Duvel al bar dell’albergo per annaffiare il nostro profondo imbarazzo.





 Il Britalian era un tempo anche noto come Inglese maccheronico. L’espressione è però caduta in disuso in quanto ritenuta politicamente scorretta.
Il Britalian era un tempo anche noto come Inglese maccheronico. L’espressione è però caduta in disuso in quanto ritenuta politicamente scorretta.
 “Un Drake a Bankitalia”, titola il Sole-24 Ore il 31 Dicembre 2009, riferendosi esplicitamente a Mario Draghi.
“Un Drake a Bankitalia”, titola il Sole-24 Ore il 31 Dicembre 2009, riferendosi esplicitamente a Mario Draghi.