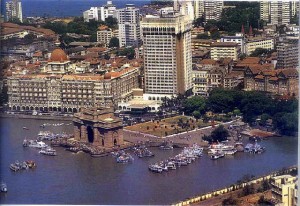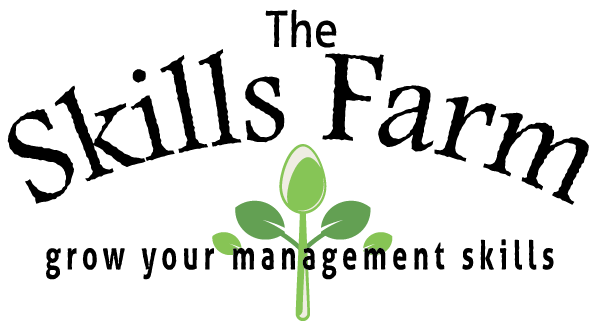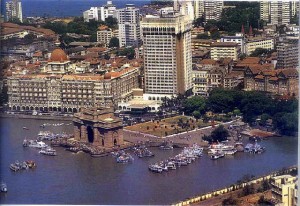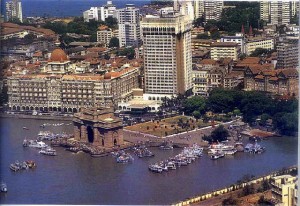
Ott 28, 2010 | The Blog
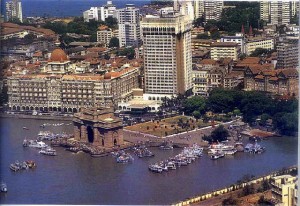
Eccomi di nuovo a parlare di India.
Questa volta non si tratta di reminiscenze lavorative in quel Paese ma di un corso di comunicazione interculturale che sto preparando per un’azienda italiana.
Un’opportunità commerciale ha portato questa società a interagire strettamente con un partner indiano operante nel mondo dell’informatica e a impostare con esso un intenso rapporto sviluppato principalmente per via elettronica.
Ecco quindi delinearsi una modalità di comunicazione affidata principalmente alla parola scritta e ai dati senza il beneficio del dialogo faccia a faccia, che quasi sempre facilita i rapporti interpersonali.
In queste comunicazioni istantanee ma a distanza entrano in gioco fenomeni quali la differenza oraria, la possibilità di incomprensione sui termini nella lingua franca (l’inglese ovviamente) utilizzati in maniera diversa dai due interlocutori e i problemi legati a una scarsa fiducia reciproca, che possono nascere nei rapporti a distanza.
Il tutto appoggiato sulla tradizionale base della relazione committente/prestatore di servizi che presenta già da sempre una serie di fattori critici.
Altri problemi emergeranno di sicuro durante il corso, che si prospetta quindi particolarmente interessante.
Il mondo dell’informatica, con la sua straordinaria capacità di trasmettere il lavoro via Internet e non via container, presenta una serie di aree grigie e criticità potenziali, molte delle quali sono ancora da esplorare, considerato che solo da pochi anni si sono intensificati i fenomeni di offshoring con il Paese asiatico.
Se nelle collaborazioni tra aziende manifatturiere i tempi rimangono piuttosto lunghi e legati principalmente al traffico marittimo (come avveniva nei secoli scorsi), qui non si parla nemmeno di tempi.
I miei dati trasferiti sul server del partner indiano alle 18:00 ora italiana saranno immediatamente disponibili quando apriranno i suoi uffici domani mattina, che per me sarà ancora il cuore della notte. Analogamente, la mail con i suoi commenti inviatami mentre ancora dormivo sarà lì ad attendermi sul mio PC al momento di iniziare il lavoro.
Eppure, questa eccezionale facilità di scambiarsi i dati può dare luogo a incomprensioni, tensioni e complicazioni. Occorre aggiungere un elemento di umanità all’equazione.
Quei viaggi massacranti verso Est, gli arrivi caotici nel cuore della notte, il tuffo nell’aria calda e umida dagli odori più diversi che sono stati alla base del mio lavoro per 25 anni servivano anche a quello, a stabilire un rapporto umano con il partner. Su quella base lo scambio di corrispondenza, prima per fax e poi per e-mail, poteva svolgersi in maniera più serena e trasparente.

Ott 10, 2010 | The Blog

Il mondo oggi è una gabbia di vetro. Secoli fa, sbarrate le frontiere e cacciati gli ospiti indesiderati, nulla traspariva all’esterno di un Paese chiuso nel suo guscio. In tempi più recenti, nel XX Secolo, la censura sulle emissioni radiotelevisive e il bavaglio alla stampa hanno sortito effetti pressoché identici in molti Paesi retti da regimi totalitari.
Oggi però, l’accesso generalizzato a una vasta gamma di mezzi di comunicazione (pensate ai messaggi su Twitter durante le recenti rivolte di piazza in Iran) permette alla gente comune di superare le restrizioni dei regimi totalitari.
A maggior ragione, Paesi dalle frontiere aperte e che trasmettono i loro programmi televisivi via satellite proiettano all’esterno un’immagine di sé che, all’osservatore attento, ne rivela il carattere nazionale e le regole di comportamento in essere al loro interno.
Quanto segue è apparso su un quotidiano canadese e riguarda l’immagine dell’Italia percepita in quel Paese. Fin qui, niente di nuovo. Siamo tristemente abituati a leggere di noi su giornali stranieri. A volte si tratta di analisi precise e imparziali, altre volte è solo un imbecille impreparato che fa un collage di luoghi comuni. Ma non cambia nulla, basta gettare ridicolo sull’Italia per essere creduti da molti.
Questa volta però, a parlare di noi è un italiano: un giornalista di origine istriana che vive a Montreal da quarant’anni e scrive per un giornale locale in lingua italiana. Si può dare peso o meno alle sue parole, si possono condividere o deplorare le sue argomentazioni e conclusioni. È innegabile però che la sua analisi colga spesso nel segno.
Attori e spettatori nel teatrino Italia
Non è facile dare un ritratto sintetico dell’Italia così barocca e confusionaria con la sua quotidiana isteria mediatica, il moralismo, le denunce, l’allarmismo, il catastrofismo, i fatti di cronaca nera ingigantiti all’eccesso, le nuove sentenze che ribaltano le precedenti, la dietrologia ad ogni costo, il riesumare all’infinito i fatti del passato senza mai girare pagina, l’antifascismo – a babbo morto – come professione e carriera, le polemiche, l’urlare… Un punto solo vorrei mettere in evidenza: questo teatrino non avviene a danno e a spese degli italiani per chissà quale disegno diabolico di forze oscure, come invece tanti in Italia sostengono. Sono italiani, infatti, sia gli attori sia gli avidi spettatori di questo grottesco teatrino delle urla e dell’isteria. Basti vedere cos’è una discussione tra italiani anche in TV: mai pacata, sempre esagerata. Parlano, anzi urlano tutti insieme, perché tutti vogliono aver ragione.
Nella penisola, tutti – o quasi – hanno il culto della furbizia e predicano bene e razzolano male. Sono portati all’indisciplina… Fanno il tifo contro o pro Berlusconi. Sono indisciplinati e non rispettano il segnale stradale di stop. Per molti di loro l’allacciarsi la cintura è un vero atto contro natura. Ma contemporaneamente tutti catoneggiano, denunciando le ingiustizie del pianeta Terra, in genere, e in particolare l’indisciplina, la furbizia e l’immoralità degli altri italiani…
E che dire dei grotteschi programmi di discussione in TV, sorta di Bar dello Sport nazionale, dove tutti vogliono aver ragione? Questi programmi condotti da imbonitori da fiera con laurea, che accusano e moralizzano tra cosce, tette e chiappe di false bionde discinte, sono seguiti avidamente dagli italiani, i quali – secondo me – dovrebbero invece tirare la catena su questa televisione che li sputtana attraverso il globo. Ma, purtroppo, gli italiani sono costituzionalmente incapaci di avvertirne il ridicolo, a causa di una carenza atavica di dignità nazionale.
Claudio Antonelli

Set 23, 2010 | The Blog

Era l’estate del 1972 e mi imbarcavo su una vecchia nave greca nel porto di Ancona per prendere servizio come Assistente Passeggeri in quella che si sarebbe rivelata una stagione di crociere abbastanza travagliata.
La nave, di sole 5000 tonnellate, era anziana e malconcia. L’offerta di viaggi era un prodotto di “primo prezzo”, con sistemazioni spartane, alcune sotto la linea di galleggiamento della nave. Ma il pensiero di andare in crociera per 11 giorni a meno di 150.000 Lire lanciava il cuore del passeggero al di là dell’ostacolo (o del buon senso) e il successo di vendite nei tre mesi di alta stagione si rivelò notevole.
Erano i tempi in cui ad Atene si poteva ancora circolare. La sera, mentre i passeggeri andavano a vedere lo spettacolo di Sirtaki, l’equipaggio correva alla Yortì Krasioù, la Festa del Vino, nel sobborgo di Dafnì tra Atene e il Pireo, a prendersi una sbronza low cost.
A quei tempi Istanbul era una metropoli misteriosa, a cavallo tra Oriente e Occidente ma senza i ponti sul Bosforo, il primo dei quali sarebbe stato realizzato l’anno dopo. Ad ogni ingresso in porto, sul molo ci attendeva il nostro agente marittimo (sempre in abito bianco e Borsalino), che la sera portava ufficiali e staff passeggeri a cena al Kervansaray Night Club in una piccola carovana di taxi, invariabilmente vecchie auto americane degli anni 40 e 50.
Le rose e fiori finiscono qui.
Alcune cabine erano dei loculi angusti, caldi e puzzolenti, che vibravano e scricchiolavano senza sosta.
Dalle cuccette, facce imploranti chiedevano di essere spostate ai ponti superiori, ma la nave viaggiava sempre al completo.
Il vitto poteva ancora andare per i passeggeri inglesi, ma gli italiani erano in agitazione permanente. La dieta agnello e patate fritte non gli andava giù, né il contorno di pasta scotta riscuoteva troppi consensi.
A metà Agosto si guastò anche l’aria condizionata e, in un’altra memorabile occasione, ci fu un’avaria ai motori (vetuste turbine a vapore) per cui restammo un giorno all’ancora nel Golfo di Corinto in attesa dei ricambi e fummo costretti a portare a terra i passeggeri con le scialuppe di salvataggio per un’escursione estemporanea che, nelle intenzioni almeno, doveva allentare la tensione.
Peccato che qualche paranco si fosse bloccato a metà corsa lasciando alcune scialuppe appese di traverso lungo i fianchi della nave nell’ilarità generale. A qualcuno, però, deve essere passato per la mente che, in una vera situazione di emergenza, ci sarebbe stato molto meno da ridere.
Dopo venti anni esatti, nel 1992, assumevo l’incarico di Direttore Commerciale Passeggeri di una grande società marittima italiana e mi dedicavo al lancio e alla commercializzazione di nuove linee di traghetti nel Mediterraneo Occidentale.

Sebbene i miei compiti fossero legati ai mercati di provenienza del traffico passeggeri e non all’operatività delle singole navi, mi trovavo spesso a viaggiare sulle nostre rotte. Scoprii allora che, a venti anni di distanza, il rapporto degli italiani con le navi non si era evoluto.
Al momento della prenotazione, tutti si lanciavano alla ricerca della sistemazione meno cara. Saliti a bordo e presa visione della cabina interna a quattro posti, si scatenavano immediate crisi di claustrofobia.
Inutile dire che una cabina del 1972 e una degli anni ’90 erano due cose ben diverse, ma la reazione del passeggero nostrano davanti alla sistemazione più economica non cambiava. Alla Reception si assisteva regolarmente a scene di folla, con finti svenimenti e crisi cardiache comandate a orologeria.
Il nonno, che pure saliva in bici all’Abetone ogni weekend, improvvisamente accusava dolori lancinanti al petto. La nonna si strappava i capelli dicendo: “Non riesco a respirare“. I bambini, che si sarebbero divertiti anche a dormire in sala macchine, erano usati come ricatto morale all’italica maniera e ribattezzati “le creature” per maggiore effetto dirompente sugli animi dei commissari di bordo.
Inutile spiegare ai navigatori del Secondo Millennio che anche le cabine esterne, grazie all’aria condizionata, non avevano le finestre apribili. Si passava invece il tempo a rispondere di continuo a domande profonde del tipo: “Perché non fate una nave solo di cabine esterne?“
A poco serviva descrivere quel tipo di nave come un vagone ferroviario lungo e stretto e dalle scarse doti marine; altrettanto inutile era ricordare che, al momento della prenotazione, l’opzione della cabina esterna era sempre presente fra le sistemazioni offerte (ma chiaramente occorreva spendere qualche soldo in più).
Mentre la nave usciva maestosa dal porto e spariva nella notte, alla Reception la corte dei miracoli vociante, tra un rantolo e una fitta, esigeva cabine esterne per tutti senza sovrapprezzo.
Da allora sono passati altri venti anni o quasi. Oggi faccio un altro mestiere ma salgo sulle navi almeno 8 volte l’anno come passeggero e mi guardo attorno divertito: finalmente non è più un problema mio.
Inutile dire che, in quarant’anni di attenta osservazione, il Popolo di Navigatori non è cambiato per niente.

Set 12, 2010 | The Blog

Propongo che il verbo valutare venga radiato dalla lingua italiana.
È diventato infatti fiancheggiatore di un classico tratto del carattere nazionale: l’incapacità di prendere una decisione o di impegnarsi dando una risposta chiara.
Il bello del verbo valutare è che, avendo un tono più serio e importante di verbi analoghi come pensare o riflettere, imprime una certa ufficialità alla frase.
Espressioni come “Ci devo pensare” o “Vorrei riflettere”, che per anni erano andate benissimo, sono ormai considerate patrimonio della gente semplice, anzi sempliciotta. L’Italiano ha imparato dall’autorità che più parli complicato e più diventi autorevole.
Allo stesso modo, la risposta. “Non lo so”, un’onesta frase che ha funzionato bene per secoli, è vista ora come un’ammissione di ignoranza. Meglio quindi fare fumo con il verbo valutare. (Voci di corridoio dicono che anche il verbo ponderare stia raccogliendo forti consensi, ma riparliamone fra cinque anni.)
Vediamo ora qualche esempio:
D: Venite al mare con noi domani?
R: Stiamo valutando.(Leggi: se non ci invitano amici più simpatici, ci tocca venire con voi.)
D: Direttore, siamo a fine Luglio. Ha stabilito i giorni di chiusura aziendale in Agosto?
R: Devo ancora valutare. (Leggi: me ne ero completamente dimenticato.)
D: Scusi, lei crede in Dio?
R: Mah, lo sto valutando. (Leggi: non mi voglio sbilanciare.)
D: Comandante, perché stiamo precipitando?
R: Sto valutando la situazione.(Leggi: non ne ho la più pallida idea.)
D: Allora la compri quella moto?
R: Sto valutando. (Leggi: non ho i soldi.)
Il verbo decidere, invece, è stato ormai defenestrato a furore di popolo. Si è scoperto infatti che decidere ha una notevole connotazione di finalità, per esempio: “Ho deciso!” (cioè: non ci posso più ripensare).
Gli Italiani del terzo millennio, stressati, confusi e schizzati, sono un popolo di indecisi cronici.
Se già la scelta di una corsia sull’autostrada si rivela molto sofferta, immaginatevi una decisione vera e propria quali traumi potrà comportare!
No, valutare è il verbo giusto per chi ama parlare, ma senza impegno.
D: Cara, tu mi ami?
R: Devo valutare.

Ago 13, 2010 | The Blog

Ho smesso da molto tempo di leggere le recensioni di qualunque bene o servizio che siano pubblicate in Italia, sia sui giornali che sui siti Web.
Come un filtro anti-spam che riconosce al volo le parole chiave degli odiosi messaggi di posta indesiderati, anch’io ho sviluppato un sesto senso per le marchette della stampa italica, una manica di pennivendoli inverecondi pronti a cantare le lodi di qualunque cosa.
La parola che mi fa accendere la spia rossa dell’allarme-marchetta è prestigio, anche quando compare nella sua forma aggettivale prestigioso.
Quante volte l’avete letto solo oggi in qualche recensione?
Il prestigioso marchio Motom è ritornato a fregiare degli splendidi scooter…
Leggi: il marchio Motom, che risale al 1947 e che è andato prematuramente a estinguersi per mancanza di mercato/soldi/idee, è ritornato con una spudorata operazione commerciale che ha messo in circolazione scadenti trabiccoli fatti in Cina abbinandoli a un logo storico ma tanto estinto quanto l’Idrolitina.
Vacanze da sogno nel prestigioso Hotel Caccamo, due stelle, vista tangenziale, tutte camere con bagno, sottopassaggio per accedere al parcheggio. Disponibili camere insonorizzate per un modesto supplemento.
Leggi: locanda malconcia e rumorosa in posizione assolutamente da evitare a meno che non vi si guasti la macchina lì davanti alle due del mattino.
La parola prestigio viene, guarda un po’, dal latino e vuol dire originariamente “gioco di destrezza” e, in senso traslato, “illusione”. E qui la definizione “marchio prestigioso” abusata dalla stampa calzerebbe a pennello: si tratta di un gioco di prestigio in cui a essere giocato è sempre il consumatore che crede a quello che legge.
Il significato corrente che si attribuisce a “prestigio” (autorità, fascino) si avvicina molto all’utilizzo che la lingua francese ha fatto della parola latina. Fra i vari significati di prestige, oltre a quello di illusione e gioco di mano, ci sono attrazione, capacità di sedurre, di fare impressione. Anche l’inglese, che deve al francese un bel po’ dei suoi vocaboli, ha ereditato prestige ma soltanto nelle sue accezioni di reputazione raggiunta tramite il successo oppure capacità di suscitare impressione.
Ecco quindi un’arma letale nelle mani dei marchettari: il cronometro, i mocassini, il marchio storico, il motorino, il pied-à-terre in borgata, sono tutti oggetti prestigiosi i cui lati positivi non vanno nemmeno descritti. Sono misteriosamente contenuti nell’aggettivo e nessuno osa chiedere quali siano per non passare da ignorante.
D: Ma come ti è venuto in mente di comprarti quel catorcio?
R: Ma scherzi? Non lo vedi che è un marchio prestigioso?
Ovviamente dei lati negativi, trattandosi di recensioni stampa, non si parla affatto.
Va bene informare i consumatori, ma vediamo di non esagerare e finire per raccontargli le cose come stanno…

Lug 28, 2010 | The Blog

Ho sempre avuto un’attrazione fatale per i mezzi di trasporto e ancora me la porto appresso.
Ricordo che da bambino mettevo in croce i miei perché mi portassero alla stazione ferroviaria, in porto o all’aeroporto. Mi guardavo intorno per ore, gli occhi come videocamere, poi a casa ridisegnavo religiosamente tutto: il locomotore marrone, caldo e impolverato, tozzo e ostile come un mezzo militare o il traghetto dalle mille lampadine accese di cui ridisegnavo il fumo nero fetido che usciva dal fumaiolo come una fila di tante e corsive.
Anni fa ritrovai un vecchio filmino girato da mio padre con la vecchia cinepresa Paillard. Nei fotogrammi bianco e nero saltellanti c’ero io su una terrazza dell’aeroporto di Ciampino mentre alle mie spalle si avvicinava al terminal un quadrimotore della TWA dal muso affusolato e dalla strana coda. Solo molti anni dopo scoprii che si chiamava Super Constellation, o “Connie” per i patiti del volo.
Questa passione per navi, treni e aerei è rimasta sempre viva in me nonostante abbia fatto più viaggi intorno al mondo, migliaia di decolli, atterraggi, attracchi, imbarchi e sbarchi. Che si trattasse di Kowloon o Bergamo, che avessi viaggiato nel 747 della Lufthansa o sul ponte inferiore della Star Line, l’emozione non è mai calata e il fascino del movimento continua ancora a catturarmi: muoversi per non fermarsi, per conoscere, per vedere, per rivedere, gli occhi sempre spalancati come il bimbo curioso di allora. Da qualche parte in casa conservo un chiodo dei binari della Union Pacific e uno della Santa Fe raccolti negli Stati Uniti a fianco di vecchie linee dismesse. Ho imparato a pilotare un aeroplano, ho condotto barche di ogni tipo (anche una nave passeggeri tanti anni fa) ma non mi hanno mai lasciato guidare un treno.
Quante volte ho aperto gli occhi nel cuore della notte (la mia notte o la loro?) in una poltrona d’aeroplano chiedendomi: dove sono? ma specialmente: dove vado? Sale di attesa rumorose, salette VIP dall’aria rarefatta. file accaldate e disordinate a Nuova Delhi, volo cancellato ad Anchorage, atterraggio per emergenza motore a Orlando (peccato: il film era bello ma ci hanno fatti scendere), champagne vietato sulla Pakistan, troppo champagne sulla Lufthansa, panino sulla Easyjet, gallette e facce stantie sull’Alitalia.
Viaggiare tanto è come scaricare il contachilometri dell’automobile: perdi fino a un anno per ogni viaggio che fai. Parti che ne hai 50 e torni che ne hai 49 e sei più curioso di prima. Vivi in una dimensione parallela fatta di corse di decollo e permanenze a 12 km di altezza e a meno 50° C di temperatura, ibernato per ore e scongelato quando arrivi.
“Signori buongiorno, siamo atterrati a Mumbai, la temperatura è di 38 gradi”. Bene, ora si va a lavorare e a girare tutto il giorno come una dinamo per guadagnarci finalmente una bella birra Kingfisher imperlata di condensa alle 18:00. Ma è vita questa? Sissignore, questa è vita!