
Ott 28, 2009 | The Blog

Abu ‘abd-Allah Muhammad XII, ultimo sultano di Granada, fu costretto ad abbandonare la città nel Gennaio 1492 dopo che i Reali di Castiglia l’avevano cinta d’assedio da mesi. Cadeva così l’ultimo bastione islamico in Spagna. La Reconquista della Penisola Iberica si concludeva dopo ben 700 anni.
Mentre con la sua corte si allontanava dalla città diretto alla costa, il trentenne Muhammad si sarebbe voltato per l’ultima volta a guardare le mura dell’Alhambra, sulle quali già sventolavano le bandiere dei Reali di Spagna.
La leggenda dice che egli abbia pianto per aver perduto “il più bell’oggetto del mondo”, cioè la sua medina, quella splendida cittadella in pietra rossa che dominava Granada.
Secondo la stessa leggenda, sua madre, sicuramente un bel sergente maggiore, lo avrebbe schernito: “piangi come una donna quello che non sei stato capace di difendere come uomo”.
La località in cui tutto ciò sarebbe avvenuto oltre 500 anni fa si chiama ancora Suspiro del Moro ed è un valico a quota 860 m posto lungo quei 70 km di strada che separano la città di Granada dal mare.
Il bello è che tutto questo l’ho solo scoperto dopo essermi goduto in moto quella strada stupenda, stretta e tortuosa che dalla città andalusa si snoda fino al mare, offrendo panorami spettacolari quelle rare volte che si riesce ad alzare l’occhio dall’asfalto.
Il nome del passo mi aveva incuriosito e una rapida ricerca in Internet ha soddisfatto la mia voglia di sapere.
Che siate o meno appassionati di storia, se capitate da quelle parti non mancate di percorrere la A4050 tra Almuñécar (sulla costa) e Granada.
Se appunto fate la strada a salire, arrivati al Puerto del Suspiro del Moro saprete di essere quasi arrivati a Granada. Dalla strada ormai l’Alhambra non si vede più, ma se andate all’ultimo piano dell’Hotel Ibis e non c’è di mezzo un Media World o un McDonald’s, forse riuscirete ancora a scorgere un angolo di quelle torri rosse come le vide il Sultano in lacrime.

Ott 18, 2009 | The Blog
 Aeroporto di Karachi. Sto partendo per Lahore, capitale del Punjab e seconda città del Pakistan con 7 milioni di abitanti. Fatto il check-in del bagaglio mi resta solo una valigetta 24-ore ma l’inserviente dedicato alla Business Class della Pakistan International insiste per togliermela di mano e accompagnarmi alla saletta dove attenderò l’imbarco del volo. Nel resto del mondo ci sono i cartelli con scritto “Lounge” e basta seguirli per lasciarsi alle spalle il viavai e il frastuono degli aeroporti. Qui a Karachi, invece, un signore dall’aria solenne e dai baffoni che ricordano un sergente maggiore del Raj britannico vuole a tutti i costi farmi da scorta.
Aeroporto di Karachi. Sto partendo per Lahore, capitale del Punjab e seconda città del Pakistan con 7 milioni di abitanti. Fatto il check-in del bagaglio mi resta solo una valigetta 24-ore ma l’inserviente dedicato alla Business Class della Pakistan International insiste per togliermela di mano e accompagnarmi alla saletta dove attenderò l’imbarco del volo. Nel resto del mondo ci sono i cartelli con scritto “Lounge” e basta seguirli per lasciarsi alle spalle il viavai e il frastuono degli aeroporti. Qui a Karachi, invece, un signore dall’aria solenne e dai baffoni che ricordano un sergente maggiore del Raj britannico vuole a tutti i costi farmi da scorta.

Il Forte di Lahore
Arrivo all’aeroporto Allama Iqbal di Lahore e ad accogliermi all’esterno ci sono un gradevole caldo secco e una piccola jeep Suzuki Santana con un mitragliatore montato sul tetto. Lahore è una città di frontiera e ha una storia abbastanza turbolenta. Ma ormai le armi automatiche sono in bella mostra in tutti gli aeroporti del mondo e nessuno ci fa più caso.
L’indomani si parte in auto per Sargodha lungo l’autostrada che va a Islamabad. L’ultima ora del viaggio la passiamo su una stradina stretta che attraversa campagne e piccoli villaggi. Il giovanotto al volante la percorre al doppio della velocità che terrei su una strada del genere. Vecchie corriere, biciclette, carretti, animali, adulti e bambini attraversano la striscia di asfalto davanti a noi.  Un paio di volte l’autista è costretto a buttarsi fuori strada per evitare qualche ostacolo, ma il piede sul gas rimane pigiato.
Un paio di volte l’autista è costretto a buttarsi fuori strada per evitare qualche ostacolo, ma il piede sul gas rimane pigiato.
Mi domando se esista una causa degna per morire a Sargodha, Pakistan. Concludo che la mia missione di affari non giustifica un sacrificio umano, di sicuro non il mio.
Entriamo in città e mi sembra di entrare nel caos coreografato del set di un film. Sargodha ha una doppia vocazione. E’ un importante centro agricolo ma ospita anche numerose piccole aziende manifatturiere. In realtà, la maggior parte dei miei clienti in Pakistan è concentrata qui.
Le strade sono asfaltate ma coperte di di terra, il traffico è fatto di motorette scoppiettanti, biciclette e furgoncini che si litigano la carreggiata con i pedoni. C’è perfino una strada intera dedicata al commercio di biciclette e relativi accessori.

Downtown Sargodha, Punjab
Nella piccola fabbrica di interruttori di un cliente, le presse (rigorosamente manuali) per i componenti in plastica sono al piano rialzato. Al piano terra è legata una capretta e, al suo fianco, ci sono dei bambini seduti per terra che assemblano dei pezzi contenuti in vassoi di vimini. L’aria è densa di odori di frutta marcia, polvere e mosche. E anche la capretta ci mette del suo.
Improvvisamente, la saletta fresca e tranquilla della Pakistan Airlines mi sembra lontana mille anni. Vorrei essere lì, con una birra gelata in mano e vorrei togliermi dalla testa l’immagine di quei bambini silenziosi che lavorano assorti a montare i loro interruttori elettrici.


Ott 10, 2009 | The Blog

Il sarto personale del Colonnello Muammar al-Qadafi, Leader Fraterno e Guida della Rivoluzione libica, ha un diavolo per capello mentre solleva il lembo della tenda ed esce all’aperto.
Oggi tira un vento freddo che viene da Nord, ma almeno non c’è sabbia nell’aria, solo una luce accecante.
Amir il sarto si avvia verso la sua Toyota Corolla malandata (che senso ha in Libia far riparare le ammaccature?) e carica nel portabagagli gli abiti che ha fatto provare al colonnello.
“Mi sono ridotto proprio male – dice fra i denti – ero un vero sarto e facevo abiti che la Tripoli bene si litigava. Mio padre, che mi ha insegnato il mestiere, aveva aperto una sartoria vicino a quella che oggi è la Piazza Verde e faceva abiti per tutti i gerarchi italiani.”
“Chi mi invidia per la mia frequentazione del Leader non sa che adesso mi tocca cucirgli delle porcherie come questa”, dice mentre piega una strana uniforme a metà tra Hermann Goering e il domatore del Circo Orfei. “O questa…”, una tonaca viola cangiante da predicatore nero in Alabama. Amir sbatte il cofano e un lembo del cellofan protettivo rimane fuori, come una bandierina.
Le buste di plastica sono la vera bandiera della Libia e le vedi sventolare a brandelli impigliate nei fili spinati per centinaia di chilometri lungo la litoranea che porta a Bengasi. Ma Amir non ha tempo per riflettere sullo stato delle strade libiche. Entro domani, insh’allah, deve finire le ultime variazioni per questi due costumi da pagliaccio.
Oggi ci ha messo tre ore per farli provare al Leader, con lui che ciondola di qua e di là puzzando di whisky e quelle zoccole delle sue Amazzoni che frugano nella borsa del sarto. Gli hanno perfino sequestrato le forbici. “Ma dico io, le forbici! – si lamenta Amir mentre il traffico di Tripoli lo ingoia – adesso mi metto ad ammazzare il Leader con un paio di forbici…”
“Due ore circondato da quelle capre esaltate prima di riavere l’uso della mia borsa. Addestrate in Serbia! Gli avessero almeno insegnato a lavarsi le ascelle, c’era da svenire.”
La Toyota svicola nel traffico caotico di utilitarie e furgoncini diretta al quartiere di Gargaresh dove Amir ha il suo atelier, ma il povero sarto non ha finito di lamentarsi.
“E adesso Lui mi chiede di fargli anche una bandana entro domattina. Una bandana! Ma quando mai si è visto un capo di stato con in testa la bandana?”

Set 26, 2009 | The Blog, The Blog

Il mio volo per Karachi arriva alle 5:00 del mattino. L’umidità invade l’aeroplano appena si apre il portellone: è un’aria opprimente, calda e fetida—e manca ancora più di un’ora all’alba.
Dopo ore a rigirarmi in un sedile d’aereo, entro barcollando nel terminal, dove già regna una confusione indescrivibile.
Vedo un groviglio di gente febbrilmente indaffarata ad aprire pacchi e valigie davanti ai doganieri, vedo gli sguardi avviliti di chi dovrà pagare delle somme ingenti per aver fatto spese al di là dell’Oceano Indiano, negli Emirati, dove migliaia di Pakistani lavorano in condizioni di quasi schiavitù e portano con sé detersivi, frullatori, radio e giocattoli a ogni ritorno a casa.
Benedico l’idea di aver raccolto tutti i miei effetti personali in una borsa portabiti e in una valigetta tipo pilotina. Ora non devo correre ai nastri del bagaglio in mezzo a quell’orda accaldata e aspettare un’altra ora in questo bagno di folla e di rumore. Tutto quello che voglio ora è una doccia e un cambio di abiti.
Con la mia faccia occidentale e il bagaglio minimalista che porto, passo inosservato sotto il naso dei doganieri arcigni ed esco nella zona arrivi. Mi aspetta un muro vociante di mille persone che agitano biglietti con nomi scritti sopra, mi offrono un taxi, cambio valuta o un semplice “can I help you, sir?”
L’ho già detto, ora voglio solo una doccia e, se mi riesce, chiudere gli occhi per un’ora.
In questo groviglio di umanità, riesco a intravedere il mio rappresentante in Pakistan, si chiama Akhber, è alto e magro, dal naso aquilino e l’età indefinita. “Welcome to Pakistan, my friend”, intona con la cadenza cantilenante del Subcontinente Indiano.
Saliamo in macchina, un calesse di fabbricazione giapponese che ha visto tanto sole e sale e un tempo aveva perfino un colore. L’auto fa lo slalom tra le buche e i ciclisti e si immette in un viale immenso dove un fiume di veicoli scorre verso la città in nuvole di fumo, mentre un sole anemico si annuncia dietro la foschia e lo smog come un pallido uovo al tegame.
Akhber è andato in pensione dall’aviazione militare, dove era un ufficiale superiore, ma entrare in casa sua mi stringe ogni volta il cuore. Lo spazio ridotto e lo squallore mi mettono una tristezza infinita, o forse sono solo stanco.

“La nostra riunione è anticipata alle 8:00, mi dice Akhber, ma abbiamo tempo per un caffè”. (Addio doccia). Mentre rovista nella cucina alla ricerca del barattolo di Nescafè, estraggo dal mio bagaglio una bottiglia di whisky etichetta nera, quello che piace a lui e che in un paese islamico come il Pakistan si trova con difficoltà. L’ho contrabbandato con successo anche questa volta; in dogana sarebbero stati guai se mi avessero scoperto: la bottiglia ora farebbe la sua degna figura in casa di qualche doganiere.
“Akhber, questa è per te” gli dico e vedo un sorriso riempire di mille grinze la sua faccia lunga e ossuta, come le crepe in una vetrata centrata da un sasso.

Ago 9, 2009 | The Blog

Grazie alla rotta polare, il volo speciale della World Airways riesce a fare Monaco-Anchorage senza scali. Anche se l’aereo è un gigantesco 747, in turistica il viaggio è scomodo ed eterno; arriviamo malconci e sbandati per la differenza di fusi orari.
Giusto il tempo di noleggiare un’auto in aeroporto e cercare un motel per buttarsi sul letto a pelle di leone sperando di dormire.
Giusto il tempo per rendersi anche conto che in Alaska i prezzi di tutto sono più cari che nei Lower 48, come vengono chiamati il resto degli Stati Uniti continentali.
In Alaska si respira ancora aria di frontiera, quello spirito pionieristico che spinge l’uomo a insediarsi in luoghi dal clima ostile. Curiosamente, l’Alaska conserva ancora nella composizione della sua popolazione un retaggio dei tempi eroici: ci sono più uomini che donne e questo distacco è il più alto degli USA. La seguono in classifica stati poco urbanizzati come Nevada, Colorado, Wyoming, Utah, Idaho e, a sorpresa, Hawaii.

Palmer, Alaska, sulla Highway 1
La gente è cordiale ma sbrigativa. Non si tratta della fretta e della proverbiale ruvidità degli abitanti della Grande Mela e anche la cordialità è diversa, per esempio, dalle maniere impeccabili e un poco retrò del Sud degli Stati Uniti.
Gli abitanti dell’Alaska sono uniti dalla solidarietà innata di chi vive in un ambiente duro e poco accogliente. Quanto all’uso del tempo, finché fa bello, meglio utilizzarlo al massimo e senza sprechi.
Siamo in Agosto e la stagione turistica volge al termine. La Golden Rule di chi visita l’Alaska è prepararsi a trovare il tempo più freddo di una stagione rispetto a quanto indichi il calendario (primavera o autunno se si va in estate, inverno se si va in primavera o in autunno).
 Ieri il Monte McKinley era coperto dalle nuvole. Con i suoi 6.194 metri la “Grande Montagna” (o Denali nella lingua dei nativi) ha un suo microclima e a volte la sua cima resta nascosta per giorni.
Ieri il Monte McKinley era coperto dalle nuvole. Con i suoi 6.194 metri la “Grande Montagna” (o Denali nella lingua dei nativi) ha un suo microclima e a volte la sua cima resta nascosta per giorni.
Oggi però c’è una giornata splendida e la montagna si vede chiaramente, stagliata contro il blu del cielo.
Arriviamo a Talkeetna, un villaggio di 500 anime al confine meridionale del Denali National Park da cui partono tutte le spedizioni per il McKinley. All’aeroporto ci dirigiamo verso l’hangar di Hudson Air Service, una ditta familiare di lavoro aereo che organizza voli turistici e di supporto ai campi base degli alpinisti.
 Il volo durerà un’ora e ci porterà intorno alla montagna e attraverso la Great Gorge del Ghiacciaio Ruth. Non potremo sorvolare la cima, perché il piccolo monomotore Cessna non è pressurizzato, ma il giro ci farà ammirare la bellezza di questo monte e dell’immenso parco naturale che lo circonda.
Il volo durerà un’ora e ci porterà intorno alla montagna e attraverso la Great Gorge del Ghiacciaio Ruth. Non potremo sorvolare la cima, perché il piccolo monomotore Cessna non è pressurizzato, ma il giro ci farà ammirare la bellezza di questo monte e dell’immenso parco naturale che lo circonda.
Scendiamo dall’aereo galvanizzati dall’incontro ravvicinato con questo colosso silenzioso. Ma la splendida giornata di sole non deve ingannare, Denali è una montagna che ha le sue regole e chi non le rispetta muore. Gli abitanti dell’Alaska lo sanno e hanno un rapporto sano con il territorio aspro che li ospita e con il tempo spesso inclemente.
 Il nostro pilota, un tizio che atterra sui ghiacciai ma non se la tira per niente, ci saluta. Avete indovinato: cordiale ma sbrigativo.
Il nostro pilota, un tizio che atterra sui ghiacciai ma non se la tira per niente, ci saluta. Avete indovinato: cordiale ma sbrigativo.
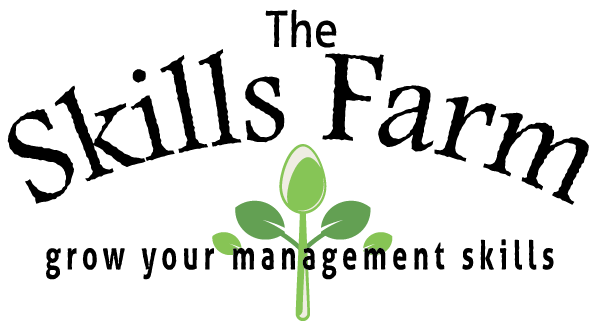

 Aeroporto di Karachi. Sto partendo per Lahore, capitale del Punjab e seconda città del Pakistan con 7 milioni di abitanti. Fatto il check-in del bagaglio mi resta solo una valigetta 24-ore ma l’inserviente dedicato alla Business Class della Pakistan International insiste per togliermela di mano e accompagnarmi alla saletta dove attenderò l’imbarco del volo. Nel resto del mondo ci sono i cartelli con scritto “Lounge” e basta seguirli per lasciarsi alle spalle il viavai e il frastuono degli aeroporti. Qui a Karachi, invece, un signore dall’aria solenne e dai baffoni che ricordano un sergente maggiore del Raj britannico vuole a tutti i costi farmi da scorta.
Aeroporto di Karachi. Sto partendo per Lahore, capitale del Punjab e seconda città del Pakistan con 7 milioni di abitanti. Fatto il check-in del bagaglio mi resta solo una valigetta 24-ore ma l’inserviente dedicato alla Business Class della Pakistan International insiste per togliermela di mano e accompagnarmi alla saletta dove attenderò l’imbarco del volo. Nel resto del mondo ci sono i cartelli con scritto “Lounge” e basta seguirli per lasciarsi alle spalle il viavai e il frastuono degli aeroporti. Qui a Karachi, invece, un signore dall’aria solenne e dai baffoni che ricordano un sergente maggiore del Raj britannico vuole a tutti i costi farmi da scorta.
 Un paio di volte l’autista è costretto a buttarsi fuori strada per evitare qualche ostacolo, ma il piede sul gas rimane pigiato.
Un paio di volte l’autista è costretto a buttarsi fuori strada per evitare qualche ostacolo, ma il piede sul gas rimane pigiato.









 Ieri il Monte McKinley era coperto dalle nuvole. Con i suoi 6.194 metri la “Grande Montagna” (o Denali nella lingua dei nativi) ha un suo microclima e a volte la sua cima resta nascosta per giorni.
Ieri il Monte McKinley era coperto dalle nuvole. Con i suoi 6.194 metri la “Grande Montagna” (o Denali nella lingua dei nativi) ha un suo microclima e a volte la sua cima resta nascosta per giorni. Il volo durerà un’ora e ci porterà intorno alla montagna e attraverso la Great Gorge del Ghiacciaio Ruth. Non potremo sorvolare la cima, perché il piccolo monomotore Cessna non è pressurizzato, ma il giro ci farà ammirare la bellezza di questo monte e dell’immenso parco naturale che lo circonda.
Il volo durerà un’ora e ci porterà intorno alla montagna e attraverso la Great Gorge del Ghiacciaio Ruth. Non potremo sorvolare la cima, perché il piccolo monomotore Cessna non è pressurizzato, ma il giro ci farà ammirare la bellezza di questo monte e dell’immenso parco naturale che lo circonda. Il nostro pilota, un tizio che atterra sui ghiacciai ma non se la tira per niente, ci saluta. Avete indovinato: cordiale ma sbrigativo.
Il nostro pilota, un tizio che atterra sui ghiacciai ma non se la tira per niente, ci saluta. Avete indovinato: cordiale ma sbrigativo.