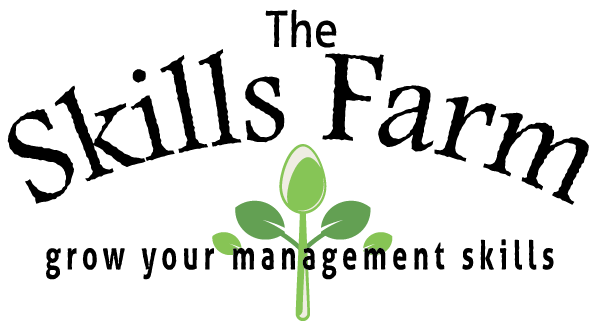Teheran è come un enorme bidone di yoghurt rovesciato sulle pendici dell’Alborz e che scorre fino alla pianura. Tra i suoi quartieri nord e quelli meridionali c’è una differenza di altitudine di 600 metri e perfino di diversi gradi di temperatura.
La città conta oltre 13 milioni di abitanti, ha un traffico infernale e, pur non essendo propriamente brutta, non è neanche un posto che ti rimane nel cuore a al quale vuoi a tutti i costi tornare.
Se conosci qualcuno il discorso cambia, la gente è aperta e cordiale e ama raccontarti del suo paese.
L’ospitalità iraniana è palpabile. In una riunione, l’ospite è al centro delle attenzioni e non manca mai un piatto ricolmo di frutta e un piattino con forchetta e coltello davanti a lui . Si parla di affari, si discute di prezzi, ma la discussione viene regolarmente interrotta dall’invito a servirsi, a mangiare un po’ di quella frutta bellissima.
E piano piano ti lasci convincere. Nel giro di qualche minuto ti ritrovi a discutere animatamente mentre mangi albicocche o apri quei favolosi pistacchi che sono una delle ricchezze del paese.
E dire che l’arrivo a Teheran prometteva male. Alle 2 del mattino e dopo una spettacolare veduta dall’alto dell’immensa metropoli luccicante, il jet della Lufthansa atterra all’aeroporto di Mehrabad (*).
Il terminal è semideserto e disordinato, l’impressione iniziale è di un bazar che stia per chiudere.
Tra le poche anime che lo occupano, c’è il solito viavai di pupazzi in uniformi militari o paramilitari pieni di sé che sembrano in agitazione, anche se chiaramente non sta succedendo proprio niente.
Non ho ancora il visto di ingresso ma una lettera d’invito. Il visto, mi hanno detto, mi verrà dato in aeroporto. Non ne sono del tutto convinto e già mi vedo salutare l’alba in una sala d’attesa dai vetri sporchi e che puzza di tappeti umidi e fumo di sigarette.
Ma non è così. Sono la seconda persona che dovrà ritirare il suo visto e l’operazione dura pochi minuti. Ormai i passeggeri del mio volo sono già transitati tutti e mi ritrovo a percorrere da solo il salone degli arrivi diretto al controllo passaporti. Mi sembra che le mie scarpe facciano un gran rumore sul pavimento di marmo, ma è solo il silenzio spettrale che è calato sul terminal.
Un giovane addetto all’immigrazione mi guarda con espressione cordiale mentre arrivo allo sportello, controlla rapidamente passaporto e visto, poi alza gli occhi e sorride a trentadue denti dicendo: “Welcome to Iran!”.
Mi aspettavo lo sguardo inquisitorio dei guardiani della rivoluzione o l’atteggiamento scostante di un perfetto ignorante in uniforme e invece, nel cuore della tiepida notte iraniana, in un aeroporto dove le ultime luci si stanno spegnendo, il primo Iraniano che incontro mi accoglie con simpatia.
(*) Qualche mese dopo, a fine 2007, quasi tutti i voli delle compagnie straniere sono stati trasferiti al nuovo Imam Khomeini Airport costruito a 30 km dalla città.